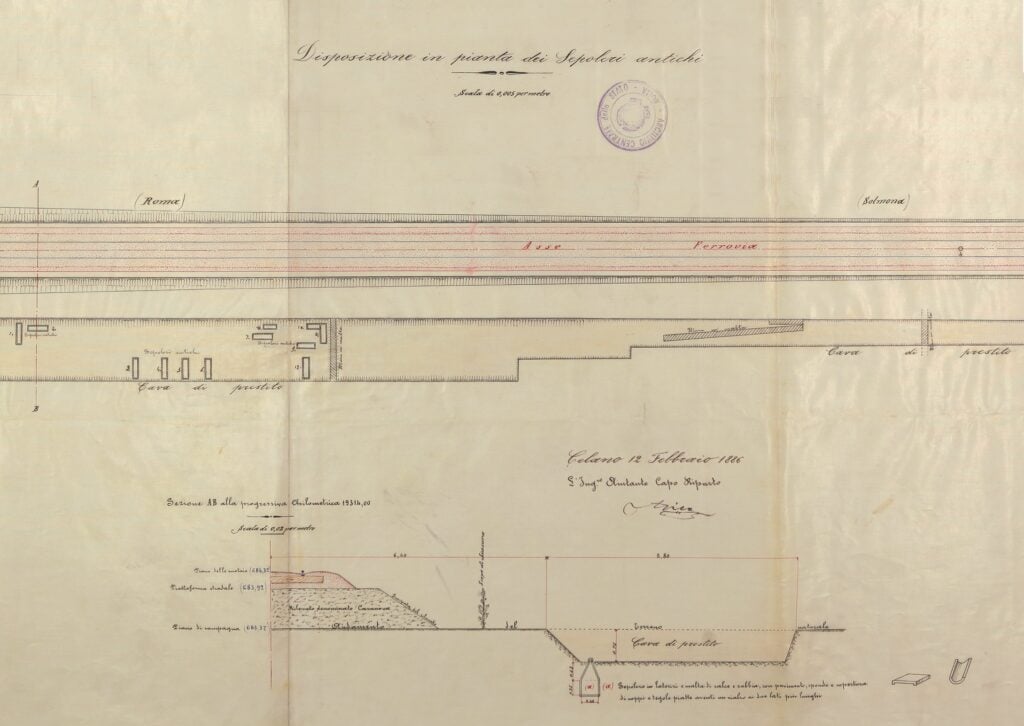“Lunga passeggiata a scopo di studio o di svago; in particolare gita in montagna”. Questa la definizione di ‘escursione’ data dal dizionario (Sabatini Coletti); è quel che promette il titolo: una camminata particolare, fuori dai soliti percorsi, con partenza dalla sommità di Monte Pratëcéllë (quota 911) o, se vogliamo che sia più impegnativa, dalla cima di Prëtara Rosa ( quota 1031); in breve, dalle alture di Arciprete al Rifugio… del Diavolo. Si tratta, è vero, di fare una bella scarpinata: partire quasi dai paraggi di Trasacco e mettere piede in quel che è uno dei nostri parchi nazionali più belli; fu riserva di caccia reale dei Borbone, mi pare di aver sentito dire. Durante il tragitto potremmo avvistare il Lupo appenninico se, come dimostra una foto pubblicata su ‘Terre Marsicane’ spaventatissimo e con la coda fra le gambe, cerca una via di fuga tra le case di Gioia (e si ha paura del lupo?!); potremmo fare l’incontro con l’orso, come avverte la segnaletica stradale alla casa cantoniera di Sperone. A proposito dell’orso trovo interessante riferire quel che mi disse, con naturalezza , nella parlata di Lecce, un anziano pastore, la vita ricca di esperienze, depositario di tradizioni e usanze secolari, se non millenarie ormai scomparse, avviato a quel mestiere, con le pecore della famiglia, fin da quando era bambino, all’età di sei anni ( la massaria fu la sua scuola: imparò lì, da diversi maestri, a leggere e scrivere in stampatello, a far di conto e a fare la firma, felice di poter leggere il Vangelo e la Bibbia, “patulae recubans sub tegmine fagi”, coricato al riparo di un gran faggio, nelle ore più calde del giorno, quando le pecore si abbàfano all’ombra. “ Cë štavë du tipë d’urzë –affermava sereno – ; cë šta l’urzë nërmalë i cë sta l’urzë cavallinë; quištë va ‘mmézzë allë pèquëra i nan cë dicë gnéntë!.”
Io non credo che nel Parco Nazionale d’Abruzzo, che ora ha la denominazione di Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise per essere preservato dalla speculazione e conservato e valorizzato al meglio (turisticamente, intendo), ci siano due specie di orsi e zoologi ed etologi non se ne siano accorti; penso però che nell’affermazione di quel brav’uomo, che aveva vissuto la transumanza per i tratturi, dall’Abruzzo alla Puglia,“ sottë ad acqua i sottë a véntë- chë ‘n’ambrèlla chë pë casa- cë faceva ‘mmérnë i aštatë” ( sotto ogni intemperie, al riparo di un’ombrella, che gli faceva da casa d’inverno e d’estate), che aveva trascorso intere stagioni su queste montagne, visto l’orso gironzolare non lontano dal gregge rivoltando sassi per cibarsi di quel che di edule si trovi lì sotto, ci sia da cogliere un qualche dato di fatto ben noto, e cioè che il nostro orso, l’Ursus arctos marsicanus, fra le sei specie di orsi ascritte al genere, è una razza a sé, non paragonabile minimamente a quel feroce carnivoro che è il lupo il quale quante pecore avvicini tante ne sgozza, solo per berne il sangue, ‘pë bévë sulë lë sanguë’ ; parole che ti facevano rabbrividire di sgomento da ragazzo quando qualcuno, fra i più grandicelli e più informati, pronunciava questa sentenza sui lupi, allora in buon numero qui in Abruzzo. Il nostro orso è fondamentalmente vegetariano; la cronaca dello scorso autunno lo descrive mentre si aggira nei paraggi di Lecce per andare a cibarsi di carote che i pastori, in questa stagione, lasciano sparse a piccoli mucchi proprio nei pressi delle stalle ; allë pèquëra nan ci ha dittë gnéntë; ha preferito far visita ad alcune arnie dislocate nelle vicinanze; ha preso confidenza e ora, ormai di casa, va a dare la buona sera ai pollai adiacenti alle abitazioni. Si dice che, sempre a sera inoltrata, sia andato a finire perfino nella spaziosa e verdeggiante Villa comunale per controllare che sia ben tenuta(?); insomma è fra la popolazione residente di Lecce e c’è da pensare che l’impiegato dell’anagrafe abbia già aggiornato il registro della popolazione ( non è fare dello spirito, l’orso è di casa a Lecce!). Questo sarebbe l’urzë cavallinë; l’orso che invece conduca vita… da orso, che va in letargo, che non si avvicini all’abitato, che si nutre ugualmente di mëlozzëra e përazza (mele e pere selvatiche), lamponi, cicērijjē ( i frutti del biancospino), cornioli, more, cëcëvattë (sorta di tubero di un’ombrellifera) e, in mancanza d’altro, di pasciòla, i semi del faggio, questo sarebbel’urzë nërmalë.
Tornando all’escursione: – Posso capire lo svago, ammesso che possa esserlo un incontro con l’orso – mi potrebbe far notare il lettore- ma lo studio? ( Eppure mi è capitato di incontrare il plantigrado sulla strada che mena al vecchio borgo di Sperone; lui, dico lui sì, perché mi osserva dopo che, disturbato dall’avvicinarsi dell’ auto mentre rovesciava un sasso sul ciglio di quella via sterrata, si scansa, si sposta di un paio metri a valle; io fuori dall’abitacolo, le mani appoggiate allo sportello sinistro semiaperto; per incoscienza o per una sorta di tranquillità che mi deriva dalla certezza di avere il rifugio a portata di mano e come se la siepe che ci separa facesse da barriera, lo guardo; immobili entrambi (mi era noto che bisogna restare fermi in presenza di animali selvatici); il mantello di un marrone chiaro, i piccoli occhi in cui mi sembra di leggere sorpresa disappunto curiosità, mansueti. Quando mi viene in mente di cogliere una tale irripetibile occasione per fotografarlo a ricordo e testimonianza e faccio il gesto di mettere la mano in tasca per tirar fuori il telefonino, si gira a valle, con mia grandissima delusione, e si dilegua mimetizzandosi fra gli sterpi e i tronchi dei faggi; aveva creduto, forse, che volessi estrarre un’arma? A volte vien fatto di pensare che in questa nostra cara amata terra marsicana, sia più di buon senso e saggio l’orso…! (Era il settembre del 2015.)
“Quilë éva l’urzë cavallinë, përché purë j’ lë ‘nquëntrèttë ( incontrai ) quandë pascìva (pascolavo) lë pèquëra a lë Scarajazzë, propria vëcinë addó lë si ’ncontrë tu, ( nei pressi delle ‘ Case di Trivegna’, di cui parleremo in seguito), mi direbbe quel pastore, nato agli inizi dell’altro secolo: voleva vivere fino al duemila ( se lo augurava ed è stato accontentato! ), per vedere se sarebbe avvenuta la fine del mondo.
Lo studio, dicevamo. Ci sarebbe da parlare tanto di zoologia e di botanica e chiederci, per fare qualche esempio, quali luoghi frequenti il lupo cervino come, non ricordo in quale paese del parco, i più anziani chiamano la lince, e in quale zona scavi la tana la spënosa, l’istrice, di cui qualche guardia forestale sostiene l’esistenza della quale, anche a distanza di anni, potrei dare conferma se mia zia Lorenza mi avesse detto che quell’aculeo d’istrice che toccai con mano in casa sua nei primi anni quaranta del secolo scorso era stato trovato dalle nostre parti; potremmo chiederci se la stazione di giaggiolo che attira l’attenzione sulla strada statale Marsicana, lungo tutta la curva di Femmëna Morta quella, per intenderci, che sovrasta la Castëlluccia, sia formata da esemplari classificabili nell’ Iris marsica, nova species, scoperta dai botanici Maretta Colasante e Ignazio Ricci ( Ricci, I., Colasante, M., Istitutodi Botanica dell’Università di Roma, Estratto dagli annali di botanica, Vol xxxii, 1973, Roma 1974)
Ma né di botanica né di zoologia, che pure costituirebbero argomenti arcinteressanti, parleremo durante l’escursione; materie che potrebbero indurci a ricordare gli esami di maturità e a farci sognare di nuovo di essere di fronte ad una commissione d’esami che ci interroga e noi, sempre in sogno, a protestare: “ Ma se gli esami li ho fatti già, e superati! (Chi non ha mai sognato gli esami di maturità, quelli di una volta, quando dovevi portare tutte le materie del triennio?) Tranquilli! Il nostro studio consiste in un pacato discorrere sulle località che attraverseremo o che si affacceranno alla nostra vista durante la camminata fino a destinazione; nel conoscerne il nome e nel constatare che corrisponde al vero l’affermazione degli antichi: “nomina sunt consequentia rerum”, anche se mi è capitato di leggere: “ […] Da un lato sta la “cosa ”che, a rigore, non può essere nominata: dall’altra il “nome.”, e fra loro si apre un abisso incolmabile. […] I nomi non sono consequentia rerum, ma, al contrario, le cose sono le conseguenze dei loro nomi”.[1]
Quando saremo arrivati, non lontano dalla meta, alle case di Trëvegna, e ci saremo ristorati, seduti ai bordi di quella vasca, realizzata con lastre di pietra incastrate ad arte, colma d’acqua che sgorga dalla grande roccia , constateremo l’ ineccepibilità della massima. Ispirandoci e avendo per guida la monumentale opera “Le Origini della Cultura Europea” di Giovanni Semerano, ( il mio dizionario accadico, dal quale riprendo tutti i termini in questa lingua) risaliremo all’origine dei nomi delle nostre Terre.
Sì, lo so; so che il mondo accademico, con significative eccezioni, per la verità, storce il naso; ma che storcere, allora, si potrebbe chiedere al mondo accademico, nel leggere le versioni apportate alla favola della pecora, scritta in indoeuropeo, ricostruito dal grande comparatista August Schleicher, favola che inizia: “avis akvasas ka”, quando in luogo di avis, si suppone *owis, e dopo invece di * ovis si suppone H3ewis e in luogo di varna (lana) si suppone włna e poi la lana diventa wł2neH2 , e poi…, per fermarci qui? Su andiamo, volenteroso escursionista; i Latini chiamavano otium quel che ci aspetta.
Figuriamoci di fare la passeggiata al tempo in cui c’era il lago, perché diversi nomi lo riguardano, e di muovere i passi nei giorni del solstizio d’estate poiché la propizia stagione ci riserva delle sorprese. Prima, però, debbo chiarire il motivo per cui, nel titolo, ho scritto ARCHIPII.
Ho sottocchio il trattatello del Mommsen Sul bronzo di Rapino. Ecco cosa vi si legge: “ [ …] Da’ popoli sabini e sabelli ( è da tener presente che gli storici moderni fanno discendere i Marsi dai Sabelli, e questi dai Sabini il cui più antico luogo d’origine, secondo Catone, fu Testrina,[2] vicina ad Amiterno; l’osservazione è mia) non fù (sic) usata la lettera E, ma sempre II ” ( Mommsen, T., “Sul bronzo di Rapino”, ora nel museo reale di Berlino, e le altre iscrizioni in dialetto marso, OSSERVAZIONI, Estratto dagli annali del’Istituto di corrispondenza archeologica Vol.XVIII, ROMA 1846 p.14). “Nel paese de’ Marsi e Marrucini finora E e F non si sono trovate nelle iscrizioni antichissime.” “Sono costanti le figure di II=E, I’=F, già notissime per le iscrizioni latine.” Il celebre storico riporta, a testimonianza, questa “ iscrizione di cippo quadrangolare che sembrò porzione di erma, copiata a S. Benedetto sulla sponda orientale del Fucino ( l’antico Marruvium Marsorum)” : NOVIISIIDII –PIISCO.PACRII [3] – novesede pesco pacre (ivi, p.25 ), “che sembra lapide votiva consegrata (sic) a qualche divinità”, e osserva: “ […] Ai dialetti patrj non si mise termine prima della guerra sociale, la quale gli trasse tutti in rovina: e allora addivenne che il latino estese il suo dominio sopra tutta l’Italia”. Considerato lo scopo di questo articolo, prendo a prestito l’affermazione del grande storico, per sottolineare ex Oriente lux! e poiché anche la civiltà, come la luce, viene dall’Oriente, e con le conquiste di Sargon, che estese i confini del suo impero fino alle sponde del Mediterraneo l’ idioma di Accad si diffuse in tutto il bacino, arrivò all’Atlantico, per le vie dell’ambra raggiunse le rive del Baltico dove abbondava la preziosissima resina, fu lingua internazionale nei rapporti diplomatici fino al al IX sec. a.C., ‘addivenne che l’accadico estese la sua influenza su tutta l’Europa’.
Scrivere ARCHIPPII ci riporta indietro nel tempo, al IV sec. a.C., quando i Marsi non avevano ancora fatto proprio l’alfabeto dei Latini i quali ( riprendo sempre dal Bronzo) “ […] dissero ocrem montem confragosum (aspro,dirupato); a cui convengono molto bene i nomi di Interocrea nella Sabina e Ocriculi nell’Umbria, essendo la città di Otricoli posta sopra erta collina”. “[…] Altro paese detto Ocre nel contado di Aquila. E’ stata paragonata quella parola (Ocre) col greco akros, ‘alto’, e rettamente ( ivi pp. 16,17)”. Fin qui il Mommsen, citato non linearmente ma con scrupolo, perché si presti al nostro caso. Mi preme far notare che il greco akros e quindi Ocre, e l’umbro Ocris, di cui alle tavole eugubine, è forma metatetica di accadico arku,’alto fortificato’. A noi, dico noi perché in questo momento sto coinvolgendo nella ‘conversazione’ il lettore originario di queste Terre che ben conosce, viene spontaneo associare al ‘paese detto Ocre nel contado di Aquila’, nominato dal grande storico, il casale di Arciprete giacché in questo termine, nella sua prima parte, scorgiamo: accadico arku con l’occlusiva velare sorda k mutata in affricata prepalatale sorda c, e la vocale posteriore di massima chiusura u mutata in vocale anteriore di massima chiusura i. Ciò detto su arci, ( viene in mente Arce, il paese del vicino Frusinate ) e su arku, torniamo al nostroArchippe, nella cui seconda parte è chiara l’origine: accadico appu ‘cima, vetta’. Fra l’imponente serie di oppidi, una cinquantina, riscoperti o scoperti ex novo dall’Archeoclub Marsicano, ( Cesare Letta, in Fucino cento anni, p.110 ) due meritano la nostra attenzione: quello sul Monte Pratëcéllë ( abbiamo visto all’inizio a quota 911), a E di Arciprete, sopra il vicus in località Santë Mannë e quello su Prëtara Rosa ( quota 1030), presso il Monte Mèria, sulla strada antica tra i vici di Arciprete e di Spineto. ( ivi p.113) Il nome di Arciprete, da accadico arku alto, nella sua prima parte, e da accadico birtu borgo, nella seconda parte (un ‘prete’, per di più arci cioè di grado superiore ad altri nella stessa parrocchia, ad Arciprete quanto avrebbe da fare?); prete da accadico birtu p<b, per metatesi intermedia e vocale anteriore aperta ‘e’ da vocale di massima chiusura ‘i’, induce a sostenere che Archippe sia da identificare in uno di questi due oppidi (rassegniamoci! ‘quelli di Archippe’; ci sarà stata un’epoca in cui l’isola di Ortucchio fu completamente sommersa dall’acqua; e poi, cari ‘Amici di Archippe’, diciamoci la verità: il vostro laborioso paese ha avuto mai le caratteristiche di una rocca? ). Propendo a ritenere che Archippe sia da identificare nell’oppido scoperto dagli archeologi sul monte Pratëcéllë poiché lo rilevo dal nome stesso: prat- ‘prete’ < birtu borgo, e accadico ellȗ alto.
Archippe, rocca sulla vetta; questo, dunque, il significato del nome dell’ oppido in alto ad Arciprete. Sennonché leggiamo in Livio che nel 195 a.C., quando era console Lucio Valerio Flacco e comandante delle truppe romane in Peloponneso Tito Quinzio ( Livio, xxxiv,22 ), nella città di Argo, che di rocche ne aveva ben due (Livio, xxxiv 25: ‘nam duas arces habent Argi’ ), pochi valorosi qui in arce erant, guidati da un duce Archippo quodam ( xxxiv, 40 ) scacciarono, expulerunt, il presidio di Spartani i quali avevano occupato la città. Livio non dice altro di di Archippo, scrive solo che era un quidam, ‘un Tizio’. Ora, considerato che ciascuna delle contrade di ogni città ha un proprio nome ( si pensi al Palio di Siena), che il significato di Archippo è quello che abbiamo visto, che Argo stessa è una rocca, arku, potrebbe darsi che Archippo possa essere stato anche, o solo, il nome di una delle due rocche di Argo, dalla quale pochi valorosi al comando di un quidam scacciarono gli Spartani. Un quidam di quelli di tutta la rocca, la rocca stessa.
Comunque stiano le cose, nulla cambia circa l’etimo in questione, che mi spinge ora a liberarmi, finalmente! da un rovello che mi porto da sempre: la traduzione del verso Archippi regis missu, fortissimus Umbro Eneide, VII, 752 ). Dalla classica versione di Annibal Caro: “ De la gente Marrubia un sacerdote – venne fra gli altri; sacerdote insieme- e capitan di genti ardito e forte- Umbrone era il suo nome ; Archippo il rege-che lo mandava; “ Quin et Maruvia venit de gente sacerdos- fronde super galeam et felici comptus oliva- Archippi regis missu fortissimus Umbro; a quella, pure in versi italiani, di Giuseppe Albini: “ E di Marruvia gente sacerdote,- col ramo a l’elmo del benigno ulivo,-per cenno di re Archippo, Umbrone venne- fortissimo.[…] ( Giuseppe Albini, L’Eneide, Traduzione in versi italiani, Bologna, Zanichelli editore,1966) e, credo, fino a tutte le altre versioni, il genitivo ‘regis’ viene considerato apposizione o nome/attributo se, non essendo io latinista e non avendo alcun titolo, intendo correttamente l’esempio di nome/ attributo, ‘Tarquinius rex’, che trovo nel “Commento alla sintassi latina” di Alfredo Ghiselli (Alfredo Ghiselli,Commento alla sintassi latina,Firenze, Valmartina , 1951, p.107.) Starò fuori del coro stonerò sarò in errore(?!), vorrei dire però, almeno ora che non devo temere più gli esami, che se al ginnasio, quando ci si cimentava nel tradurre il poema di Virgilio (anche la versione dell’Annibal aveva bisogno di…traduzione! studiare l’Eneide a quei tempi e su quel testo e imparare a memoria certi episodi, comportava, come l’esempio più sotto mostra e parafrasando il Foscolo nella sua diatriba con il Monti , essere “ traduttore del traduttore… Caro!” ) anziché la traduzione del libro terzo (Virgilio, ENEIDE, libro TERZO, introduzione e commento di EDMONDO V. D’ARBELA, Carlo Signorelli, Milano 1952) ci fosse stata quella del libro settimo, avrei interpretato il verso 752: ‘Archippi regis missu fortissimus Umbro’ : – […] ‘il fortissimo Umbrone, inviato dal re di Archippe; e questo perché partendo a piedi da Lecce per andare Trasacco, a chiedere una grazia (quale?) a san Cesidio, vedevamo alla nostra sinistra Arciprete, dal suono così particolare che, non so per quale motivo, forse per una certa assonanza tra arch- ed arc-, ho sempre associato, venuto il momento degli studi, ad Archippo, o Archippe che dir si voglia; dico inoltre che, essendo iscritto alle liste di leva del distretto di Sulmona, un eventuale verso ‘Sulmonis regis missu’ non lo avrei tradotto ‘inviato dal re Sulmone’ ( nome di uno dei trecento guerrieri della città latina Laurento), ucciso da un dardo scagliato da Niso per salvare il suo amico Eurialo: [(Niso)] il dardo-vibrò di tutta forza. Egli volando-fendé la notte e giunse ove a rincontro-era Sulmone, e l’investì nel tergo-là ’ve pendea la targa ( lo scudo); e ’l ferro e l’asta-passògli al petto, e gli trafisse il core (IX,634-639) [(Nisus)] ferrum-conicit: hasta volans noctis diverberat umbras- et venit adversi in tergum Sulmonis inique- frangitur ac fisso transit praccordia ligno. (Eneide, IX, 410- 414); ma, ribadisco senza esitazione, avrei tradotto : ‘… inviato dal re di Sulmona’; come se avessi avuto a che fare con un verso dal suono ‘Romae regis missu, …’. La sistemazione logica formale del latino! So che nemmeno la grande umanità, mista al rigore, del prof. Punzi dell’ indimenticabile liceo Mamiani, me l’avrebbe fatta passare, la mia traduzione, anche se, da marsicano ( accadico mārē gente e accadico āşû elevato, che si leva in alto, āşi dei monti, montanaro (!). A. Leo Oppenheim, l’antica Mesopotamia-ritratto di una civiltà,newton compton editori,p.315,nota44 avessi insistito caparbiamente nel mio modo di vedere, e domandargli: – E se a Virgilio fosse stato noto, al pari di Marruvium, anche un Archippum, oppidum dei Marsi? Non ci ripeteva lui, l’autorevole Professore, con il Maruzeau, che l’ordine delle parole latine va interpretato? Non ero venuto io a Roma, in quello stimato liceo, verso il quale nutro la più profonda gratitudine, “ Maruvia de gente”? Non avevo giustificazioni se, per me, Archippo era nome di oppido, un oppidum come Roma, prima di diventare caput mundi?
E poi hanno abolito e ridimensionato l’insegnamento del latino! Per non abituare il populum a… porsi domande?!
Ma è ora di metterci in cammino; partiamo di buon mattino, perché il sole presto sarà alto e i raggi picchieranno. Discesi in strada, ci lasciamo alle spalle Arciprete e il vecchio vico di Spineto. Procediamo spediti per la nostra destinazione, lo sguardo attratto, a sinistra, dalla distesa d’acqua che ospita anatre a non finire: riconosciamo germani, alzavole, gallinelle d’acqua, moriglioni; a tratti la riva diventa paludosa; nonostante la livrea mimetica, acquattato nel folto di un canneto, con il becco dritto all’insù, scuro sulla sommità del capo e sulle parti dorsali, riusciamo a individuare un tarabuso, immobile; più avanti uno svasso maggiore, sul suo nido, porta sul dorso un suo piccolo vistosamente mimetico; un airone cenerino va in cerca di rane e qui una biscia d’acqua ha ingollato una rana. Ci avviciniamo per curiosare fra alcune canne e avvertiamo un fruscio d’ali; abbiamo disturbato la cova di una cannaiola , mentre più lontano vediamo mamma folaga portare a zonzo la sua famigliola. Con compiacimento coltiviamo un pensiero: certo il nostro Fucino costituisce un habitat unico; è un mare d’acqua dolce, e che mare!
A circa mezza lega, un tremila passi, da quella piccola isola, Issa, accadico ișu piccolo, che davanti ai nostri occhi appare come una piccola oasi che affiora dall’acqua, ecco un casale; è la Bargacamìna: da sumero accadico barag luogo abitato,borgo, accadico amȗm palude e accadico inu sorgente, fiume, chiaramente con riferimento all’acqua del lago. In tempi remoti forse ci sarà stata qui, come alle Paludi di Celano, una qualche palafitta, stando a quel che suggerisce il nome. Davanti ai nostri occhi, a destra della Bergamina, come la chiamano i pescatori di Issa, l’altorna, la brezza di valle che a quest’ora incomincia a spirare verso le montagne, increspa la superficie del lago, e fa ondeggiare il biondo mare di spighe di solina, il grano adatto a queste terre di montagna. Fra un mese ci sarà la mietitura, tempo di grande fatica ma di grandissima letizia; i manoppri, i covoni, verranno portati all’aia, composti in casarce (biche), in attesa dei giorni più belli, quelli di trëscà con gli asini, muli, cavalli e anche con i lenti buoi, di ventilare all’altorna di monte, quando di sera spira a valle. Gli arconi aspettano di riempirsi di some di grano! Sono le terre di Satrana queste, che menano tanta grascia ; una vera manna più per quei mille abitanti del castello di Lecce, arroccato lassù fra quelle magre pietraie vicino al monte Turchio, che per questi pochi pescatori di Artucchia, avvezzi più alle fatiche della pesca che a quelle dell’aratura.
Ride il cuore ad Angelo del Papa, ad Antonio de Benedictis, Fabritio (sic) Terzone, Salvio di Giov. di Salvio, Lione Cornacchia, Domenico di Salvio, per citare solo alcuni fra i tanti proprietari tutti di Lecce, che posseggono terreni qui a Satrana. [4]
Satrana, da accadico ša quello che ( il luogo che), e accadico, atru preminente, che sovrasta, per fertilità ogni altro terreno; il nome richiama l’antica divinità agreste Saturnus, divinità dell’abbondanza, Satre divinità etrusca della luce, Sataran divinità del pantheon sumero accadico; richiama il latino satur ( pieno, sazio), e si comprende il perché del nome di queste terre, invidiate da coloro che non le posseggono; avere terreni a Satrana significa non sapere cosa è la caraštia!
La via, serpeggiando, in qualche tratto rettilinea, risale un leggero pendio oltre il quale si para alla vista una discreta distesa coltivata a grano e a vigna. Nel silenzio che ci attornia sentiamo provenire un allegro vociare da oltre un vigneto, laggiù in fondo alla piana.
La curiosità ci fa affrettare il passo e, in breve, raggiungiamo un corso d’acqua, il Rio di Lecce. Una numerosa comitiva, costituita da uomini, ragazzi, giovinette, ma soprattutto da donne è sparpagliata sulla riva sinistra; c’è chi ha già guadato il fiume e chi tenta di farlo mantenendosi in equilibrio su di una passerella di fortuna fatta di sassi gettati sommariamente in acqua.
Proviamo anche noi ad attraversare il rio facendo attenzione ad appoggiare bene i piedi su quei sassi che ci sembrano più stabili; quando siamo sull’ultima pietra, con un salto guadagniamo l’altra riva. Attorno ad un’ampia fossa pressoché circolare, ribollente d’acqua sorgiva, che trabocca in un rivolo, si è formato un crocchio; c’è chi è semplicemente affascinato dalle bolle provenienti dal profondo, chi con sbruffi si rinfresca il viso e il capo, chi le braccia, chi fa provvista d’acqua immergendo nella corrente del rivolo un piccolo otre dal pelame che tradisce la sua origine caprina. Ci avviciniamo anche noi al pozzo di Forfëra, questo il nome della fossa da cui sorge l’acqua. Il nome Forfëra richiama lo stretto di mare, paragonabile a un grande fiume, che collega il Mar Nero con il Mar di Marmara, il Bosforo, greco bòsporos. Cosa avrebbero dovuto arare i buoi, greco bous, da cui si fa derivare il termine Bosforo, in quello stretto? Quanti popoli, quante genti migranti, quante greggi, quante milizie hanno varcato quel tratto di mare per passare dall’Asia all’Europa e viceversa! Bòsporos: da accadico būru stagno, accadico bâ’u attraversare col pronome determinativo ša-: letteralmente “ l’attraversamento dello specchio d’acqua”. ( Giovanni Semerano, Dizionario della lingua greca, Firenze, LeoS. Olschki Editore, MCMXC-RistampaMM).
Pozzo di Forfora: pozzo dell’attraversamento, pozzo del guado di fiume, dunque; in Forfora <Bosforo: f<b e r<s. Si entra subito in confidenza con quelli più vicini, come si usa fra conterranei ma soprattutto da queste parti ( non corre un detto ‘Abruzzo forte e gentile?’), e chiediamo da dove viene e dove è diretta tutta questa gente.
-Veniamo da Trasacco e andiamo a san Giovanni di Bisegna, – è l’asciutta risposta di una donna che ha l’aria di guidare la comitiva; poi aggiunge: – Ci andiamo ogni anno, come facevano i nostri padri e prima i nostri nonni e tutti quelli venuti ancora prima, da sempre; e tu di dove sei?- mi chiede. – Sono di Tarotë – è l’altrettanto asciutta mia risposta. – Tarotë? quelle tre case che fra poco incontreremo quando incomincia la salita che poi ci porta a Gioia? Noi passiamo sempre proprio a Tarotë per andare a san Giovanni,- afferma decisa. – Sì, sono due famiglie che hanno lasciato Lecce, lassù vicino a Turchio e sono venute ad abitare qui in basso perché qui è un’altra vita; fa meno freddo, sono più vicini a san Benedetto e a Pescina, dove si fa il mercato, a L’Aquila che è una città, e alle terre più fertili. Pietro d’Ettorre ha sposato Antonia di Giacomo di Sperone;[5] qui in basso col tempo sicuramente scenderà tutto il paese – dico, come se fossi in grado di prevedere il futuro. – Sicuramente succederà così,- s’intromette un uomo sulla cinquantina che dice di essere il marito della donna e di chiamarsi Cesidio.
– Cësì, – chiamo Cesidio alla leccese, – dal momento che facciamo la stessa strada fino al valico di Gioia, quando a sinistra voi prenderete il sentiero che vi porta sulla collina e poi scenderete, passando in mezzo al bosco, alla chiesa di san Giovanni, mentre noi proseguiremo in direzione di zë Péšchië (Pescasseroli), possiamo venire con voi?- “ Come no, è un piacere; siamo paesani!- Ci aggreghiamo quindi alla comitiva e riprendiamo il cammino a fianco di Cësìlë.
La giornata è stupenda, non c’è una nuvola; il sole splende già alto su Sperone; ci abbaglia e con la mano dobbiamo fare capanno agli occhi per guardare quel borgo, con la torre circolare, abbarbicato su quel costone. Questo gesto istintivo per protegger la vista dai raggi del sole levatosi da dietro Sperone, la numerosa e festosa comitiva alla quale ci siamo aggregati, messasi in cammino da occidente, Trasacco l’antico Supinum, verso oriente, Bisegna, ci fa interrogare: – Non è che questo andare a Bisegna, nei giorni del solstiziod’estate, non è altro che, mutatis mutandis, riprendere il culto del dio sole delle genti stanziate nella parte occidentale del lago, nei veci ( pron. marsa di vici) di Supino, santo Manno, Archippe, Spineto?
Fra una chiacchierata con il nostro Cësìlë e un personale vagare sulla religione perveniamo, dopo aver attraversato il letto di un torrente fatto di breccia e ciottoli, al Sorbo di Renzo. Invano, girando lo sguardo all’intorno, cercheremmo una pianta di sorbo, non perché sia un albero a scarsa diffusione, ma perché, e il fatto è veramente sorprendente, il nome della località ci ricorda che abbiamo appena superato una fiumara. In Sorvë dë Rénzë vediamo difatti: accadico šû pron. dim. questo (il luogo), ebar di là, e accadico rehû il riversarsi greco reo (‘scorro, fluisco’) cioè: la località al di là del riversarsi del torrente. Qui, al Sorbo di Renzo Domenico Gargaro possiede un terreno di coppe dodici a confine con la strada e il torrente ‘La Tavana’ ( ecco il riversarsi chiamato con i proprio nome, rehû! ); -zë di Renzo, in posizione anaforica è, ancora, il pron. accadico ša quello che, aramaico zi.
Ci troviamo dunque al Sorbo di Renzo, una località che fa parte della zona di Rëvana dove il torrente Latavana (questo il vero nome) va a disperdersi; rehû riversarsi, spandersi,allargarsi e accadico enu fiume, sorgente. E qui a Rovano confinanto (sic) con Gio: Pallotta, il Dr. Giacomo Tomassetti, la strada e con Santo Manno, cioè la distesa di terreni che l’acqua del torrente non raggiunge, il notaio Gio: Batta Abrami, da Lecce, possiede due appezzamenti di terreni di ventidue e di quattro coppe (Catasto di Lecce del 1704). Santo Manno, come il vicus di ‘s. Manno di cui sopra, ad Arciprete, ( Cesare Lette, ivi, p.113): da accadico ša- an- itû- ma- ēnu quello (il luogo che sta)- al- confine con l’acqua- del fiume.
Il vicus di Santë Mannë di Aeciprete doveva trovarsi non lontano dalla riva del lago o nei pressi di una sorgente, non c’è dubbio.
Il sentiero che abbiamo preso al Pozzo di Forfora, interrotto dal torrente, riprende al Sorbo di Renzo; da qui, diventato stradello pressoché rettilineo e agevole da percorrere, ci porta all’incrocio con la via di Santa Maria, dove c’è una chiesa nota con il nome di ‘La Madonna del Pozzo’, e continua quindi, verso Oriente, in direzione di Manafurnë.
E’ noto che il lago, a seconda delle epoche, ‘fa i capricci’, non ha un livello stabile; di solito l’acqua arriva a Calluco, località più vicina a Santë Vënëzianë che ad Ortucchio; da accadico kallum cima, testa e accadico agû acqua; certe volte deborda ancora più a sud est, verso il Corno, ed ecco quindi formare un acquitrino a Conabella, da accadico qānu territorio accadico abbu pantano e accadico –ellû alto; altre volte avanza ancora di più ed eccolo a l’Aquëlèlla, alla chiesa della Madonna del Pozzo ad allagare, nel 1753, sette coppe di terra del povero Gio:Battista Gargari, quarantaseianni, sartore, moglie e sei figlie femmine più sua madre di settandadue anni, vedova, tutte da campare; già povero di suo, che quando cuce qualcosa lo pagano a grano; quest’anno ci si è messo pure il lago![5]
Alla chiesa della Madonna del Pozzo ci si arriva per la via di Santa Maria, ša an itû ma rehû. Siamo ora a metà percorso, a Colabrittë dirimpetto a Manafurnë. Qui è la via che i residenti tutti intorno al Fucino prendevano per recarsi nel Sannio, come stiamo facendo ora noi con i Transaquani, loro per andare a Bisegna, noi al Diavolo. Qui è la via che prendevano i vicales Anninis per scendere a Marruvio e poi andare a Roma (v.Cesare Letta, ivi, p.135 sgg.). La piana alle falde del monte Panna, tra la cala di Colabritto e Alto le Ripe, ha tutte le caratteristiche di uno stagno; ce ne dà la conferma il nome Manafurnë : da base semitica ebr.mānă sbarrare a difeaa ( Semerano, Diz.lingua lat.sub, moenia) e accadico būrum lago, pozzo, profondità. Colabrittë non fa venire in mente Calabria? L’elemento Cola- da accadico kālû significa riva, diga, confine, la componente –abri, l’ abbiamo visto sopra, “ corrisponde al significato che denota passaggio attraverso un corso d’acqua , uno stretto, un angusto mare: accad. ebēru, epēru, ebar , di là ( Giovanni Semerano, Le origini , p.497); -ittë : accad. itû confine, riva limite.
Incomincia la salita; sarà più faticoso marciare ma più gratificante poiché quando saremo più in alto la vista abbraccerà tutta la distesa del lago: lo sguardo indugerà su Marruvio, Luco, Avezzano, il Velino, sui prati e gli alberi in fiore e gli armenti che, per dirla con il poeta latino Lucrezio, persultant pabula laeta (scorazzano per i prati rigogliosi [ del Parco]). (Lucrezio, De rerum natura, I,14) L’udito si delizierà con il canto delle tante varietà di uccelli.
Incontreremo tanti altri nomi, cioè le località stesse, ma parleremo solo di poche altre perché, ormai, vogliamo arrivare a destinazione.
A Tarote troviamo tre case, dico tre, alla lettera, come abbiamo sentito al Pozzo di Forfora ; una costruzione ha l’aria di stalla perché in un piccolo recinto adiacente razzolano sei sette galline con un gallo e zampariéjja, scalcia, un puledro. Abitano a Tarote solo due famiglie: quella di Pietro d’Ettorra e quella di Antonio di Criscenzo;[5] sono scesi ad abitare qui a Tarote, un promontorio dalla forma rotonda che si protende nella piana sottostante e ai cui piedi scorre il torrente Latavana; da accadico târu giro, e accadico adû acqua nel suo aspetto di onda, acqua di fiume, che qui è al massimo delle piene raccolte nel vallone di Maquërana.
C’è un pozzo nel piccolo spiazzo al centro di questo poggio; quattro ragazzini, quattro: due femminucce dai nomi Gemma e Domenica di nove e dieci anni e due maschietti: Giuseppe di tredici e Domenico di sei anni. Le bambine giocano a vriccia, il gioco degli astragali, con cinque sassolini fra i più rotondi raccolti nel torrente, osservate dal più piccolo; Giuseppe il più grandicello si è arrampicato su ‘në pëzzëcarašë ( un Celtis australis ) che cresce accanto al pozzo, probabilmente per veder quante uova ci siano nel nido, di cardellino, a sentire il canto di un uccellino sul ramo più alto di un olmo al limite della ‘piazza’. Un mastello della capacità di una decina di litri, munito di corda, è posato al fondo di un grande scifo ricavato da un macigno per fare da lavatoio e da abbeveratoio agli animali delle due famiglie e dei viandanti; Giovanni, aitante giovane della nostra comitiva, si premura di calare più volte il mastello nel pozzo per dissetare e rinfrescare l’accaldata compagnia.
Si riparte e adesso la salita si fa impegnativa. Il sentiero tira dritto lasciandosi a sinistra il vallone di Pëdónë che scende al torrente, accadico padānu,[6] suolo, fondo stradale greco pédon, suolo,terra,terreno,campagna; ora, dove non ci sono tante pietre, lo coltiva Sëtaccë, soprannome che in realtà fa riferimento al fatto che la valle scende al torrente ai piedi di Tarotë: ša itû quello al limite e -acce come –uccia di Castelluccio da accadico agû acqua; il ‘vallone’ costituiva, nel passato, il tragitto più agevole che tutti, uomini e animali scelgono, quando si porta un carico.
Dopo circa un tre quarti d’ora di cammino svoltiamo a destra; fatti pochi passi, sentiamo un abbaiar di cani; corrono nella nostra direzione; si arrestano, però, al ciglio del poggio, vedendoci in tanti; non ci tranquillizzano, questi cani pastori abruzzesi. Si distingue, fra loro, un cagnone che ti mette paura solo a guardarlo con un collare di ferro irto di spuntoni; il lupo non potrà mai azzannarlo collo! Esitiamo a proseguire; per nostra fortuna ‘në warzëwacchië, un giovanetto, sui sedici diciassette anni (da accadico wardu š(a) (w)agû: letter. ‘il servo-quello -dell’acqua’, li chiama a sé, avviandosi verso delle casupole adagiate all’inizio di un pendìo dal quale la vista spazia su tutto il lago.[7] Sono le Case di Trivegna. Probabilmente sono qui da tempo immemorabile perché una sorgente poco a monte, sulla strada , un discreto avvallamento verso la montagna in direzione di Sperone adatto alla coltivazione, e i pascoli all’intorno ne hanno fatto un posto ideale per stanziarvisi. Dico a Cesidio, e a un paio di giovani accanto a noi che mi sembrano incuriositi, il perché del nome Trivegna. – Tri,- dico esitante, conscio che il mio parlare suoni loro un po’ strano,- per metatesi è da accadico tīru e significa abitazione; in –egna rivive accadico enu e significa sorgente, fiume e quindi Trivegna vuol dire, esattamente, Case alla sorgente; come in Bis-egna, Visinium, che sorge su di uno sperone che s’innalza dal fiume Giovenco, vuol dire esce dal fiume: da accadico wāşû emergente, che si leva ed enu fiume, sorgente. Questo posto viene chiamato anche Maria Štella; tutti pensano che sia esistita chissà in che epoca, una Maria Stella padrona o chissà che, forse štrejja (strega) di queste case. None! Maria Štélla vuol dire: acqua quella che scorre in alto: ma- rehû-ša- ellû, e il nome fa riferimento proprio alla fonte che viene chiamata anche la Fonte della Signora, dove non vediamo l’ora di arrivare.-
Ci arriviamo, ci arriviamo…
La sorgente sgorga da un’apertura nella roccia; eccolo lì, lë Wawwëzë [8] dë lë Monnëchë, (accad. mû ‘acque’, e accad. iku, ‘diga, canale’), il gigantesco masso, alla svolta per Gioia; quando i raggi del sole gli cadono a piombo spicca di bianco anche da lontano: da Ortucchio da Venere, da San Benedetto, e forse anche da Avezzano, per chi ha una vista acuta.
L’acqua scaturisce da una fenditura: incanalata in un corto spezzone di pietra scavato mo’ di cannotto, riempie una lunga vasca, lunga perché serva da abbeveratoio alle greggi. Un boscaiolo di Gioia scende al piano, al suo casale di Manafurnë, e aspetta che il mulo carico tàccarë , legna da ardere, finisca di bere, mentre la fonte viene presa d’assalto dall’assetata comitiva. Nella grande confusione si alza una voce di ragazzo:- Guardate, guardate! una lucertola che cammina in mezzo all’acqua!- Pensiamo che avrà visto qualche lucertola caduta nella vasca, affogata. Ci avviciniamo e alcuni ragazzi che osservano sorpresi le lucertole nuotare al fondo , si fanno un po’ da parte per consentici di vedere. In effetti notiamo che si muovono al fondo un paio di esserini, sembrano lucertole; una, però, ha una cresta sul dorso, cosa mai vista in questi piccoli simpatici rettili ; nuotano nella vasca dei tritoni; meraviglia anche noi vederli quassù, tanto in alto. E’ la stagione della riproduzione e sono corsi all’acqua.
Rinfrescatasi e dissetatasi la compagnia, al segnale della ‘capo banda’, così viene chiamata affettuosamente l’organizzatrice della visita al santuario di San Giovanni, riprendiamo il cammino; Cesidio mi si affianca e mi fa con aria che sembra abbia rimuginato a lungo: – Paisà, com’è quella cosa che dici di Trëvégna? me la vuoi ripetere?” Ha l’aria sorniona, Cësìlë, mi sembra che voglia dire lui qualcosa a me; però mi ha fatto una domanda ed è cortesia rispondere; gli ripeto volentieri: – Vedi, Cësì, Trivegna è una parola, anzi due, che vengono da molto lontano; una: tiru vuol dire abitazione, casa, come ho già detto, la seconda –egna, enu vuol dire sorgente, fiume. Tutta l’espressione Case di Trivegna sta a significare che la massaria sta vicina alla fontana che abbiamo appena lasciata. Anzi, mo’ ti dico di più: la via che stiamo calpestando è stata ed è molto importante; questa è via di passaggio obbligato per tutti quelli che stanno nei paesi intorno al Fucino e che debbono recarsi in Molise e in Puglia; per di qui sono passati anche i soldati romani quando facevano la guerra ai Sanniti. Per dire che queste case stanno prima della sorgente, i Romani avrebbero detto e direbbero, se volessero parlare ancora latino, prae, che vuol dire davanti, innanzi; Cësì,- proseguo nel mio dialetto che comprende benissimo- mo’ nan të pënza’ ca jë vojjë fa’ lë bravë chë ti, però devo finire il pensiero: il latino prae, come il greco par, pará, perì è come la parola beri accanto, vicino di un’antica lingua che si parlava dove si dice che c’era la torre di Babele. Aggiungo, te lo ripeto ancora, non credere che io voglia fare sempre il bravo: però qui devo ricordare che la storica grammatica greca di Lorenzo Rocci dice che le lettere p b f si chiamano labiali e che, ma ne abbiamo già parlato al pozzo di Forfora, spesso una prende il posto dell’altra, cioè: f diventa b, o anche p, e viceversa.
Cesidio, nonostante il mio parlare un po’ ‘ricercato’, non mi pare annoiato e mi fa un sorrisetto, di cortesia, forse perché ho parlato un po’ difficile; accelera il passo, lasciandomi indietro, per raggiungere la capo banda che ci precede; confabula con lei sorridente.
Svoltiamo a Lë Përazza, nome che non allude ai piccoli e caduchi frutti del pero selvatico di cui si nutre l’orso, cavallino e non; ma al fatto che siamo usciti allo scoperto e che a questa altitudine, alla nostra destra, inizia il Vallone di Maquërana; Përazza accadico pû, ebr.pe, bocca,apertura, inizio harru fossato,-azza da accad. āşû elevato.
A Gioia salutiamo la festosa compagnia, dandoci appuntamento all’anno prossimo. I pellegrini s’incamminano per il sentiero che risale la breve collina alle spalle del piccolo borgo per scendere alla chiesa di san Giovanni in mezzo al bosco, vicina ad una sorgente. Nel tardo pomeriggio saranno raggiunti dalla compagnia di Lecce, l’altro gruppo più numeroso dopo quello di Trasacco; man mano arrivano piccole comitive dagli altri borghi vicini: Aschi, Sperone, Ortona… Qui, al rivolo che dalla sorgente va a confluire con il fiume Giovenco si assiste ad una scena sorprendente che può essere materia di interesse per studiosi di religione, storia, sociologia. Si chiede ad un prescelto qualsiasi, dello stesso paese, o di un altro, meglio ancora: se vuole “ farsi a compare di san Giovanni con te”; se la risposta è positiva avviene quanto segue: i due si stringono a gancio i mignoli della mano destra e li immergono nell’acqua che scorre a valle; con movimento a pendolo pronunciano una formula ( dimenticata ) e diventano, ipso facto, compari di san Giovanni. Si fa la conoscenza, in questo modo, con persona mai vista prima, con la quale si instaurerà un rapporto profondo di amicizia che durerà tutta la vita; ci si cercherà nelle ricorrenze, ci si aiuterà nei casi di bisogno, si avrà un’altra casa dovunque, nel mondo, si abbia un ‘compare di san Giovanni’.
L’indomani, il giorno ventiquattro, i pellegrini riprenderanno la via del ritorno; quelli di Trasacco che al mattino avranno partecipato tutti alla funzione religiosa a Bisegna, risaliranno, attraversato il fiume Giovenco, l’erta di Sperone, scenderanno a Manafurnë e da qui proseguiranno ; quelli di Lecce, che sono più vicini al santuario e che si saranno accontentati della visita alla chiesa nel bosco, ripercorreranno, alla spicciolata, il tragitto fatto nel pomeriggio del giorno prima. Fra i ragazzi c’è chi coglierà, fra le pietraie dell’altura di Gioia Vecchio, j’appallarùnë, la ‘Stipa austroitalica’ (ancora appu ed ellû !!!); una volta tornato in paese, ne farà un bel mazzetto, lo appesantirà impiastrando l’estremità dei gambi con lo sterco di mucca passato di qualche giorno; vi legherà stretto uno straccetto. Tutto il divertimento consiste nel lanciare per aria il mazzetto e nel vederlo ricadere ‘piantato’ per terra, candido e soffice pennacchio svolazzante all’aria.
Proseguiamo per la via della Lungara, in discesa, e arriviamo al Passo del Diavolo; sarebbe stato meglio per lui starsene all’inferno, lui il Diavolo che rivendica non sisa che su queste terre; è voluto venire qui, a Prata Longa, dove ora ci troviamo; mal gliene incolse, lo smaschereremo! Lo metteremo a nudo, noi marsicani. Per scamparla può solo librarsi in aria, col tridente in mano, sulle ali di pipistrello, dall’altura di Turchio a quella dell’Ortella, sorvolare il vallone di Lampazzo, e andare da altre parti a dichiararne la proprietà, finché non verrà smascherato anche lì. Questo non è posto per lui; non ci inganna perché noi, nel diavolo vediamo soltanto : ‘separazione delle alture’: “διά: significato originario separatamente, cioè da una parte, da un lato, poi attraverso, accadico idu, sumero da lato, parte” (Semerano, Dizionario della lingua greca, sub diá) e accadico wūlû altura. E così noi, piccoli esseri umani, abbiamo assestato un bel colpo nientemeno che al diavolo! Un esempio che ci insegna a non aver paura…del diavolo! Ora potremmo proseguire per la Parruccia, qui a destra, poi per lë Navëcèllë più in alto, e quindi scendere alla Fòntë dë la Spina, risalire per la Cëcërana e la sua Fossa Përronë, Campë Sicchë, Rocca Gënëvésë, Fòntë Puzzë, l’Ërtélla. Sarà per un’altra volta, e in quell’occasione ci fermeremo al posto di ristoro, operante, che, d’in su il Poggio ( mi perdoni il grandissimo poeta di Recanati, ma è un ricordo della V elementare!) de La Cicërana, domina Le Prata.
Avevo promesso una lunga scarpinata.
NOTE
[1]Pietro Citati, Peter Pan il bambino magico figlio di Alice, la Repubblica del 6 marzo 2009.
[2] Anche Dionigi di Alicarnasso: “ Primum autem eorum (Sabinorum) sedem fuisse vicum quemdam TESTRINAM nomine […]. (da: Panfilo Serafini,***, Adelmo Polla Editore, p.275)
[3] “ In Novesede, il Mommsen roconosce i Dii Novensides di provenienza sabina”. ( Sul bronzo, p.28). Nella formula di invocazione agli dèi, all’inizio di ogni battaglia, venivano invocati i Novensiles ( Livio,VIII,9); questa la formula: “Iane, Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bellona, Lares, Divi Novensiles, Di Indigetes, Divi, quorum est potestas nostrorum hostiumque, Dique Manes, vos precor veneror, veniam peto feroque, uti populo Romano Quiritium vim victoriam prosperetis hostesque populi Romani terrore formidine morteque adficiatis. Sicut verbis nuncupavi, ita pro re publica <populi Romani> Quiritium, exercitu, legionibus,, auxiliis populi Romani Quiritium, legiones auxiliaque hostium mecum Deis Manibus Tellurique devoveo.” Giano, Giove, Marte padre, Quirino, Bellona, lari, dèi stranieri ed indigeti, voi prego, voi venero, a voi, sicuro di ottenerla, chiedo questa grazia: concedete benigni al popolo romano dei Quiriti la forza e la vittoria e colpite col terrore, col panico, con la morte i nemici del popolo romano dei Quiriti. Come ho annunciato con le parole, così ora per la repubblica del popolo romano dei Quiriti, per l’esercito, per le legioni, per chi aiuta il popolo romano dei Quiriti, faccio voto agli dèi mani e alla Terra, assieme a me, delle legioni nemiche e di chi le aiuta.) [ Traduzione di Gian Domenico Mazzoccato, Grandi Tascabili Economici, Newton 1997 ]
I Novensiles erano divinità che scagliavano i fulmini; questi, presso gli Etruschi, erano di undici tipi. Le divinità, nove; in realtà nel numero novem si cela accadico nabû luminoso, risplendere e in siles accadico sil’u getto.(Giovanni Semerano,ivi, LXVII). Il nome marso sede, è identico ad antico babilonese šēdu, sîde spiriti illuminati, protettori della fecondità; NOVII ( =NABÛ). “ La parola pesco è oscura; Pacre si mostra nome del dedicante.” ( Mommsen, Sul bronzo, p.28)
L’accostamento del termine marso, sede, al babilonese šēdu è fatto dall’autore dell’articolo.
La nota richiama il servizio militare e il sidol con cui si deve tirare a lucido, rendere splendente il cinturone… Si cela, forse, nel rito del sidol, senza che nessuno mai l’abbia saputo, l’invocazione riportata che il console Decio, “ indossata la toga pretesta, velato il capo, tirata la mano da sotto la toga e toccatosi il mento, e rimasto in piedi sopra un giavellotto,” prima della battaglia contro i Latini, rivolge agli dèi luminosi?
[4] Catasto di ecce del 1704. Vedi anche “ C’è anche del gotico nella Marsica”
[5] Catasto di Lecce del 1753.
[6] Nella foto che correda il mio articolo ‘Perché Lecce nei Marsi e non dei Marsi’, il Vallone di Pedone, in collina, sulla destra, appare come un quadrato marcato da un tratto scuro. Per averne idea: Google, Lecce nei Marsi,Wikipedia, Nota 5, ( Perché Lecce nei Marsi e non dei Marsi).
[7] Vedi foto in “Sull’impresa di disseccare il lago Fucino in ‘Terre Marsicane’.
[8]Wawwëzë: con questo termine viene indicato, a Lecce, ogni sasso di grandi dimensioni. Anticamente tali massi, che si rinvengono sulle altura, erano considerati la dimora della divinità, chiamati betili (lett. ‘casa del dio’: accad.bētu, ‘casa e ili, ‘del dio’. Waw, nome proprio del ‘sole che splende’; zë, pron. dimostrativo: ‘ quello che’. Sulla collina, a sinistra del Vallonë dë Pëdone ( di cui al testo ) c’è, ci sono, enormi macigni; tutti, e singolarmente, costituiscono Wawwëzë Abbrešatë, letteralmente: ( Il Sole, Padre del fuoco: Waw, ( Il Sole) abu, padre, išati, gen. del fuoco.)
Ma vedi il mio articolo “ Il segreto di certi santi” su Terre Marsicane.