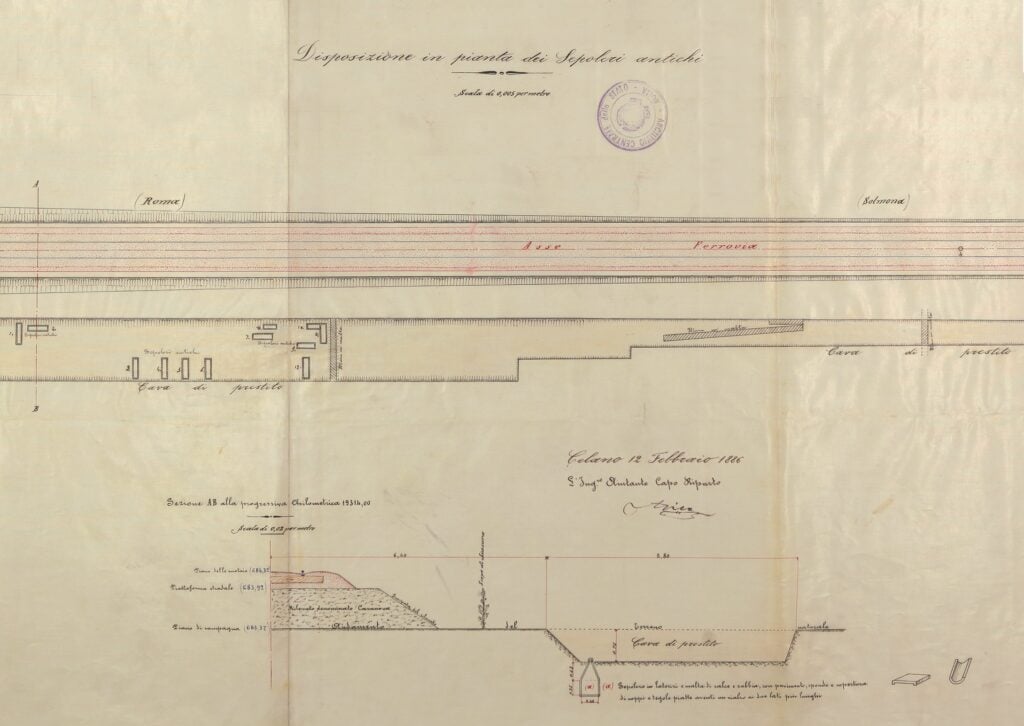Ultimi anni quaranta del secolo scorso; periodo della mietitura al Campo, località a superficie piana ai piedi di Lecce Vecchio. Dal campicello di una decina di are, tramandato di generazione in generazione, dove i miei genitori mi hanno portato forse per mostrarmene l’ubicazione, ( il dettaglio, di nessuna rilevanza in sé, vuole rimandare alla vita di montagna nella Marsica di quegli anni ), guardo stupito il vecchio borgo di cui giù, in paese, i più anziani favoleggiano di suono di campane che, a tempo di prima, si sentiva fino a Celano, di vappi ( guappi) che si partivano spavaldi per dare una lezione a ‘quelli del castello’, di feroci briganti che terrorizzavano le massarie sequestravano persone commettevano ogni atrocità.
A trent’ anni dal terremoto del 13 gennaio 1915, nonostante i crolli, la cinta delle mura è ancora imponente; le torri rettangolari, innalzate su una preesistente cerchia ciclopica, sporgenti dalla cortina, ne accentuano la potenza; le due chiese, di cui si fa cenno nella Bolla di Clemente III, ( Andrea Di Pietro, Origini e storia di Pescina e dintorni, Adelmo Polla Editore, p.93. ) in rovina ma ben identificabili; la maggiore, chiesa parrocchiale, sul colle di sud ovest, da osservatori poco attenti scambiata per un castello, quando il ‘Liber Mortuorum’, ossa umane e crani che incominciano ad affiorare fra i ruderi, suscitando un generale stupore che richiama l’attenzione dell’Autorità Giudiziaria, parlano di sepolture in chiesa ( “ Anno Domini 1784, die vero trigesima mensis Januarii, Joannes Grilli, aetatis suae annorum quadraginta unius obiit […] et corpus eius humatum fuit in hac ecclesia parrochiali, adibitis de more funeralibus, sedente D. Francisco Vincentio Layezza, Marsorum Episcopo. D. Lauretus Chiola archipresbiterus scripsit” [1] ); la seconda, in linea con la prima, a nord ovest, sul colle più basso; la torre mastio, vedetta sul punto più alto ( 1278 s.l.m.), a scrutare la Conca del Fucino; spettacolo che suscita rimpianto per questo castello, vera e propria cittadella, dove nell’ultimo anno del secondo conflitto mondiale, in ruderi riadattati a capanna, vanno a trovare rifugio, per qualche tempo, alcune famiglie di Vallemora, in ansia per la presenza in paese di una guarnigione della Wehrmacht.[2]
Non vede che poveri resti, ai giorni nostri, chi per un’escursione alla Cicerana e alla Selva di Mĕrrĕcéntĕ, patrimonio dell’umanità, percorra la strada che mena alla Terrarošša, così chiamata, dai nativi, la località la Guardia, dove veniva estratta la bauxite ( trasportata a valle da una mastodontica teleferica con stazione a Vallemora, là dove ora c’è il capolinea degli autobus, quindi con carretti alla stazione di Pescina e poi, in treno, allo stabilimento di Bussi, per ricavarne l’alluminio), e si chieda il perché della disattenzione per questo borgo che avrebbe potuto costituire testimonianza e attrattiva, essendo stato l’unico paese della Marsica che, abbandonato nel corso dell’Ottocento in seguito al prosciugamento del lago, aveva conservato la sua struttura medioevale di castello, borgo difeso da una cerchia di mura, come l’antica Roma; questa oppidum ( Livio ) sul Palatino nel secolo VIII a.C., il nostro borgo oppido nel V-IV secolo, come testimonia la su ricordata cerchia “ di I-II maniera poligonale messa in opera a secco”. [3]
La buona sorte mi ha concesso di varcare, a distanza di anni, la siepe naturale di biancospino, carpini, aceri, maggiociondoli, cornioli che recinge il poderetto; di calcare forse le stesse mie orme e, di rivolgere ancora lo sguardo verso quelle torri.
Non è più il castrum Litii che vidi da ragazzo, quel che ho davanti agli occhi. Ti prende un certo scoramento.
Animo!
“Quando le pietre rimangono mute, le parole continuano a parlare la lingua del passato”, scrisse Jacob Grimm. E suona rassicurante.
I nomi che leggiamo nel catasto del 1704, in quello del 1736, dalle pagine scompigliate e mutilo perché sarà capitato in mani leste, e soprattutto in quello del 1753 parlano del passato di questo borgo millenario. [4]
Tre porte si aprivano nella cerchia di mura: porta Caiola o Pila detta anche di Collemino, porta di Metta o della Corte e porta del Campanile.
Sentiamo il catasto.
Su porta Caiola o Pila o di Collemino.
“ Domenicantonio di Biaso Valletta abita in casa propria nel luogo detto Porta Caiola […].
Antonio di Leone abita in casa propria sita nel luogo detto la Pila seù (cioè) Porta Caiola giusta ( vicino) li beni di Angelo Leone e di Matteo Cherubini.
Antonio Milani, Mastro Fà legname (sic), abita in casa propria nel luogo detto la Pila […] e possiede altra casa nel luogo detto vicino la Porta di Collemino […] per uso di bottega .
Angelo di Giovanni Metta possiede un piccolo orticello per uso di casa nel luogo detto Collemino di puggello uno giusta li beni di Antonio Milani, le Mura e la Via”. [5]
Su porta della Corte o di Metta.
“Pasquale Coccia abita in casa propria nel luogo detto sopra la Porta delle Corte […] e possiede una stalla, nel medesimo locale per comodo dei suoi animali giusta li beni di Micchele Iannitti (il quale) abita in casa propria sita vicino la Porta di Metta”.
Su porta del Campanile.
“Angelantonio Genovese bracciale possiede una stalla con pagliaro nel luogo detto fuori la porta sotto il Campanile, per uso dei suoi Animali, giusta li beni di Gaetano del Papa, e la Strada”.
Non ci soffermeremo su questa porta se non per accennare al fatto che la scelta, strategica, di lasciare il varco a pochi metri dalla torre campanaria, ubbidiva a un preciso disegno: permettere alla popolazione, scesi pochi tornanti sulla sinistra, di portarsi celermente a valle, all’abbondante acqua del rio che dalla sorgente di Saùco, là dove ora c’è un casotto da cui parte la conduttura che porta l’acqua al paese odierno, scorreva nel canale. Fontana, lavatoio, abbeveratoi non potevano mancare [6]
Andiamo allora ad occuparci delle altre due porte.
“ E’ noto che i toponimi tendono a permanere molto a lungo nel tempo”, ci ricordano Luca e Francesco Cavalli Sforza nella loro opera. (Chi siamo, Codice editore, p.239.) Valgano a dimostrazione i nomi di: Caiola, Pila, Corte, Collemino che, stante l’antichità del nostro oppido – castello, non possono che rifarsi ad un remoto passato e gli esempi che riporto qui sotto: accadico daqqu, piccolo, fanciullo e Dachĕ soprannome di persona di bassa statura; accadico darāsu, repellere, respingere indietro, leccese darassĕ allontanare, respingere (“ darassĕ, Signore!” è l’implorazione rivolta al cielo in presenza di una calamità come: una tempesta con saette, una grandinata che rovini tutto il raccolto, una sciagura, una pestilenza ); accadico barāqi, del lampo, del fiammeggiare, accadico burruqat , detto, in un testo accadico, di una signora che ha gli occhi lampeggianti ( ‘ blitzende Augen hat’,von Soden, 106 a.; da Semerano, G., Le origini della cultura europea, p.305” ), Barracchittĕ, soprannome di un carissimo, effervescente, indimenticabile amico che ci ha lasciati, occhi vivaci, portano a sostenere che anche nei nomi delle porte del nostro borgo rivive la lingua di Sargon, l’accadico, arrivato con le conquiste del grande re fino alle sponde del Mediterraneo, e da qui propagatosi per tutto il bacino. Con la civiltà viaggiano le parole che nel fondo linguistico del vicino Oriente sono simboli tradotti in realtà, coincidono con l’essere sono il fatto stesso. Salva l’astrazione, caratteristica del pensiero occidentale, farei un esempio con la voce spagnola ola,
Durante una partita di calcio, in certi momenti della gara, si assiste ad un agitarsi degli spettatori che si levano in alto e si risiedono imitando il movimento di un’onda; fanno, insisto, fanno la ola; e non aggiungo altro sulla voce se non che, facile previsione, fra i sostenitori della squadra vittoriosa in tanti andranno a festeggiare il successo con abbondanti libagioni e braciole ( chi non ha assaporato mai carne di proprio gusto e, visto che siamo in Abruzzo, arrosticini fumanti… in alto alla brace ?! quando non braciole, fatte a braciola, infilate a lunghi spiedi di rami lisci di faggio, in aree attrezzate di montagna?). Bene. La parola ola coincide con ( il fatto di levarsi in ) alto, dunque; e in accadico elû è alto, andare su, ascendere, andare in alto in un luogo, elevato, appunto.
Siamo pervenuti così in alto; a porta Cai-ola che l’archeologo, muovendosi, letteralmente, nello spirito dell’ammonimento “…il piccone dello scavatore è cieco e il materiale messo in luce inutile quando non soccorrono le cognizioni storiche , filologiche, etimologiche dello studioso” dello storico dell’antichità B.R.Motzo, ha cercato e scoperto a nord est del colle più basso, accanto alla chiesa di Sant’Elia, a strapiombo sul Fossato, esattamente come indicato dalla prima componente del termine cai-, voce semitica corrispondente ad ebraico gaj “ valle, terra bassa in riva al fiume, al mare ”; antico francese cay, gallico cai, francese quai lungofiume, greco γαίη. Caiola dunque in alto al Fossato. Si perveniva a porta Caiola per via della Cecola che risaliva ( risale) dal vallone, “autostrada” che collegava il borgo con il resto del mondo. Via della Cecola passa fra diverse aie dove si triturava il grano sul crinale, accadico eku limite, confine; ce– < sa pronome dimostrativo, quella. Cecola quella ( la via ) in alto, al confine ( sulla cresta), che conduceva dritta alla porta per eccellenza; alla Pila, accadico abullu porta, porta di città, il quartiere stesso, che da essa prendeva il nome. Al 14 Gennaro (sic) del 1754 al quartiere la Pila o, con il nome del colle, a Collemino, c’erano 81 famiglie per 456 abitanti (quanti, in realtà, se dagli inizi di ottobre a fine aprile c’era da badare alle più di quattromila pecore e alle più di tremila capre che si portavano in Puglia, custodite anche da ragazzi di 7-8 anni? Che Nan cĕ lĕ pĕrtìvĕ lĕ pèquĕra ‘n Pujja – sĕ nan tĕnìvĕ la cujja! ammonivano i vecchi pastori, a significare quanto dura fosse la transumanza).
A Collemino è evidente la cinta di mura a difesa dell’oppido; Collemino, da accadico kallum cima, testa e da voce mediterranea, semitica, ebr. mānă, sbarrare, chiudere; latino moenia ‘ mura, baluardi, fortificazioni.
La Rua [7] di Sant’ Elia degrada dolcemente verso lo scoscendimento del colle opposto e qui, alla convergenza, c’è la porta di Metta; termine derivato, per scomparsa dell’accento e raddoppiamento della dentale, da (di) metà, per la posizione occupata, fra i due colli.
Corte è l’altro nome di questa porta, per un preciso motivo.
E’ la porta ai piedi del colle della chiesa parrocchiale, della torre mastio della “Casa dell’Università” (il comune), della piazza principale; è la porta per la quale si entrava in città; accadico qarittu, aramaico qarta , ebraico queret, arabo qariat. ( città, villaggio.), grod polacco, gorod russo, grâd serbo croato, ugaritico qrt e, per finire, leccese qrti-jjĕ, dai ‘catastieri’ italianizzato in corte.
Chiudo col dire che fino al terremoto della Marsica, Castelluccio, l’attuale quartiere di Lecce, costituiva il casale capoluogo: qui il municipio, la chiesa parrocchiale, la scuola elementare; costituiva il centro degli altri otto casali che formavano il paese; era, nome che si conserva ancora, lĕ Quĕrtijjĕ, cioè la città, distrutto dal terremoto, ma tornato all’antico grazie all’affezione e alla lungimiranza di avveduti imprenditori che l’hanno reso un posto incantevole, di piacevole soggiorno. Lĕ Quertijje di Lecce Vecchio, al 14 Gennaro 1754, contava 84 fuochi ( famiglie) 425 abitanti.
NOTE
[1] Napoleone, con l’editto di Saint Cloud del 12 giugno 1804, proibì la sepoltura nelle chiese. A Lecce la prima sepoltura in “ Camposancto” fu quella del 29 maggio 1839 di “ Maria Felix filia Sabatini Tirzoni”. ( dal Liber Mortuorum ).
[2] L’episodio mi è stato riferito da Guglielmo Monaco di Vallemora, all’epoca dei fatti giovane carbonaio nella ditta paterna. Da parte mia posso testimoniare di aver sentito parlare in casa, fra miei parenti, di “prigionieri” che si nascondevano in montagna ai quali bisognava portare dei viveri e di che coprirsi per ripararsi dal freddo ( ‘oh gran bontà de’ cavalieri antiqui!… ); posso testimoniare di essermi recato, calata la sera prima che scattasse il coprifuoco, con la sorella di lĕ Dachĕ, mia zia Isabella, che qui voglio, sì, ricordare per il suo gran cuore, e con un paio di altre donne ( questo è il ricordo), a la Vĕcènnĕ, all’estremità sud est di Tarotĕ, ed essere entrati in una buia stanzetta dove si teneva nascosto Salvatore, soldato italiano siciliano. Fra le bollette della luce e le ricevute delle tasse, che venivano conservate con molta cura insieme ad ogni foglio di carta che recasse una scritta ( non c’era allora molta scolarità in paese, soprattutto fra le donne, e per questo veniva conservata a lungo ogni “carta”) ho visto un attestato di riconoscenza, a firma del Generale Alexander, con su il nome di mia madre. Distrussi, nei primi anni sessanta con le mie mani, per un repulisti generale, tutti i fascetti di bollette e ricevute delle tasse fra cui quell’attestato.
[3] Antonio Manna, Un esempio di incastellamento nella Marsica Meridionale, tesi di laurea.
[4] Si deve all’impegno del Prof. Mauro Terra l’aver riportato all’Archivio comunale copia del Catasto del 1753 conservato nell’Archivio storico di Napoli, grazie al quale è stata possibile la stesura di questo articolo.
[5] Puggello: italianizzazione del leccese p’jllĕ, il cavo di una mano riempito di semente. Era la più piccola misura di superficie corrispondente a quella coperta da un pugno di grano, 3 mq.ca.
La misura base di superficie a Lecce (è) era la coppa, recipiente a forma tronco-conica della capacità di 12 kg. di grano con i quali si ricopre una superficie di 448 mq.; per 1kg occorrono 12 puggelli; retaggio del sistema babilonese di conteggio sessagesimale, per indigitazione. Mq. 448: kg.12 = mq.37,(33): 12 = 3,(11) mq.
[6] “Antonio di Giov. Borza Pecoraro: possiede nel luogo detto Saùco un territorio di puggelli 14 giusta li beni di Berardino Borza, di s. Francesco, di Pier Matteo Abrami, del Capitolo, ed il Rio”.
[7] Lampante in ‘Rua’ il termine francese ‘ rue’ (via), introdotto al tempo della dominazione angioina nell’Italia Meridionale ( dal 1265 al 1441 ), dopo la battaglia di Tagliacozzo. Non può essere stato introdotto sotto il regno di Giuseppe Bonaparte o di Murat, perché lo troviamo nel catasto del 1753 e la Rivoluzione francese è di là da venire.
- Chiesa di s. Elia a Collemino.
- 1a torre a Collemino.
- 2a torre.
- 3a torre.
- 4a torre.
- 5a torre.
- Torre circolare (aragonese, dopo il1442), a guardia della porta della Corte.
- Il Campo.
- Il Campo.
- Chiesa parrocchiale.
- Mura ciclopiche alla base della chiesa parrocchiale.
- Il Castello di Lecce: a sx Collemino a dx l’ Orto della Corte.
- L’ Orto della Corte: a sx la torre Mastio; a dx il campanile della chiesa parrocchiale.
- Il Castello di Lecce. In primo piano la via innevata che dalla porta di Metta o porta della Corte, scende al Campo.
- Chiesa di s. Elia ( anni settanta sec.XX).
- Chiesa di s. Elia ( inizi XXI sec.)
- Chiesa di s. Elia.
- La coppa
- Anni 70 del ‘900. Costruzione strada panoramica Lecce- La Guardia.
- Porta della Corte.
- Il Velino e la Conca, visti da Lecce Vecchio.
- …tanto per…( Il podere!)