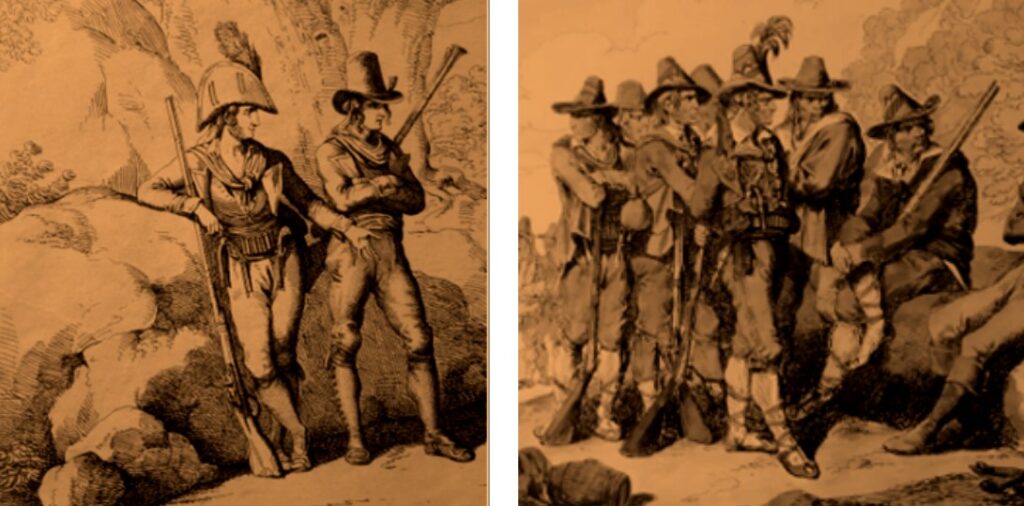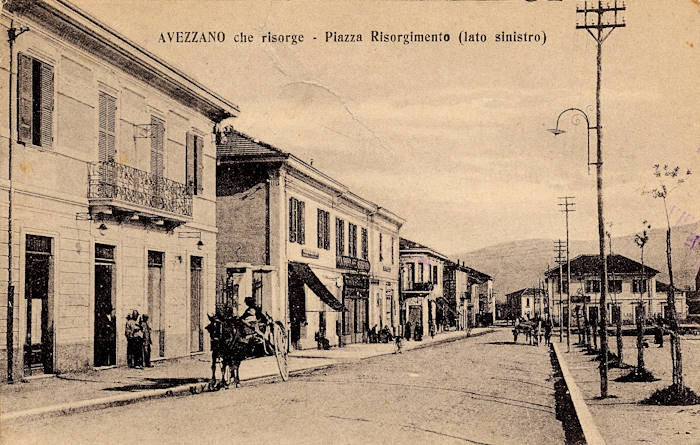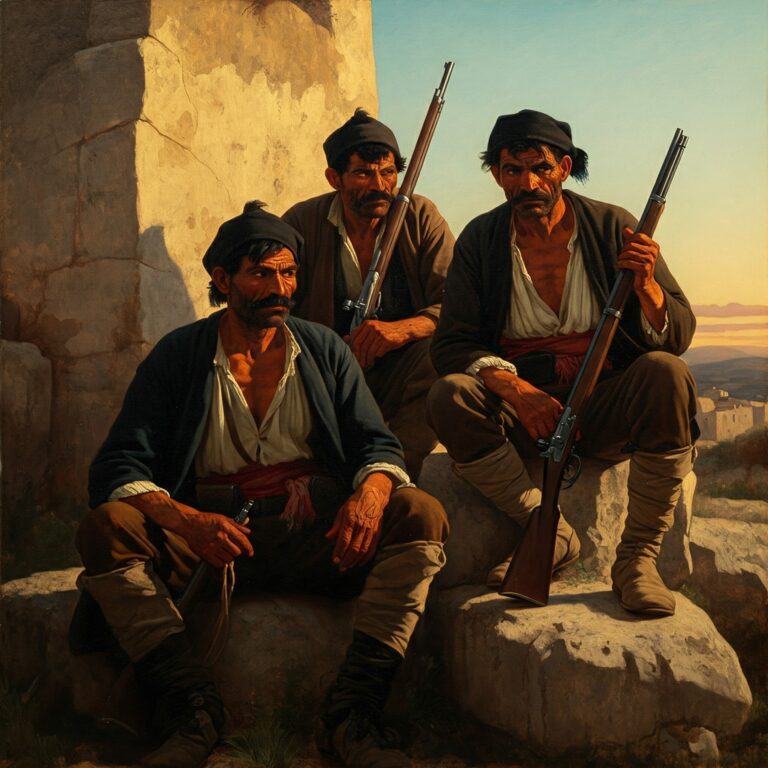Marsica – “Papé Satàn, papé Satàn aleppe!”. L’indimenticabile verso ( Inf. VII, 1 ) è tornato alla memoria, appena il titolo è comparso sullo schermo.
Parole incomprensibili quelle pronunciate da Pluto, guardiano del quarto cerchio dell’Inferno, dove (è piacevole tornare col pensiero al fior degli anni) due folte schiere di dannati, gli avari e gli scialacquatori delle proprie e altrui sostanze, spingono col petto e in direzione contraria grandi pesi. Si scontrano in due punti del cerchio diametralmente opposti rinfacciandosi a vicenda,’ con grand’urli’, i peccati che li accomunano nella condanna; poi ciascuno si volge indietro e riprende a rotolare il proprio macigno fino all’altro punto dell’ incontro, in eterno. I commentatori hanno dato discordanti interpretazioni del verso; alcuni sostengono che esso non ha alcun significato che possa fare riferimento ad una lingua umana, essendo un esempio del linguaggio dei diavoli, per noi incomprensibile; per altri le parole pronunciate da Pluto sarebbero soltanto suoni privi di senso, che rivelano una mente contorta e abbrutita. Il Momigliano le commenta come “segno dell’imbecillità a cui riduce l’avidità di ricchezza”.
Parole oscure dunque, quelle pronunciate da Pluto (…anche per il Poeta?).
L’articolo, il lettore che frequenta questa testata e ha notato la firma, lo avrà già intuito, tratterà dell’etimologia di Canalĕ, soprannome che Giuseppe si è visto appioppare fin da ragazzo. Se si esclude, e categoricamente lo escludo, che il termine, dato che siamo nel Fucino, faccia riferimento a uno dei tanti canali creati per il prosciugamento del lago, o che indichi quella fenditura formatasi per erosione sui fianchi dei monti come, ad esempio, il ben noto ( a Lecce) Scaraiazzĕ, profondo scavo che ha inizio dall’alto, alle Case di Trivegna, poco prima della casa cantoniera di Sperone, e va a confluire in basso, nel torrente Latavana, ( Scaraiazzĕ, ‘scavo dall’alto’, da accadico sakāru ‘ separare, dividere ‘ , greco σκαριφάσθαι ‘ scavare, scalfire’ e accadico asû ‘elevato, alto’; così Scardella, soprannome di Domenico Morgani, falegname, ‘ quello che incide, intacca, scava, scalfisce’; –ella, accad. allû pron., latino ille quello ), o ancora che possa designare la gronda, la canala e, nell’era delle telecomunicazioni, un canale di emittente televisiva, un canale d’informazione, un canale diplomatico, si deve forse concludere che Canalĕ sia un vocabolo oscuro, incomprensibile come le parole pronunciate dal diavolo? Era ricco di significato, eccome! per chi, osservato il comportamento di quel vispo ragazzo che è Peppe, ha ricacciato il termine dal bagaglio di antiche parole che Lecce si porta appresso da secoli.
Lecce, questo castello medievale, ‘villaggio posto in posizione dominante e difeso da mura’, tale è l’accezione del vocabolo ‘castello’, proprio di Litium, (pronunzia Lizium), dove non c’è mai stato alcun maniero, di ben mille anime agli inizi del XIX secolo quando, allettati dalle voci che davano prossimo il prosciugamento del lago che avrebbe lasciato allo scoperto nuove terre e dal clima più mite, gli abitanti si trasferirono man mano a quote più basse, stanziandosi chi qua chi là, dando origine a ben nove casali.
C’è al centro dell’attuale paese, ricostruito dopo il terremoto del 1915, lo spiazzo “Largo Andrea Doria”, un quadrilatero dalla perfetta forma rettangolare, delimitato ai due lati minori da un edificio per lato; una fila di basse casette contigue, di quelle approntate dopo la catastrofe e che sono la caratteristica di tutta la Marsica, costituisce un lato maggiore; il lato opposto, a sud, è segnato da due edifici ad un piano, paralleli tra loro e distanziati di una carreggiata.
Al piano terra di uno di tali edifici abita Anatolio, Natojjĕ, nome che in paese è ormai una metafora; sta per ‘pidocchioso’, data l’assoluta povertà. Originario dell’Altopiano delle Rocche è solo in casa ; ex ufficiale di posta, ha dovuto lasciare l’impiego non si sa bene per quale motivo; sopravvive di carità e delle poche lire che gli danno come scrivano. Gli si rivolgono soprattutto quelle madri di famiglia illetterate, e sono tante, con i bambini piccoli non ancora in età scolare o alle prime classi, non in grado di scrivere una lettera, che devono dare notizie della famiglia al marito che sta fuori di casa, a Foggia con le pecore, o a tagliar legna nei boschi del Reatino.
Al pianterreno del secondo edificio abita Peppe.
Ragazzo di sana e robusta costituzione, sveglio. Quando si cimenta con i suoi coetanei alla lotta libera, atterra tutti, anche qualcuno più grandicello d’età, che lo abbia sfidato. Al mattino gli scolari del quartiere gli si radunano intorno prima che Charlot, il temutissimo bidello somigliantissimo in tutto e per tutto al celeberrimo personaggio, per questo il soprannome, che fa rigar dritto tutti e che non risparmia osservazioni neanche ai maestri, salga sul campanile e, orologio alla mano dia, con nove rintocchi di campana, il segnale che è arrivato il momento di andare scuola. Anche se non paragonabile al “plagosus Orbilius”, il maestro di Orazio che picchiava di brutto (Ser. II, 1, 70), ogni insegnante ha la sua brava bacchetta, e se non c’è alunno che possa dire di non aver ricevuto mai una bacchettata, non è dubbio che Peppe, per via della sua esuberanza, sia tornato spesso a casa con le mani arrossate…; sì, perché quando il maestro alza la bacchetta, lui d’istinto lesto ritira la mano e allora, dopo essere stato ‘invitato’ a riappararla, gli tocca porgere anche l’altra mano.
Il maestro è il maestro…! Peppe è certamente tipo da marinare la scuola come ha fatto una volta Eugenio. Stanco e mortificato di ricevere bacchettate perché spesso viene sorpreso senza aver fatto i compiti, e a casa nessuno può dargli un aiuto, un giorno Eugenio, sentiti i rintocchi di Charlot e temendo quello a cui sarebbe andato incontro, non se la sente proprio di andare a sedere sul banco; coinvolge nella decisione altri cinque scolari più piccoli, fra cui l’autore dell’articolo, e tutti insieme vanno a nascondersi dietro una siepe di bossi all’uscita del paese, a mezza collina, dalla quale la vista spazia su tutto il paese e domina la piazza dove c’è l’edificio scolastico. Rimangono, i birichini, dietro la siepe per tutta la mattinata! Quando, a portone della scuola spalancato, vedono uscire a frotte le varie classi, aspettano che finiscano di uscire anche i maestri. Ora sì che, fatto il proprio dovere, si può tornare a casa…
La primavera è la stagione in cui si va in cerca nidi e Peppe con i compagni non si lascia sfuggire l’occasione di cercare sotto ogni pianta di timo o sotto qualsiasi altro toppo, un nido di terragnola , l’allodola, che come dice il nome, nidifica sul terreno; o di cercare un nido di cardellino, verzellino, verdone fra i rami dei mandorli, sui quali ci si arrampica però più per fare una scorpacciata delle verdi e tenere drupe che per cercare un nido dei notissimi uccelli. Appena fuori del paese Peppe anticipa, con aria seria e sorniona: – Saccĕ nĕ nidĕ chĕ du’ ova i nĕ cĕllittĕ! ( Traduzione ad sensum: “ Conosco un posto dove c’è un nido con due uova e un uccellino”). I due più piccoli della comitiva, che non hanno mai visto da vicino un nido e chissà cosa farebbero per vederne uno e sgranare gli occhi alla vista delle piccole uova punteggiate, e toccarle con un dito, gli chiedono curiosi: – Cĕ lĕ ‘zinghĕ, purĕ a nu? ( “ Ci fai vedere pure a noi dove si trova? “) . Un’allegra risata accoglie la richiesta dei due ansiosi, che lì per lì restano assai contrariati. Un riso di compiacimento affiora però anche sulle loro labbra quando tutti i compagni all’unisono, e quasi e con tono canzonatorio, a voce alta fanno notare che il nido, con due uova e un uccellino, si trova proprio lì, accanto a loro….
Peppe ha sempre la meglio in quei bisticci che avvengono fra ragazzi durante il gioco e spesso rimanda a casa qualcuno che ricorre dalla mamma piagnucolando : – M’ha minĕ (picchiato) Peppĕ!-
I più piccoli lo eleggono a loro difensore; gli chiedono di ripararli ( dalle botte dei più grandi ). È il capo riconosciuto e incontrastato del quartiere, è il ragazzo alfa di Largo Andrea Doria, se è lecito mutuare l’espressione dall’etologia. Se abbiamo presente che il termine accadico ālu significa ‘città, villaggio, contrada, quartiere’ e se pertanto scriviamo il soprannome in maniera disgiunta, Can alĕ, dal momento che in effetti si tratta di due termini, possiamo affermare anche noi, come colui che per primo ha ricacciato il termine, che Peppe è, sì, il Can(e) del quartiere. Ma chi dopo tutto quello che con sincerità abbiamo riferito del nostro eroe oserebbe associarlo al fedele, o ringhioso, animale? Per certo nessuno. Altra è allora la strada da seguire, alla ricerca del significato del soprannome. Ce la indicano grandi personaggi; ce la suggerisce il Gran Khan dei Mongoli, quos nos Tartaros appellamus, come nella sua Ystoria Mongolorum il missionario francescano Giovanni da Pian del Carpine lascia scritto in questa sua opera in nove capitoli: i primi otto composti in viam e ultimati a Lione nel novembre del 1247; ce la suggerisce Altan Khan che alla guida delle sue orde, alla metà del secolo XVI dopo aver devastate le terre dello Shanxi nel 1550, assediò addirittura Pechino per alcuni giorni, per non parlare dei più celebri Gengis Khan e di Kublai Khan di cui al Milione e, più vicino a noi, ce la suggerisce Can Grande della Scala, Signore di Verona, presso cui trovò ospitalità il nostro sommo Poeta. Ci siamo. Can(e), da accadico kânu, ‘ legittimo, duraturo, stare saldo, essere sicuro, certo, fisso ( come un canone), stabile in un luogo’; condizione che, come alcuni casati insediatisi secoli addietro in alcuni paesi dei Monti Frentani ( vedi Palmoli), si portano scritta nel cognome Cane che, beninteso, non ha nulla a che vedere con il fedele amico dell’uomo. In Sardegna è Canu che, data la conformità del termine all’originale accadico ( lo si ritrova anche in aramaico, arabo, etiopico, in ebraico kūn), immaginiamo che lo abbiano pronunciato i guerrieri Šardana dopo aver messo i piedi, ben saldi, e fatta loro la bellissima isola.