Le nuove prospettive politiche non certo edificanti e le vicende economiche fasciste tra la seconda metà del 1925 e la fine del 1927, provarono «duramente tutta l’economia italiana», incidendo non poco sulle condizioni di vita anche della popolazione marsicana.
A ciò contribuì, oltremodo, un’annata cattiva che assunse «proporzioni drammatiche» (1). Occorreva improntare subito, un’azione di rivalutazione e di stabilizzazione della lira che avrebbe comportato «la quasi certezza di una crisi economica e finanziaria di assestamento». Sull’argomento, in modo dettagliato e specifico, esiste un’ampia letteratura che mostra come il ministro Volpi e Mussolini affrontarono questa crisi con strumenti tecnici, tra il settembre del 1926 e la primavera del 1927 (2).
Nella stessa prospettiva, si inserì il nuovo contratto di lavoro «per la campagna bietolifera 1927», laddove importanti riunioni svolte in tutta la Marsica, caratterizzarono i difficoltosi negoziati con gli agricoltori. Dopo molteplici discussioni, alle quali parteciparono oltre ai delegati della «Società Anonima Zuccherificio di Avezzano», l’onorevole Luigi Razza (presidente della federazione sindacati fascisti), il «grande ufficiale» Cacciari (presidente della confederazione nazionale agricoltori fascisti); l’onorevole Casavicchio, in rappresentanza della «Federazione Bieticoltori Italiani» e Romano Cocchi (segretario generale dell’ufficio provinciale dell’Aquila), fu stipulato il nuovo contratto collettivo per la campagna «bietolifera 1927». Il concordato stesso segnò: «una grande vittoria sindacale poiché l’aumento medio delle voci tariffali di consegna nei vari periodi è di L.1.70 centesimi in rapporto ai prezzi praticati lo scorso anno» (3).
In questa azione capillare, il prezzo per ogni quintale di bietole però variava, in rapporto alle consegne fatte nel primo periodo (settembre) fino al sesto periodo che comprendeva le date 16-25 novembre 1927. Quindi, in aggiunta a: «notevolissimi vantaggi economici, si è anche ottenuta la riduzione sensibile delle spese di trasporto a carico dei coltivatori per ogni quintale di polpa insilata e ritirata dalla Società». Nell’insieme, il concordato fu accolto con viva soddisfazione dagli agricoltori del Fucino: «i quali rinsaldano così la loro fede nel Fascismo, quale tutore vigile ed amorevole dei loro interessi». Con queste affermazioni, tratte dalla cronaca de «Il Risorgimento d’Abruzzo e Molise», il giornale fascista ricordò che, cogliendo l’occasione della favorevole contrattazione, il segretario generale dell’ufficio provinciale, accompagnato dal vice segretario generale Giovanni Alessandri, effettuò: «una serie di riunioni di agricoltori nei più importanti centri della Marsica per spiegare agli organizzati la portata dei benefici conseguiti ed invitarli a stringersi sempre più fervidamente intorno ai gagliardetti sindacali fascisti».
Allo stesso modo, ricevuti dal commissario prefettizio di Celano (Albanello), dal segretario del sindacato, dal comandante della milizia nazionale e da altre autorità locali: «i signori Romano Cocchi e Giovanni Alessandri si sono recati nella piazza ove si addensava un fitto stuolo di agricoltori. Dal balcone del Municipio, ha preso per primo la parola Alessandri che ha esposto le finalità del Sindacalismo fascista, supremo regolatore della vita economica nazionale, e difensore strenuo degli interessi dei lavoratori» e poi parlò Cocchi tra grandi acclamazioni.
Anche a Luco dei Marsi la delegazione fu ben ricevuta nell’aula consiliare gremita di agricoltori. Il segretario provinciale mise subito in evidenza l’importanza delle clausole a favore dei lavoratori: «dicendosi certo di poter contare sulla loro fede e tenace attaccamento». La sua relazione fu accolta da scroscianti applausi. Successivamente, la comitiva venne ricevuta a Trasacco da: «una grandiosa manifestazione alla quale presero parte tutte le autorità locali, il Podestà, il Segretario Politico del fascio, il Comandante la Milizia, i dirigenti Sindacali e un’imponente massa di popolo. Nella piazza del paese parlarono il Segretario Generale Cocchi e il Vice-Segretario Alessandri, suscitando grande entusiasmo e poderosi Alalà al fascismo, al sindacalismo e al Duce».
Nella giornata successiva, in questo clima di esaltazione collettiva: «ebbero luogo imponenti adunate a Pescina, Gioia dei Marsi, Ortucchio e S.Benedetto. In tutti questi paesi, e particolarmente a Pescina ove contemporaneamente ebbe luogo anche l’insediamento del Podestà Avv. Mameli Tarquini, le laboriose popolazioni agricole dimostrarono nel modo più palese il loro tenace attaccamento all’organizzazione. I discorsi pronunziati da Cocchi furono accolti con viva soddisfazione, e si rinnovarono dappertutto le manifestazioni di giubilo e di gratitudine per i vantaggi conseguiti attraverso il nuovo contratto bietole. Da tutti i centri suddetti furono inviati telegrammi di saluto deferente e devoto all’on. Rossoni, all’on. Razza e al Console Masciocchi, Segretario Federale del Partito, per attestare ancora una volta la feconda armonia di intenti che lega le organizzazioni sindacali della Provincia e quelle politiche» (4).
Senza negare l’importanza di tali risultati parziali raggiunti durante la contrattazione con gli agricoltori fucensi, occorre rilevare quanto sia stata illusoria l’azione fascista, sempre vincolata alla severa congiuntura del momento.

Gli industriali zuccherieri, già dal 1925 avevano sciolto l’Unione zuccheri, costituendo con l’adesione di oltre il novanta per cento delle società saccarifere il «Consorzio Nazionale Produttori Zucchero», che assunse il monopolio assoluto dell’acquisto delle barbabietole e della vendita del prodotto raffinato. Tuttavia, per esercitare il proprio dominio incontrastato, il consorzio eliminò ogni esercizio di potere contrattuale da parte dei produttori di bietole. Così fu sciolta nel 1927 la «Federazione Nazionale dei Bieticoltori» e, con decreto 24 maggio 1932, n. 1112, sorse l’organizzazione obbligatoria di tutti i produttori di bietole (ANB), dominata dai grandi proprietari terrieri come Torlonia; successivamente, nel 1934 fu riunita nella «Corporazione delle Bietole e dello Zucchero», in posizione subordinata all’industria saccarifera.
Il suo monopolio protetto, garantito e favorito dallo Stato non venne ostacolato dall’ANB, ormai ben integrata, anzi «nel suo sistema di dominio e di potere, ebbe così la possibilità di realizzare i massimi profitti, trovando in perfetta corrispondenza la sua politica di sempre con quella autarchica realizzata dal regime fascista» (5).
NOTE
- R.De Felice, Mussolini il fascista, II. L’organizzazione dello stato fascista, 1925-1929, Giulio Einaudi editore, Torino 2019, pp.259-262.
- R.De Felice, cit., pp.234-235.
- Il Risorgimento d’Abruzzo e Molise, Anno IX – Num.690 – Roma, 20 Marzo 1927. Un nuovo contratto di lavoro per la campagna bietolifera 1927. Importanti riunioni di agricoltori nella Marsica.
- Ibidem.
- Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, Legislatura V, Disegni di Legge e Relazioni, Documenti, pp.3-4, Comunicato alla Presidenza il 18 Dicembre 1968 (n.384). Esproprio e trasferimento di proprietà dell’industria monopolistica dello zucchero.







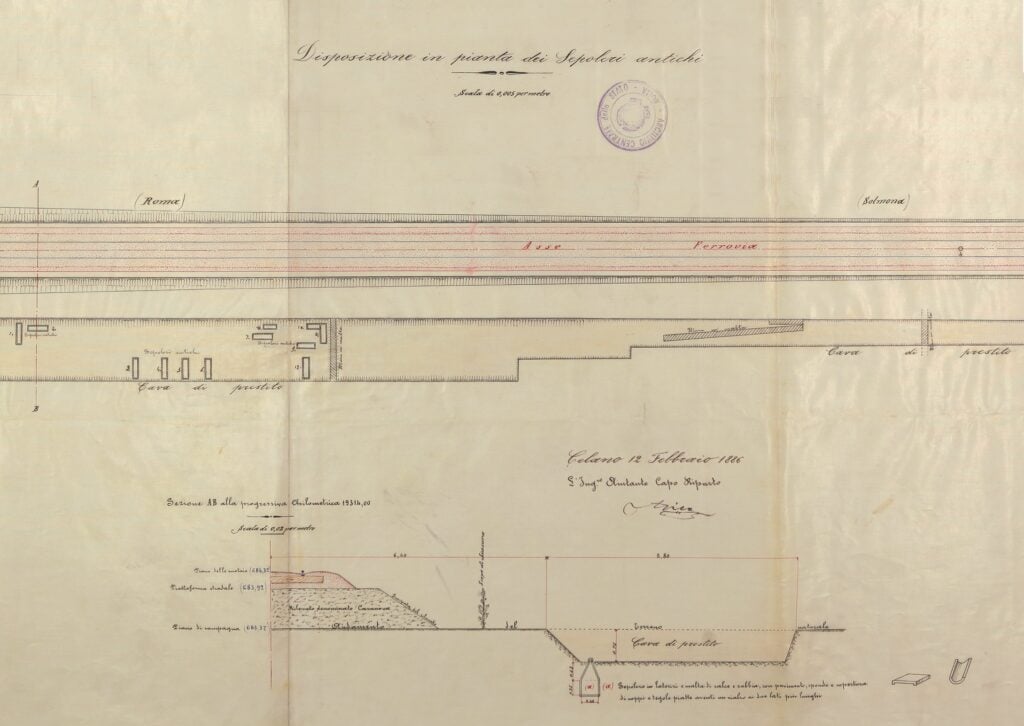












![Picsart_25-04-04_12-37-04-761 {"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](https://www.terremarsicane.it/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Picsart_25-04-04_12-37-04-761-scaled-r3v0yy2vap421d3m0neguc2hy4k9rfia3jd8vdaclc.jpg)






















