Per interpretare correttamente questa voce, senza lasciarsi travolgere dal vortice di sperticati ed audaci riferimenti metaforici per così dire gallo-centrici, come fanno i linguisti, bisogna prima di tutto considerare che vi sono anche altre voci simili, alla base secondo me del chicchirichì ‘gheriglio’, con significati che col gallo e la sua cresta pare abbiano poco in comune come l’aiellese cécurë ‘foruncolo o tumefazione sulla pelle’, il trasaccano cécalë ‘grumo (di polenta, lievito, di calce)’, aiellese càcalë ‘caccola’, lat. cicer ‘cece’, lat. cicera ‘cicerchia’ i quali presumono tutti un’idea comune di ‘corpo rotondeggiante, pallottola’ presente anche nell’italiano chicco oltre che, in tutto il suo splendore, nella voce cicerchieta ‘anello’ del dialetto di Scanno-Aq. Il chicchirichì è inoltre un dolce a forma di cupoletta o ditale ripieno e pertanto anche in questo caso il nome riconferma l’idea di ‘rotondità’.
Il mio parente Giuseppe Gualtieri, scrittore e poeta originario di Aielli e vivente negli USA, mi informa che cuchërùzzë, ai bei tempi andati, designava appunto il ‘gheriglio’(cfr. cuca ‘noce’, in alcuni paesi del Veneto, Friuli, Istria), oltre alla ‘cima, vetta, colmo’, significato a me noto e su cui tornerò più sotto. In effetti la voce abruzzese cucurumìë ‘gheriglio’ ne è una conferma.[1] Nel dizionario I dialetti italiani[2] il termine in questione viene collegato alla cresta del gallo la quale sarebbe indicata metaforicamente mediante il verso caratteristico dell’animale. In altri termini il ‘gheriglio’ con la sua conformazione frastagliata assomiglierebbe alla cresta. Eppure nè a me né a tutti i miei familiari ed amici, pur essendo vissuti in un paese dove fino a non molti decenni fa il volatile lo si poteva incontrare un po’ dappertutto, è mai balenata questa corrispondenza perché, in effetti, essa non è così evidente come si supporrebbe. Casomai è da pensare che solo chi si fosse ritrovato nella propria lingua un termine come chicchirichì ‘gheriglio’, non mutuato da quello relativo al verso del gallo ma con un’origine autonoma rispetto ad esso, sarebbe stato indotto per forza di cose a cercare una qualche somiglianza, sia pur vaga, tra le due entità.
Nel suddetto dizionario si citano anche le voci checchelechè, cucchërichè ‘gheriglio’ dell’area campana e checchelecchè (esiste anche chichilëchè ‘gheriglio’ dell’area abruzzese[3]) tutte intese come varianti di chicchirichì, voce considerata onomatopeica ma che tale non è, come vedremo. Io sono propenso a credere infatti che le precedenti forme, che presentano la liquida /l/ nella penultima posizione, non debbano essere considerate a tutti i costi deformazioni rispetto alle forme che nella stessa posizione presentano la liquida /r/: me lo suggerisce di primo acchito la voce abruzzese cìcele[4] ‘ciottolo, endice, bisbiglio’ la quale, con i primi due significati si riallaccia a quell’idea di ‘rotondità’ di cui si parlava che, secondo me, è naturalmente alla base anche del concetto di ‘gheriglio’, termine che peraltro rimanda ad un etimo greco col significato di ‘noce’. Il terzo significato di ‘bisbiglio’ richiama le voci aiellesi cëcëlà (arcaico chëchëlà) ‘cinguettare’. Altre voci citate sotto la voce chicchirichì nel dizionario dell’UTET sempre col significato di ‘gheriglio’ sono l’aretino galletto, il ticinese e lombardo settentrionale gal e il calabrese chichili–gaḑḑu in cui, secondo noti linguisti, ci sarebbe stata l’intrusione del gallo a rafforzare il significato di ‘gheriglio’. Io non ci crederei nemmeno se per assurdo fosse vero (senza voler denigrare nessuno) perché sono convinto che il nome del volatile è qui solo la rietimologizzazione di un nome corrispondente all’abruzzese gallë ‘gallozzola, ghianda’[5] e al calabrese gaḑḑa ‘noce del piede’, dal lat. galla ‘noce di galla’.
Da dove può essere arrivato questo strano cìcëlë ‘ciottolo, endice’? A me pare evidente che esso sia della stessa famiglia del greco kýklos ‘cerchio, sfera, globo, bulbo dell’occhio’ con l’inserimento di una vocale cosiddetta anaptittica tra la /k/ e la /l/, come accade ancora oggi per esempio nella resa dialettale dell’italiano “bicicletta”, la quale diventa nell’idioma di Aielli bëcëchëllétta. Infatti, a conferma di tutto ciò, recentemente ho scoperto il termine chichil-onë ‘pietra grande’ del dialetto di Laciano-Ch. Ma non è escluso il fenomeno inverso, cioè che sia stato il greco ad innovare facendo saltare una precedente vocale. Le lingue in genere sono dotate di una sovrabbondanza di forme e nel greco se ne incontrano di simili alla precedente come kóklos ‘conchiglia, chiocciola’, chóchl–ax ‘ ciottolo, pietra da macina’, kókkalos ‘pigna’, simili al ted. Kugel ‘palla, sfera’, tutte richiamanti la solita ‘rotondità’ come il calabrese còccalu ‘cranio, teschio’, abruzzese cuculéttë [6] ‘cavoli cappucci, cavoli a palla’, calabrese cócula ‘glande del pene’, termine quest’ultimo che si incontra in tutta Italia col senso di base di ‘oggetto rotondo’. E non è da credere, viste le varie forme simili del greco o di altre lingue, che esso debba essere formalmente per forza un diminutivo del latino coccum (greco kókkos)‘granello, nocciolo, bacca’, ma che invece sia da ricollegare alla ben nota radice mediterranea o paleoeuropea kukko ‘punta’, significato che come vedremo fra poco richiama quello di ‘protuberanza, rotondità’, come nell’aiellese arcaico cucùlë ‘organo sessuale maschile, pene’. Che le sopraccitate forme per ‘gheriglio’ debbano rientrare nel più vasto concetto di ‘rotondità’ ce lo dice il termine chicchëlëcchè ‘fiore dell’acacia’ (dialetto di Luco dei Marsi), albero con fiori a capolino, riuniti insieme nel ricettacolo a formare una sorta di ‘testa’. Del resto il termine è strutturalmente simile al francese coquelicot ‘papavero’ . Il papavero prende solitamente il nome dalla sua capsula (testa) come nel cerchiese cucuccìjjë, checuccìjjë ‘papavero’, voce che in altri paesi come Aielli indica invece la ‘zucchina’ ed è diminutivo di chëcòccia ‘zucca’. Bellissimo il termine per ‘papavero’ nel dialetto di Collelongo-Aq, e cioè cincëlëc–àstrë . Il suo primo componente richiama la serie precedente con l’inserimento di una /n/ di disturbo tra la prima e la seconda sillaba, mentre il secondo è tal quale il primo componente del diminutivo greco aster–ískos ‘stelletta, asterisco’ ma anche ‘calice del papavero’ in Dioscoride.
A rigor di termini anche questa visione capo-centrica per i termini del papavero è frutto, secondo me, di una specializzazione del significato originario dei termini che inizialmente avevano un valore più generico di ‘protuberanza, escrescenza, elevazione’ riferibile anche all’intera piantina. La forma chichilëchè potrebbe avere un esatto sosia nell’aggettivo sostantivato greco kyklikón ‘cosa rotonda’.
Nel dialetto di Aielli chìcchëra vale ‘cresta di gallo o di gallina’ ed ha un esatto corrispondente nell’abruzzese chìchërë ‘gheriglio’[7], variante del sopra menzionato aiellese arcaico cuchër–uzzë ‘gheriglio’, a sua volta parente stretto di aiellese cuchër–ómmë ‘bitorzolo’ e di abruzzese cucur-umìë ‘gheriglio’ sopra citato: i vari significati trovano, infatti, un punto d’incontro in quello di ‘protuberanza, escrescenza’, non importa se puntuta o rotondeggiante: non bisogna farsi ingannare dai significati, che a noi appaiono ormai in veste specializzata, perché una “punta, cima” di un “colle” è pur sempre una protuberanza rispetto al “colle”, come questo, nella sua interezza, lo è rispetto al paesaggio circostante. L’esempio precedente chicchëra/chichërë riproduce secondo me la presunta dinamica semantica tra il chicchirichì ‘canto del gallo’ e il chicchirichì ‘gheriglio’, ma elimina il passaggio metaforico tra il canto del gallo e la sua cresta, e questo è un indizio non di poco conto che con tutta probabilità anche l’altro supposto e improbabile, come abbiamo visto, rapporto metaforico tra la “cresta” e il “gheriglio” sia null’altro che frutto di un errore di prospettiva e di impostazione del problema. Un’altra conferma in questo senso viene dalla considerazione che la visione gallo-centrica espressa dai linguisti del dizionario UTET circa questi termini lascia completamente al di fuori del suo ambito la voce arcaica aiellese cucher-ùzzë ‘gheriglio’, la quale, pur appartenendo chiaramente alla famiglia di abruzz. chìchërë ‘gheriglio’, recalcitra tuttavia, nella pratica della lingua, ad essere collegata a parti del gallo o al suo canto, anche nell’altro suo significato di ‘cima, vetta, colmo’ riferito solitamente ad alture, mucchi, elevazioni varie ma non alla “cresta” del gallo. Il re è nudo, in questa come in tante altre circostanze! Sfido bonariamente i linguisti a dimostrarmi il contrario: gliene sarei infinitamente grato. Il bello è che voci simili si incontrano anche nell’interessante area sarda e precisamente nel nuorese chichirra ‘testa’, nel logudorese cuccuru, cuccuruddu ‘cocuzzolo, collina, cima, punta’ ma anche ‘coccola, frutto rotondeggiante del ginepro’, nel logudorese cuccuruddù ‘chicchirichì’ ma anche ‘galla, escrescenza delle piante’, nel logudorese chighir–ista ‘cresta’. La radice è presente anche nell’aiellese cucher-ùzze ‘cima, apice’ e nell’interessante termine trasaccano cucùle che oltre ad avere il significato di ‘cornuto’, riferito all’uomo tradito dalla moglie, indica anche una pianta con fiori a forma di campana, una “cavità” dunque, concetto quest’ultimo perfettamente speculare a quello di ‘protuberanza’[8]. Va da sé che il termine richiama anche il lat. cucullu(m) ‘cappuccio’, e, specularmente, il sopraccitato aiellese arcaico cucùlë ‘pene’.
Ora, questa serie continua di termini che mostrano un doppio e diverso significato, quello di ‘sporgenza, colle, cima, ecc.’, da una parte, e quello che possiamo definire di ‘sonorità’, dall’altra, come avviene nell’abruzzese cìcëlë ‘ciottolo, bisbiglio, cinguettio (cfr. logud. chighilliu ‘schiamazzo’), nel toscano chicchirichì ‘gheriglio, verso del gallo’, nel logud. cuccuruddù ‘galla, chicchirichì’, nel fr. coquelicot ‘papavero’ e fr. coquerico ‘chicchirichì’, credo che non ci consenta di liquidare in tutta fretta come ‘onomatopeiche’ le voci interessate. Si deve piuttosto pensare che le radici in questione presentino in superficie valori specializzati e apparentemente incompatibili ma che in profondità esse finiscano col combaciare con un significato più generico come quello di ‘forza, tensione’: la ‘tensione’ può infatti concretizzarsi nella forma di una ‘protuberanza, escrescenza’ o in una ‘vibrazione’ delle corde vocali con emissione di suoni all’esterno, quando questi sono prodotti da esseri viventi, nella cui classe rientravano, nel tempo lontano delle origini del linguaggio, gran parte, se non tutte le entità della Natura. Per cui mi pare un vano affannarsi quello dei linguisti che vogliono a tutti i costi far risalire, ad esempio, l’etimo del verbo italiano tentennare al lat. tin–tinnare, tinnire, tin–tinare ‘tintinnare, ronzare’, attraverso il significato di ‘suonare il campanello’ che il verbo pare abbia assunto in alcuni dialetti. Lo ‘scuotere’ del campanello avrebbe metaforicamente generato l’ ‘oscillazione’ del tentennare. E il ragionamento potrebbe essere anche accettato se non ce ne fosse un altro a mio avviso più diretto e concreto che scende alla radice comune dei due termini apparentemente ‘divisi’ in superficie ed elimina la presunta origine onomatopeica. A me pare, infatti, che la radice coinvolta in questo caso sia la stessa del lat. ten-ere, tend-ere , verbi esprimenti ‘tensione e sforzo’ e quindi adatti ad esprimere anche un ‘suono’. Infatti, il termine corradicale greco tónos ‘tensione, tendine, fune, energia, sforzo, tono, altezza della voce, accento’ mi pare possegga in abbondanza significati che promanano da quello di fondo il quale potrebbe aver dato origine, non solo al significato di ‘sonorità’, ma anche a quello di ‘impulso, spinta, scossa’ che sta dietro all’it. ten-tenn-are. Da notare anche il greco ton–thorýzo ‘mormoro, sussurro, fremo’ il cui secondo componente, che è da accostare a greco thórybos ‘chiasso, strepito, fremito’, ripete tautologicamente il valore del primo. In Euripide si incontra anche tan–tarýzo ‘fremo, dondolo, palpito’ il cui primo componente a mio avviso va collegato col greco tany– , tana– corradicali del precedente tónos e di greco tanaós ‘lungo, disteso, prolungato’. Ma composti tautologici come tany–echés ‘risonante’, detto delle corde, o come tany–rroizos ‘forte risonante’, detto dell’asta, fanno capire che si tratta di ripetizione intensiva di una stessa idea di ‘sonorità’ insita in ambo i membri, piuttosto che di quella di ‘lunghezza’ la quale , comunque, si sviluppa sempre dal nucleo semantico di fondo della radice. Se così stanno le cose anche il din don delle campane non dovrebbe essere ‘onomatopeico’ (anche se ora noi lo avvertiamo come tale) e, nel primo elemento, dovrebbe semmai richiamare l’ingl. din ‘fracasso, chiasso’ che in verità non so se i linguisti liquidino come ‘onomatopeico’ o meno. A rafforzamento di quanto sopra si rifletti sulla la stretta interdipendenza tra i concetti di “protuberanza, forza, spinta ” e quello di “suono, rumore” che si può desumere dai termini abruzzesi vuttë ‘spinta, urlo’; buttë ‘getto’; vuttà ‘spingere, pigiare’; vussà ‘spingere, pigiare’; vussë ‘spinta’; vussà e ussà (Aielli) ’abbaiare’; vozzë ‘rigonfiamento, bernoccolo’; buzz-éttë ‘gallozzola’[9].
A questo punto credo sia oltremodo utile, dati gli esempi precedenti, chiedersi come mai i linguisti siano tanto corrivi ad assegnare una valenza onomatopeica non solo a molti termini riguardanti ‘rumori’ provenienti dalla Natura ma anche a tantissimi nomi relativi a ‘suoni’ provenienti dal mondo animale, soprattutto da quello degli uccelli. Io non sono mai bene riuscito a capire, infatti, quale sia la differenza sostanziale tra la radice di lat. fl–are ‘soffiare, spirare’, considerato onomatopeico, e quella di lat. flu–ere ‘scorrere, fluire’ ma anche ‘spirare, soffiare’, tra l’altro considerato, mi pare, non onomatopeico: il punto d’incontro tra i due concetti non è difficile individuarlo nella ’forza, energia, spinta’ che muove l’aria o l’acqua. Così si evita anche la necessità di dover connettere, come fanno taluni, flu–ere al greco rhéo ‘scorro’, all’ingl. stream ‘corrente’, che molto probabilmente fanno capo ad altre radici. Grava pesantemente, sulla ricerca degli etimi, il forte pregiudizio in base al quale ogni concetto deve essere espresso da una o alcune particolari radici e non, potenzialmente, da una qualsiasi di esse. Modestamente, poi, credo che non si sia riflettuto abbastanza sul fatto che il mezzo linguistico che usiamo è esso stesso composto di ‘suoni’, ciascuno dei quali reca però con sé quel nucleo semantico originario, impresso come un marchio di fabbrica, che è preposto ad esprimere fin dalle origini anche le varie ‘sonorità’ della Natura, come ho spiegato, senza dover per questo trasformare il suo valore simbolico-cognitivo in quello imitativo-iconico. Ma col trascorrere lento e inesorabile del tempo, una volta scomparsi nella coscienza del parlante il ricordo e la consapevolezza di quel marchio semantico d’origine che nel frattempo ha dovuto subire deformazioni varie a causa delle varie specializzazioni storiche dei termini, molte radici, le quali –è bene ricordarlo- costituiscono tutte già di per sé entità sonore, sono andate per forza di cose a combaciare o quasi con quei suoni da rappresentare emessi variamente dalla Natura o dagli animali, sicchè ora, come conseguenza ineluttabile, ci sembra che esse, le radici, in questo caso siano null’altro che la fotocopia della realtà sonora rappresentata, senza quel significato d’origine rintracciabile nel fondo di tutte le altre non onomatopeiche: eppure esse non volevano fare un’eccezione per i “suoni” in quanto li avevano già identificati, all’origine, e classificati come “forze”, entità viventi alla stessa stregua delle altre come, secondo me, ci fa pensare in qualche modo l’espressione formulare omerica con cui si indicano le parole, che non sono altro se non ’suoni, emissioni, emanazioni’ (épea pteróenta ‘parole volanti’). Nella ipotesi poi di trovarsi, ad esempio, nella necessità di rappresentare le cose con una tavolozza di colori i quali, però, non avessero nessun valore imitativo della realtà ma solo un valore simbolico secondo i meccanismi analizzati per le parole, succederebbe la stessa cosa, e se ci capitasse di indicare una ‘ciliegia matura’ con il colore ‘rosso’ saremmo inevitabilmente indotti a credere che il colore ‘rosso’ con cui casualmente designiamo la ‘ciliegia’ trovi la sua piena spiegazione nell’essere solo una copia quasi perfetta di quello della ciliegia, e non più un simbolo con un suo proprio significato d’origine, in questo caso probabilmente quello di ‘rotondità’ o di ‘escrescenza, pianta’, dato che i frutti sono spesso indicati col nome dell’albero che li produce per la fatale coincidenza del concetto di “pianta” con quello di “frutto”, il quale si configura solitamente come una ‘escrescenza’ più o meno rotondeggiante. Ed io peraltro ho potuto capire, nel corso della mia lunga ricerca, che la Lingua, ogni volta che se ne presenti l’occasione, è pronta a favorire questi fenomeni, perché è alla ricerca essa stessa di una specializzazione o di una spiegazione purchessia riguardo all’origine di quei termini che le dovessero apparire un po’ o molto estranei, oscuri. Il fatto è che anche il premio Nobel Konrad Lorenz, famoso etologo austriaco, considerava l’imitazione (e quindi l’onomatopea) solo in senso lato cognitiva nel suo libro L’altra faccia dello specchio, e dal punto di vista filogenetico la riconduceva al comportamento di giuoco e di curiosità degli animali sociali che vivono in nuclei familiari durevoli. Se per ipotesi i linguisti avessero voluto dargli retta non avrebbero nemmeno potuto farlo, perché essi avvertivano con i loro orecchi quelle che a loro apparivano incontrovertibili onomatopee come è il caso di chicchirichì. Io sono convinto, per i motivi suesposti, che l’onomatopea non abbia (quasi) nessun valore conoscitivo e che essa sia un sottoprodotto dell’attività linguistica dell’uomo, che ne ha assecondato la naturale propensione al giuoco e alla imitazione. Ma nel contempo essa avrebbe potuto, questo sì, in una fase successiva a quella aurorale del linguaggio, investire varie radici, portanti già il significato generico di ‘suono, rumore’, con il riflesso di quelle forme iconico-imitative che nel frattempo l’ homo ludens andava sviluppando attraverso quei meccanismi tipicamente onomatopeici come l’antifonia vocalica (din don, tic tac, ingl. tick–tack ‘ticchettio, ticchettare’, ecc.) o il raddoppiamento del segmento fonico (tin tin, it. tin–tinn–are, ecc.).
Tra i filosofi moderni mi pare che il neokantiano Ernst Cassirer (1874-1945) abbia insistito sul valore simbolico di tutte le attività umane e in particolare del linguaggio, elemento fondamentale nella sua filosofia, il quale non sarebbe, quindi, uno specchio della realtà naturale e psichica ma espressione dello Spirito umano che le interpreta: peccato, però, che quando parla del percorso seguito dall’uomo per arrivare al linguaggio simbolico della maturità, costituito di concetti del tutto slegati dalle caratteristiche delle entità rappresentate, non può evitare di considerare l’ onomatopea come indicativa di una fase intermedia vicina ancora al dato reale sensibile. Questo dell’onomatopea costituisce evidentemente un fatto talmente radicato nella nostra cultura e nella nostra mente, e peraltro immediatamente riscontrabile al livello apparente di ogni lingua, che nemmeno le filosofie che sviluppano visioni più consone a quella che secondo me costituisce la vera natura del linguaggio riescono ad aggirarne l’ostacolo.
Alcune volte gli studiosi si lasciano andare a spiegazioni addirittura più inconsistenti di quelle ‘onomatopeiche’ come per la voce toscana tutto–mio ‘civetta’, spiegata nel dizionario dell’UTET di cui sopra come interpretazione popolare del grido dell’uccello. Si citano anche le voci sarde cuccu–méu, cuccu-miàu ‘civetta’, ma non si riserva nessuna attenzione al fatto che esiste anche l’uccello mio ‘fischione’, il greco muia ‘mosca’ e il sardo tidu, tudu ‘colombo selvatico’, tutti termini che ci aiutano ad interpretare nel solito modo tautologico e nella direzione di ‘uccello, volatile, essere vivente’ le due componenti di tutto e mio. Sono anche da ricordare i Titii sodales, collegio sacerdotale poco noto dell’antica Roma, i quali avevano il compito di osservare, secondo Varrone, il volo degli uccelli chiamati appunto titii, probabilmente ‘piccioni selvatici’. Nella variante sarda cuccu–méu si inserisce in prima sede un altro elemento che è quello di sardo cucca–pedra ‘allodola’ e di altri nomi. La prima componente di questo ornitonimo non va affatto interpretata onomatopeicamente e neanche il fr. coq (ingl. cock ) ‘gallo’, il greco kikkós, kíkirros ‘gallo’, il quale ultimo potrebbe allora far pensare meglio all’aiellese chìcchëra ‘cresta del gallo o di gallina’, al basco kukur ‘pettine’, radice già incontrata nel sardo cùccuru ‘punta,cima’, dato che anche in area germanica si incontrano termini come ingl. comb e ted. Kamm che indicano contemporaneamente sia il ‘pettine’ che la ‘cresta del gallo’. Ciononostante qualcuno a questo punto potrebbe ricordare maliziosamente il lat. cucurr-ire ‘fare chicchirichì’ facendoci ripiombare nel pieno della onomatopea. Ma la faccenda è tutt’altra, perché dietro queste voci non vi sono le varie caratteristiche sonore o d’altra natura degli animali coinvolti, bensì il concetto stesso di ‘animale, volatile’ sicchè dietro il ted. Hahn ‘gallo’ non si trova, ancora una volta, il ‘canto’ (cfr. lat. can–ere ‘cantare’) come vogliono i linguisti, ma certamente il fr. can–ard ‘anatra’, il lat. can–e(m) ‘cane’ se l’espressione greca Diòs ptenòs kýon vale ‘cane alato di Giove’, cioè ‘l’aquila’, e se anche l’altra espressione Diòs kýnes indica i ‘cani di Giove’, cioè i ‘grifi’, uccelli che nel loro nome richiamano piuttosto il ted. Huhn ‘pollo, gallina’, variante del precedente Hahn ‘gallo’. In greco si incontra anche kokko–bóas órnis ‘uccello che grida (boáo) chicchirichì (kókky), gallo’ (Sofocle, fr. 900), tipica definizione da vocabolario che ha poco a che fare con lo spirito della Lingua. Secondo me il primo componente kokko– è variante del sopraccitato kikkós ‘gallo’ e combacia con ingl. cock ‘gallo’ mentre il secondo componente bóas si riallaccia al lat. boa, bova ‘biscia d’acqua’, voce isolata ed inspiegata: i vocabolari citano anche la forma boas in Domenico Cavalca, avanti il 1342. Va da sé, a mio avviso, che fa parte della famiglia anche il lat. bov–e(m) ‘bove’. Molti altri uccelli, oltre al cuculo, nei dialetti italiani vengono indicati con i nomi cucco, cucca, cuca. Per uscire dal circolo vizioso delle interpretazioni ‘sonore’ della radice si deve volgere lo sguardo ai termini spagnoli cuca ‘bruco, falena, tarma’, cuca–racha ‘scarafaggio’, all’ingl. cock–roach ‘scarafaggio’ dove l’etimologia popolare già si adopera a favore, anche senza motivo, di ingl. cock ‘gallo’, e al sardo nuorese cuc–urra ‘bruco, forfecchia’: ma il nuorese cucur–ista ‘cresta’, il logud. cugura ‘cocuzzolo’, varianti di cuccuru, cuccura ‘cocuzzolo, cima, punta’, se ne stanno lì appostati, pronti a sviarci e ricondurci ancora verso la cresta e il canto del gallo, rimessi in giuoco magari da qualche etimologia popolare, sia pure strampalata. Con una simile visione gallo-centrica non ci libereremo mai dell’ormai fastidioso suo canto! La presenza, nel più volte citato vocabolario del Bielli, della voce jalle ‘gheriglio’, voce che in diverse nostre parlate indica il ‘gallo’, potrebbe farci ripiombare nella a questo punto ossessiva visione gallo-centrica, ma le voci abruzzesi strozza–jalli ’bacche rosse non commestibili’ e strozza–jalline ‘bacche della rosa canina’ di Cagnano Amiterno-Aq., ci potrebbero per lo meno dare qualche conforto nel supporre che la voce in questione sia in realtà derivata dall’altra abruzzese gallë ‘gallozzola, ghianda’. Naturalmente bisogna isolare la componente strozza– e considerarla tautologica rispetto all’altra, con un significato originario di ‘rigonfiamento, bacca’ del tutto uguale a quello della radice del tedesco moderno strotzen ‘abbondare, essere gonfio, essere turgido’. Questo punto di vista presuppone che questa parola germanica si trovasse qui già dalla preistoria e che non dipenda in alcun modo dall’it. strozza, termine calato in Italia a quanto pare con le invasioni barbariche. Ma, di converso, un valore “sonoro” della prima componente di kokko-boas ci è attestato dal gr. kokky ‘verso del cuculo’ e probabilmente dalla prima componente dell’ingl. cock-a-doodle-doo ‘chicchirichì’, termine che sembra pochissimo onomatopeico se si tiene conto del suo suono, ma che d’altro canto deve essere vecchio quanto il cucco se si osserva il giapponese koke-kokko ‘chicchirichì’, che sembra presentare la radice in questione raddoppiata, evidentemente con valore “sonoro” almeno in superficie. Ma la più interessante di tutte queste onomatopee è a mio parere il comune cocc-odè riferito al suono emesso dalla gallina che ha deposto l’uovo. E’ per me evidente che il primo componente è quello analizzato sopra, e il secondo rimanda al gr. oi dé ‘carme, ode, canto (anche del gallo e di altri uccelli)’. Il termine coccodè è quindi antichissimo, ed aveva all’origine il valore di “suono” in ambo i membri. Lo spirito della Lingua lo ha investito e ha concentrato l’attenzione sul cocco iniziale, specializzando il suo generico significato sonoro in quello emesso dalla gallina che ha deposto l’uovo (cocco). Esso non alludeva all’uovo, essendo variante invece della prima componente dell’ingl. cack-le ‘coccodè’. Quest’ultima parola condivide, a mio parere, la radice con le varie forme dialettali centro-meridionali cacaglià, cacajjà, cacheleià[10], ecc. dal significato che oscilla tra i due poli del ‘balbutire’ (cfr. fr. cacailler ‘tartagliare’) e dello ‘schiamazzare della gallina che ha deposto l’uovo (come in inglese)’. Io penso che dietro questi significati specializzati ci fosse un precedente significato generico di ‘suono, rumore’. Così si riconferma anche una grande verità, già riconosciuta dal Saussure, che è vano credere che le parole siano nate apposta per designare i loro referenti attuali.
Come si può ben capire da tutto ciò la Lingua ci trascina in un vorticoso gorgo di rimandi vicendevoli che ci fanno girare la testa e perdere l’orizzonte, e se non ci muniamo di una bussola affidabile andremo fatalmente a naufragare contro scogli non segnalati dalle normali carte nautiche.
NOTE
[1] Cfr. D. Bielli, Vocabolario abruzzese, Adelmo Polla editore, Cerchio-Aq, 2004.
[2] Cfr. M. Cortelazzo- C. Marcato, I dialetti italiani, UTET, Torino, 1998.
[3] Cfr. Bielli, cit.
[4] Cfr. Bielli, cit.
[5] Cfr. Bielli, cit.
[6] Cfr. Bielli, cit.
[7] Cfr. Bielli, cit.
[8] Cfr. Q.Lucarelli, Biabbà, Grafiche Di Censo, Avezzano-Aq, 2003, sub voce.
[9] Cfr.Bielli, cit. dove si trovano tutte queste voci, tranne quella di Aielli-Aq.
[10] Cfr. M. Cortelazzo- C. Marcato, cit., sub voce cacàglië. In questo dizionario si parla della ripetizione sillabica ca-, ca-, propria di chi tartaglia.







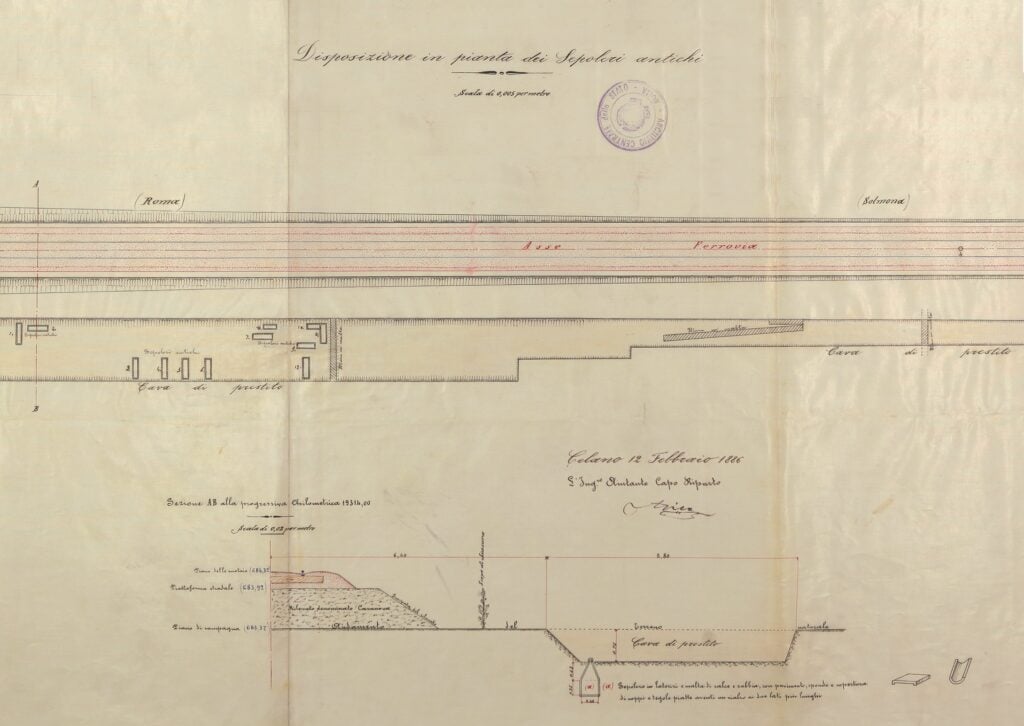











![Picsart_25-04-04_12-37-04-761 {"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](https://www.terremarsicane.it/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Picsart_25-04-04_12-37-04-761-scaled-r3v0yy2vap421d3m0neguc2hy4k9rfia3jd8vdaclc.jpg)






















