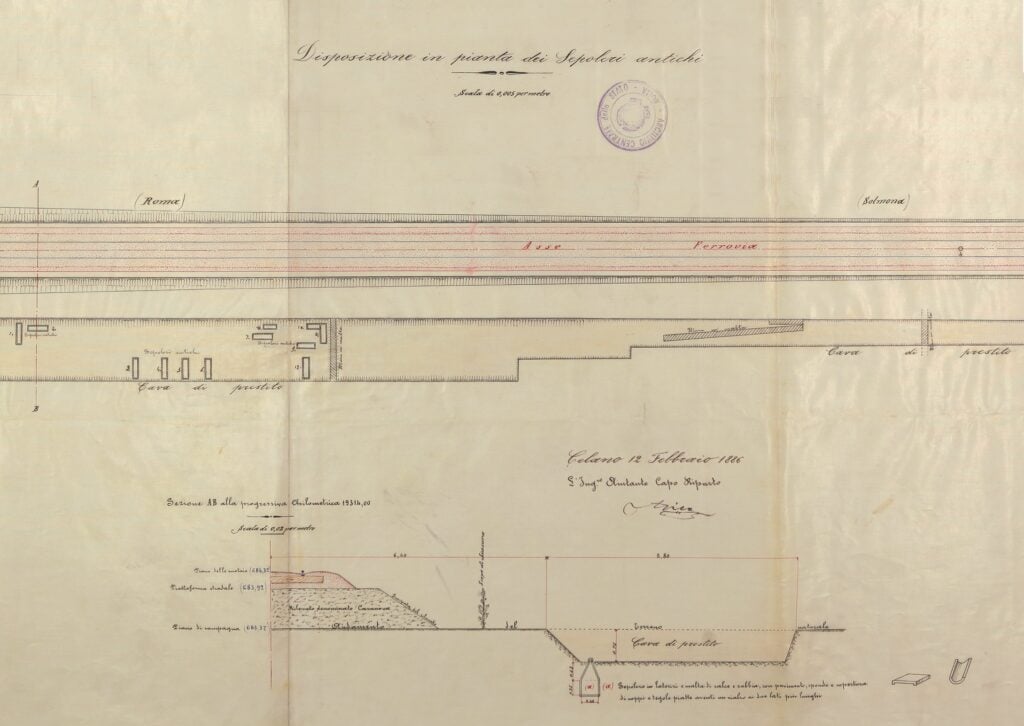Nell’ordine, più o meno, con il quale per femminucce e maschietti, promiscuamente, si fa(ceva) la scoperta di: fare a campana, a mosca cieca, a vriccia ( i cinque sassolini, rotondi al massimo: gli astragali), ad acchiapparella, a nascondarella, a erma, a topatòpa e, solo per i maschietti, a cavallina, a mazzittĕ (a lippa), a pallone, a…, chi più ne sa più ne dica. “In queste e altre locuzioni fare, seguito dalla preposizione a ha il significato di effettuare l’attività indicata dal nome o dalla frase che segue”.
Sono ricorso all’autorità del vocabolario, il Sabatini Coletti, perché il titolo dell’articolo sarebbe risultato incomprensibile per via di quel markĕ, scritto per di più con il cappa, lettera che fatta eccezione per qualche documento antico, non si usa nella nostra lingua
Ora almeno è chiaro che fare a markĕ vuol dire svolgere un’attività e, dato il contesto, che è un fare ludico, piacevole quindi. Non pensi il lettore che nel gioco entri, in qualche maniera, l’evangelista discepolo di Pietro, il cui nome peraltro era Giovanni ( Marco è il soprannome, cognominatus est Marcus. Atti,XII,12).
Markĕ è voce prettamente semitica; è accadico malku e vuol dire re. Nemmeno si stupisca se il termine lo troviamo nel vocabolario di Lecce che, come detto altrove, è oppido risalente al V-IV sec. a.C.; se parliamo di millenni, e diciamo di Lecce, possiamo prenderci la licenza di considerarlo antico quasi quanto Roma, pur se tra il solco tracciato da Romolo sul Palatino e la nascita del nostro borgo sul pomerio, cioè su di costa montana, accadico bam(t)u e accadico ūru città, villaggio, trascorrono due e passa secoli.
Nel nostro markĕ la r-, definita la regina delle consonanti, ha preso il posto della l-.
Ma ecco quando, dove, chi, come si fa(ceva) a markĕ.
–Tempo: saltuariamente in autunno e inverno quando, nella comunità agro pastorale, i lavori erano terminati; non c’erano i bar ( ora ce ne sono ben sette a neanche cento metri di distanza l’uno dall’altro) e le giornate, per gli adolescenti, interminabili; i pochi adulti rimasti in paese: alla cantina, a fare a carte o a morra e, alla sera, padri padroni, ma non dei fumi del vino, a picchiare moglie e figli, “che se non bevevi e non picchiavi la moglie non eri uomo!”; gli altri, la maggior parte, quelli che non erano uomini, lontani da casa, a guadagnarsi il pane per la famiglia.
–Luogo: una via, uno spiazzo di quartiere.
–Partecipanti: ragazzi o giovanetti nel numero ideale di cinque, sei; in più o in meno, per dire che l’attività non prevede un numero fisso, consistendo il gioco nel fare ognuno per sé.
–Strumenti: un mattone pieno, una jòca ( un mattone più sottile con gli spigoli arrotondati) per ciascun giocatore, monete, tutte dello stesso valore.
-Svolgimento:
– alla distanza di una quindicina di passi si colloca il mattone, che da questo momento diventa e viene chiamato il Markĕ ( il Re ), la faccia minore rivolta al cielo;
-su di essa si mettono tante monete, del valore stabilito in precedenza, quanti sono i
giocatori ( al tempo in cui l’ho praticato, pochissime volte, chi te li dava soldi? era il soldo, appunto, la moneta da cinque centesimi o, al massimo, la nĕchella, i venti centesimi di nichel, a costituire la posta ).
-Si stabilisce, facendo a tocco, cioè alla conta, l’ordine di tirata della joca; quindi il primo giocatore la getta facendola strisciare fino a colpire, il meno violentemente possibile, Sua Maestà il Markĕ ( un colpo violento farebbe schizzare lontano le monete); tutte quelle che si ritroveranno, misurando dalla joca, dentro la distanza stabilita in precedenza: un palmo, o un furchio ( la distanza tra il pollice e l’indice distesi) o, comunque, una lunghezza fissa per tutti, tipo un fuscello, costituiranno la vincita; il tiratore le raccoglie e le intasca.
Poiché non tutte le monete saranno state alla portata del fortunato primo tiratore; spetta al secondo avvicinare la joca alle monete rimaste sparse intorno al Re; le farà sue con la stessa procedura. Si va avanti così fino all’ultimo partecipante. Se restano ancora delle monete, si procede a un nuovo giro, rincominciando dal primo tiratore, fino a che il Malku non veda distribuite tutte le tasse, ricevute in precedenza dai suoi amati sudditi a titolo di donazione. Generosa Sua Maestà. Con un nuovo tocco si dà inizio a una nuova partita.
Il colpo da maestro è quello in cui si fa arrivare la joca con la spinta necessaria solo a far sì che il Markĕ, toccato, rovesci sulla joca tutte le monete della posta.
Questo il gioco. Lo scopo dell’articolo tuttavia è un altro, come avrà ben intuito quel lettore curioso che si sia interessato ai precedenti miei articoli, dallo stesso tenore, comparsi sulle pagine di questa testata: dimostrare, checché ne pensi lo scettico, che nella Marsica, ci sono voci semitiche, accadiche, provenienti da quel Vicino Oriente che è stato, per l’Occidente, culla della civiltà e della scrittura, ‘farmaco della memoria e della sapienza’ ( μνήμης τε γàρ καì σοφίας φάρμακον. Platone, Fedro,274e). E se parole di origine semitica si ritrovano al mio paese…, perché non in Italia e nel resto dell’Europa? Basta volerle cercare e… disposti ad ammetterlo! Io trovo, ad esempio, che il nome Cechia, Repubblica, tra il mondo slavo e il mondo germanico, definisce la sua posizione di “terra di confine”: da accadico eku (‘boundary ditch, plot surrounded by a dike’.); come Via della Cecòla, che trovo scritta nel catasto di Lecce del 1736 a p.148, ed è sul crinale a strapiombo, a confine con il Fossato, sotto Porta Caiola ( a ridosso delle mura; Francesco Milani vi possiede un orticino) e, ancora, che trovo scritta nel catasto del 1754 p.530; “ Lorenzo di Antonio Borza, pecoraro, di anni trenta, possiede un’Orticino (sic) nel luogo detto la Cecola di puggelli uno giusta li beni di Giovanni di Domenico Borza e di Antonuo Borza”. Cecola, da accadico (ša pron. dim. quella) eku e accadico elû alto; Caiola sem.: ebr. gaj, valle, terra bassa e accadico elû alto; la porta principale in alto, a strapiombo alla terra bassa, altro che bassa!, del vallone.
Cosa diversa è parlare dell’origine del linguaggio, che lasciamo agli scienziati, ai neuroscienziati, agli studiosi.
Fare a erma è fare a nasquĕnnarella ( nascondino). Si è fatto a erma, da accadico erēmu, coprire, nascondere ( eremita, mica è accadico?) a Vallemora di Lecce, vicino a Capranica, da accadico kapru villaggio, maniero, ‘certo mal definito insediamento rurale’ ( Oppenheim, A.L., l’antica Mesopotamia, ritratto di una civiltà, newton compton editori, dic. 1980, p.108. ) fino agli anni sessanta del secolo scorso; a topatòpa è ugualmente fare a nascondino con la differenza che mentre a erma ciascuno cerca un nascondiglio solo per sé, qui a topatòpa, giocano due squadre ad una delle quali, raggruppata in un nascondiglio, i componenti dell’altra, danno la caccia; topatòpa da accadico tappûtu, comunità, società (raggruppamento).
Buon Fare a Mar(l)kĕ, nell’imminente giorno di festa dei tre Malki: Gaspare, Melchiorre, e Baldassarre che vanno a Bethlehem… Bethlehem: confronta con accadico bētu, casa e accadico lā’ium potente, valente ( forse perché sede di casa reale…), ebr. le’ōm (popolo).
NOTICINA: Giacché i MALKI me lo suggeriscono, giro il loro invito a leggere, “LA FREDDA CAPANNA”.