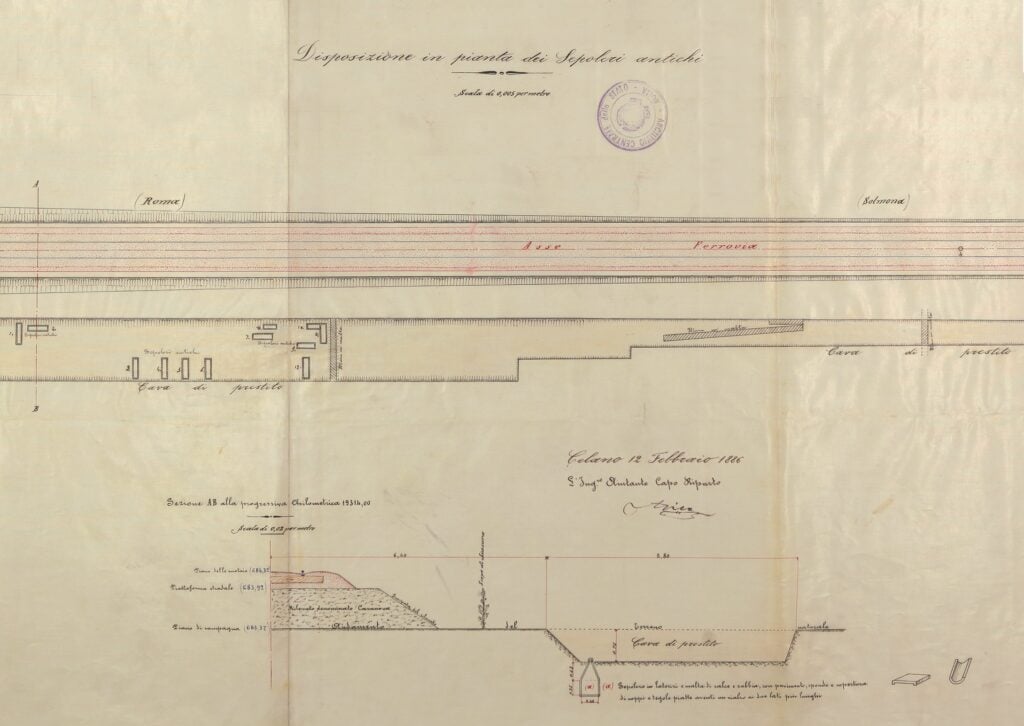Opi – Gli insediamenti appenninici Alto-medievali rego, più o meno temporanei, nel X secolo erano rilevanti. Un gran numero di comunità montane si insediarono tra il Velino e il Sirente, lungo il percorso dell’antica via Numicia o Minucia o via degli Abruzzi, che attraversava l’odierna Roccapia (a quel tempo chiamata Roccavalleoscura e dopo qualche tempo, Rocca Letizia) e la valle del Sagittario per raggiungere Scanno, Castrovalva, Frattura, Villalago, poi il piano delle Cinquemiglia. Occorre attendere il X secolo per avere una rinascita urbanistica e demografica della zona dell’Alto Sangro, ma anche nella valle dell’Aterno e nella conca di Sulmona.
Solo nel XV secolo, gli insediamenti alpestri lungo il fiume Sangro prosperano, mentre altri, come Rocca Intramonti (che successivamente darà origine a Civitella Alfedena), e un insediamento medievale nell’area del Gran Sasso, come Castel del Monte e Calascio, sono altrettanto significativi.
L’alto Sangro ha sempre rappresentato una zona di frontiera, pronta allo scambio e al commercio. Ruolo fondamentale è quello rappresentato dalla pastorizia, con l’economia socio-economica del Tavoliere e quella politico-culturale con Napoli.
Le consuetudini feudali rimangono radicate nei Feudi (Università- Comuni), ed è assai evidente la vocazione pastorale della zona dell’Alto Sangro sotto il dominio degli Aquino, Davalos. Nel territorio di Pescasseroli, secondo Benedetto Croce, una economia florida, arriverà solo a metà del Cinquecento.
Secondo il Febonio: “quelle montagne durante il calore dell’estate, prati verdeggianti e spruzzi di fresca acqua zampillante, prima che l’appressarsi dell’inverno le faccia trasferire in Puglia”. Perciò le consuetudini feudali rimangono, come a Opi, dove ancora a metà del Settecento, con la presenza dell’allevamento e della transumanza, vigeva il diritto baronale della pecora, del puledro e della vitella: il tutto per soddisfare i Baroni. D’Andrea sostiene che la nascita di Barrea si fa risalire sempre nella prima metà dell’XI secolo, vista la presenza di elementi come Sant’Angelo in Barreggio, con il cosiddetto Studio e il Castello Feudale.
Villetta Barrea a fine Seicento dovette nominare un prete cancelliere perché in questa Università non si trovavano uomini abili per la cancelleria (contabilità) visto che tutti, o quasi, si trovavano in Puglia con le pecore, mentre a Roccaraso tale compito era esercitato dalle donne: lo spopolamento invernale creava conseguenze anche nel campo della società e del costume.
Nel Quattrocento, in seguito ai terremoti, una parte degli insediamenti del Sangro furono abbandonati come Rocca Intramonti, oggi Civitella Alfedena, innanzi citata.
“È la centralità dei paesi dell’Alto Sangro rispetto al tutto il loro territorio – secondo Uberto D’Andrea – a farci pensare a tante ragioni economiche le quali suggeriscono la scelta del sito… Barrea, Alfedena ed Opi, per la vicinanza alle macchine idrauliche (i Mulini) e per una conveniente accessibilità al Tratturo (Pescasseroli-Candela), dove stavano anticamente gli abitati di Castel di Sangro, Alfedena-Scontrone, Barrea, -Villetta Barrea, Civitella Alfedena ed Opi e Pescasseroli”.
Benedetto Croce ha fornito una ricostruzione esemplare di queste comunità appenniniche col saggio su Montenerodomo tra l’Aventino e il Sangro, continua dicendo che “la vita pastorale intorbidiva o danneggiava l’accrescimento della popolazione… l’apprendimento di legge e dello scrivere”.
Un esempio diverso a Lecce nei Marsi dove l’eccezionale demanio boschivo consentiva il rifornimento della legna e carbone in tutta la Marsica, quindi la pastorizia transumante interessava una minoranza della popolazione. Al contrario, a Opi, fa da traino la Transumanza, pur avendo molti demani boschivi, mentre a Pescasseroli, continua il Croce, caposaldo di uno dei maggiori tratturi, “prevale la pastorizia”.
”Gli uomini di questa terra tutti vanno in Puglia et non ci resta se non alcuni vecchi e donne”. A Pescasseroli gli avi di Croce, i Sipari, a metà del Seicento, fanno valere l’attività commerciale con la vendita delle pelli (le cosiddette “basette”) e con le loro proprietà agricola nel Tavoliere, prendono il comando del paese.