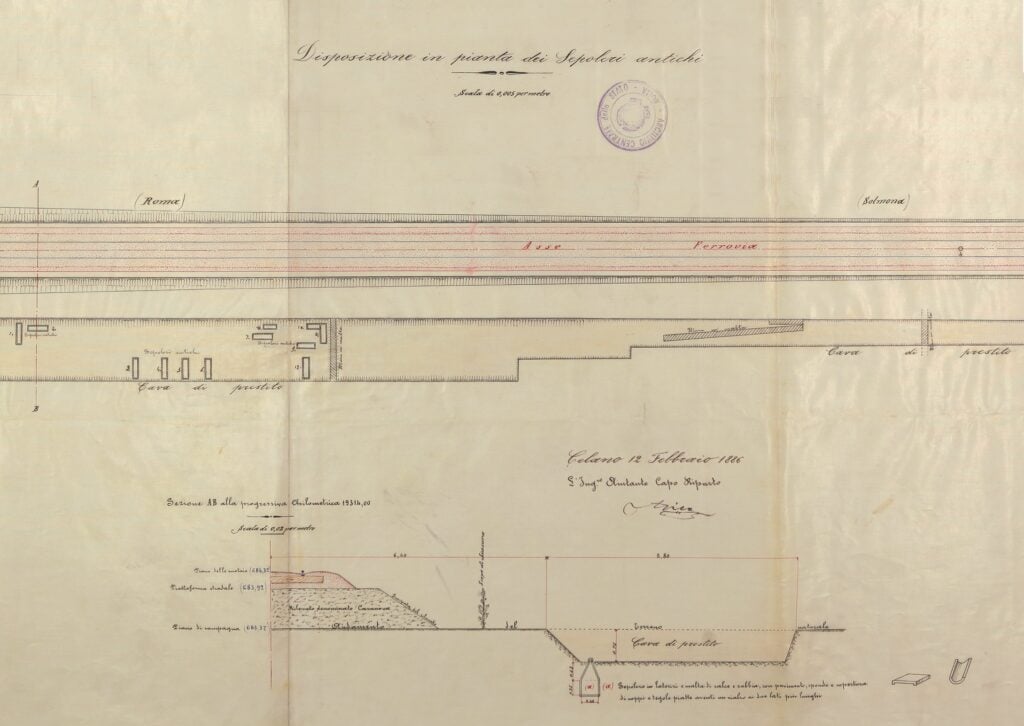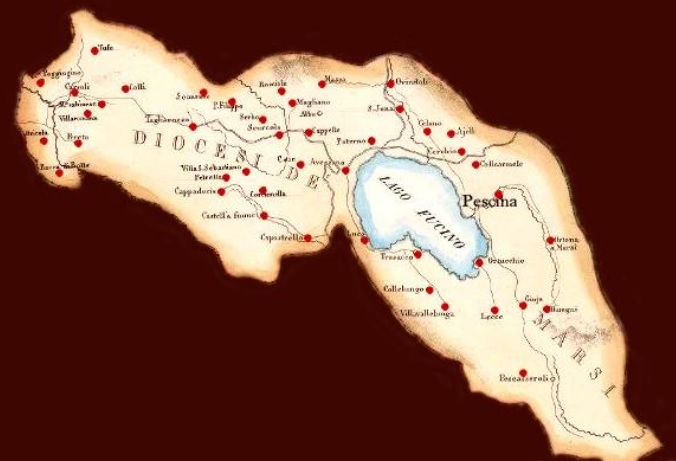Gabriele De Rosa, uno dei maggiori esponenti della storiografia socio-religiosa evidenziò, con un’attenzione pregevole, la vita dei vescovi delle diocesi meridionali tra sinodi, visite pastorali, relazioni ad limina, benefici parrocchiali e intrecci patrimoniali con le famiglie locali delle chiese ricettizie (1).
Senza alcun dubbio, lo studio di documenti parrocchiali, dei sinodi, degli atti notarili ed ecclesiastici, delle visite pastorali rimane ancor oggi il presupposto necessario per impostare anche la storia della spiritualità marsicana. Questi atti formano un complesso di fonti omogenee preziose per una ricerca a tutto campo non solo della vita ecclesiastica ma anche di quella morale, dei costumi, delle tradizioni locali e della lingua. A partire da questi rilievi, la critica moderna ha spesso rilevato i contrasti fra una chiesa tesa alla riforma religiosa e morale del clero e dei fedeli e un’altra legata alla feudalità, con la gestione di ingenti patrimoni gestiti da vescovi spesso ridotti a estensori di inventari di beni, dalla mentalità notarile e fiscale. Vicende, dunque, di strutture religiose (come afferma lo studioso Tullio Gregory) nella loro: «continuità ma anche nella loro discontinuità in rapporto alle condizioni di vita reale e a strutture economiche e civili estremamente variegate ove vita religiosa e vita sociale si intrecciano nelle loro tensioni» (2).
Tutto questo ed altro non scoraggiò il vescovo Lorenzo Massimi che, in mezzo a gravi difficoltà logistiche, continuava la sua intensa attività pastorale. Due sue relazioni misero in risalto la mentalità contadina vigente nel Seicento, caratterizzata da: «una cultura essenzialmente religiosa (spesso, una contaminazione di elementi cristiani ed elementi pagani), un misto di religiosità ortodossa e di istintiva superstizione, fatto di gesti, suoni, ritmi, formule e scongiuri, tendenti ad esorcizzare il male e, per contrasto, ad invocare il bene» (3). Durante la visita pastorale del 1638 fatta al piccolo borgo di S.Sebastiano, il presule rilevò parecchie infrazioni: «In primis. Il gioco delle carti tam in festo quam in die feriato. Il magnare al Hosteria tam ante quam post missam in diebus festivis. Il non pagare le Decime sacramentali. Il portar le donne e figlioli le reliquie senza alcuna reverentia. Il pigliar le candele nella Candelora a due chiese in magna quantità. L’andar le donne piangendo appresso ai defunti» (4). A Lecce nei Marsi e casali, invece, fece affiggere un editto con obbligo di leggerlo ogni domenica in chiesa da parte dell’arciprete (considerando l’analfabetismo vigente): «Essendosi per Noi fatta visita generale, e ritrovato che molte persone dell’uno e l’altro sesso così grandi, come piccole siano morte senza ricevere li SS.mi Sacramenti della Confessione, Comunione, et Extrema Untione nelli Casali di Lecce, senza probabile argomento della dannazione dell’anime loro, come fossero stati Turchi, o Heretici, per l’avvenire debbiano quelli, che cascano infermi fra ventiquattro ore, et le donne che traseno nel mese del parto, ritirarsi subito dentro la Terra di Lecce ad effetto di ricevere li Santissimi Sacramenti, sotto pena di docati sei per ciascheduna volta, da esigersi inviolabilmente contro quelli che contravverranno, e d’applicarsi a nostro arbitrio a luoghi pij, et quelli, che moriranno in detti Casali, senza li Sacramenti, debbano essere seppelliti nella campagna, e non possano entrare nelle mura della Chiesa di Lecce, dove li loro corpi saranno vessati dalli diavoli; et così dicemo, et ordiniam; et acciò che nessuno possa allegare ignoranza volemo che il presente editto sia pubblicato in Chiesa ogni Domenica dopo l’Evangelio, et affisso alli luoghi pubblici. Lorenzo Massimi per la Dio gratia, e della S.ta Sede Apostolica, Vescovo di Marsi» (5).
Tra le molteplici situazioni, siamo in grado di conoscere, attraverso la consultazione del «libro dei Matrimoni», un fatto singolare: quello di un matrimonio celebrato il 24 ottobre 1624 in un palazzo nobiliare. In base ai dati disponibili, il documento risulta particolare e ci mostra un’altra faccia della vita sociale e religiosa nella diocesi: «Io, Don Ettorre Matthei ho contratto il matrimonius per verba de’ presenti Usus et Volo conforme il Sancte Concilio Tridentino, et rito Santa Chiesa, tra Francesco Spina di Tagliacozzo, et Madonna Cassandra Orlandi d’Avezzano, nella casa del Dottor Marco Antonio Orlandi con licenza del reverendissimo et del Signor Abate, presente il Dottor Giovanni Minicucci et il Notar Domenico De Bucci et Sebastiano Liberatorio». Certamente, per capire meglio la mentalità del tempo, occorre consultare anche i «processetti matrimoniali», che talvolta spiegano meglio le dinamiche delle autorità civili e clericali. Nel nostro caso, l’abate della Collegiata di San Bartolomeo, approvò a livello quasi microstorico, quel difficile complesso di leggi che introduceva altre possibili norme generali nello specifico contesto locale. Tuttavia, a proposito di questo matrimonio celebrato in casa di persone altolocate, potrebbe sembrare che il «modus procedenti» dei notai del vicario e delle parrocchie non fosse una costante essenziale e tardò a conformarsi in un sistema organico come modello unitario di riferimento (6). Tra il 1702 e il 1708, di nuovo si moltiplicarono i reclami del vescovo Corradini riferiti a illegittime occupazioni di terreni appartenenti all’Episcopio marsicano ad opera di possidenti del luogo favoriti dalle autorità municipali. Costoro, spesso cercavano di screditare il clero zonale con lettere anonime indirizzate al papa e al viceré, tra cui citiamo un breve monito della seguente missiva: « […] In Alcune feste che si fanno nella nostra Diocesi, e massime alla Pentecoste, e al SS.mo Corpo di Gesù Cristo, si spendono molti denari nelle Panarde con ubriachezze, et altre indecenze, e con l’accesso [la partecipazione] dei secolari dell’uno, e dell’altro sesso, non senza scandalo, e offese a Dio». Il presule, a dispetto dei maligni e per stemperare simili accuse, concesse l’indulgenza plenaria (23 aprile 1710) a tutti coloro che avessero visitato la chiesa parrocchiale di Trasacco, partecipando alla comunione generale (7).
NOTE
- G.De Rosa, Vescovi popolo e magia nel Sud. Ricerche di storia socio-religiosa dal XVII al XIX secolo, Guida Editori, 1971. Le chiese «ricettizie» erano quelle erette in ente morale, originariamente poste sotto il patronato del comune o delle famiglie che l’avevano fondata, dotate di patrimonio privato.
- T.Gregory, Per la storia del vissuto religioso. Gli scritti di Gabriele De Rosa, Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee. Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1991 (ILIESI, CNR), p.24.
- A.Melchiorre, La discesa al «Mondo Infero» nelle cultura popolare degli Abruzzi, Penne 1987, p.41. Il compianto studioso marsicano, conferma appieno le tesi di Gabriele De Rosa.
- Archivio Diocesano dei Marsi, Fondo B/I/3, Anno 1638, Visita pastorale.
- A.D.M., Ivi.
- Archivio Parrocchiale Cattedrale Avezzano, Matrimoni, Anno 1585-1635 (vol.VI), Anno 1636-1680 (vol.VII). Marco Antonio Orlandi, dai rogiti del notaio Domenico Bucci di Avezzano, risulta essere un ricco benestante. Nel 1655 aveva rapporti d’affari con il monastero di S. Bartolomeo di Trisulti, con la confraternita del Monte di Pietà di Celano e con la cappella degli Orlandi posta nella chiesa di S.Francesco (Avezzano).
- Archivio Parrocchiale di Trasacco, Editto del 27 maggio 1705, in De Gasperis Bartolomeo, Rogito III, ff.4-5. Cfr. Archivio Diocesano dei Marsi, Pergamena del 23 aprile 1710 di Papa Clemente XI, Anno X, Serie 4/T.