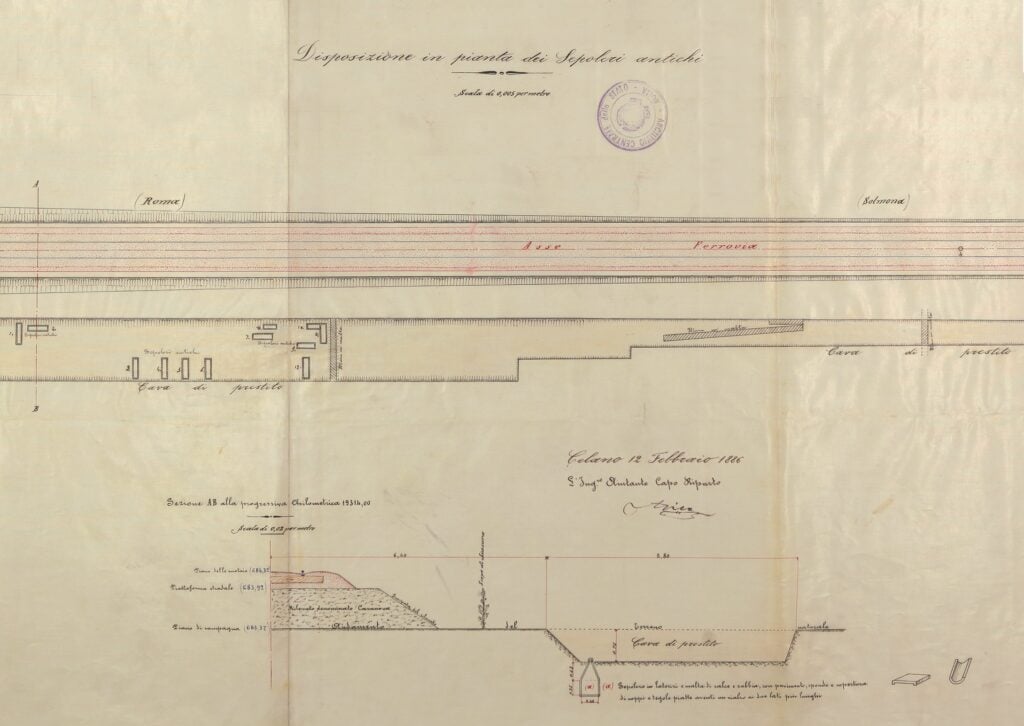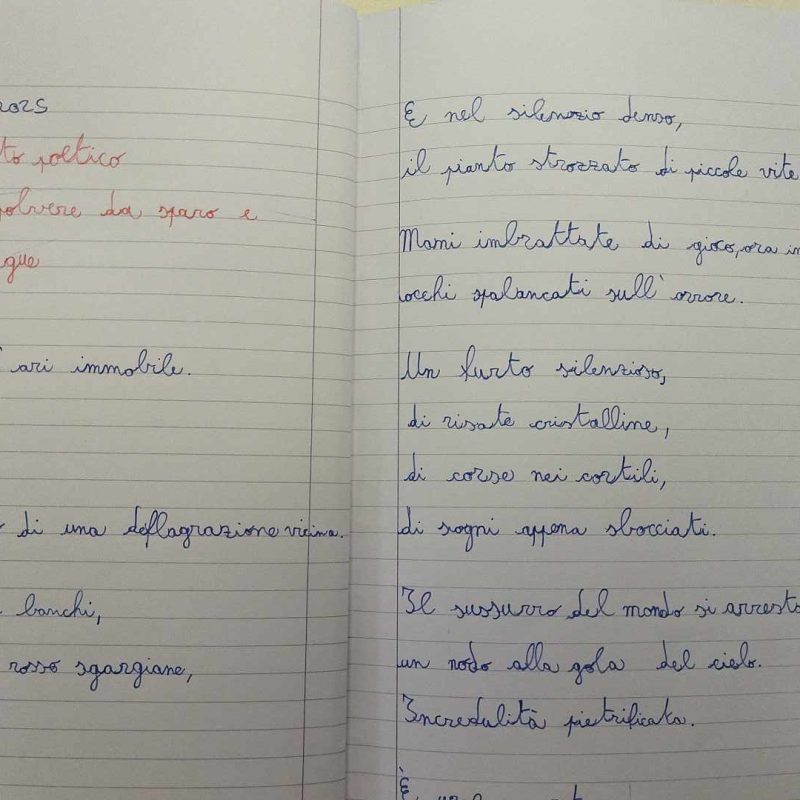Ignazio Silone, pseudonimo di Secondino Tranquilli, nato a Pescina il 1° maggio 1900 e morto a Ginevra il 22 agosto 1978, è ricordato soprattutto come narratore, giornalista, politico, saggista e drammaturgo italiano legato all’ideologia marxista.
Eppure in tutte le varie fasi della sua vita sia privata che pubblica, sia civile che culturale fu sempre animato da una vena poetica lucida, sotto certi aspetti profetica e mai lascivamente romantica, a molti ignota. Nella sua espressione letteraria le parole erano sempre collegate agli oggetti reali ed alle persone concrete. “Quello che mi interessa sono i rapporti tra le cose, i rapporti in cui le cose si rivelano e attraverso i quali esse tengono e formano il mondo” scriveva a Rainer Biemel che gli chiedeva di esporre il proprio pensiero sull’arte.
Contro l’idea crociana dell’arte come intuizione, Silone sostiene che la creazione artistica ha la funzione naturale e spontanea non solo di rispondere al bisogno di sincerità e di verità ma di costruire la speranza di un riscatto etico e sociale. La denuncia della condizione di povertà, ingiustizia e oppressione delle classi subalterne si unì sempre ad una sensibilità evocativa di immagini e sensazioni liriche connesse, nel lascito cristiano, al laicismo contemporaneo. Il romanzo “Severina” pubblicato postumo nel 1981, curato dalla moglie Darina, nel manoscritto porta il titolo di “La speranza di suor Severina” per far riferimento ad una virtù di resistenza nella lotta per i diritti. Pertanto il verso di Charles Pégury, con cui si apre “Le porche du mystère de la deuxième vertu” si fa epigrafe ideale della Speranza di suor Severina.
Silone non ha sistemato il suo pensiero artistico in una compiuta teoria filosofica, né in un disegno solo politico di emancipazione sociale ma ha conservato in tutte le sue opere l’eticità dell’artista che ha il compito di affermare la totale libertà dell’individuo a patto di non servire altra causa che quella della verità. Ogni scrittore al di là dell’ideologia, del suo status-economico o del grado di istruzione, ha il dovere morale di esprimere con la propria voce il mondo terrestre legato al luogo dove si nasce. La narrazione per adempiere alla funzione di risvegliare le coscienze al fine di trasformare la realtà dei fatti deve essere connessa agli interessi e ai sentimenti delle persone. Lo scrittore deve essere appassionato e sincero. E tutto ciò non per una letteratura individualistica e rivolta solo agli intellettuali ma per ristabilire l’autenticità di una scrittura utile all’uomo concreto perché nata dall’esperienza vissuta. Tesi questa opposta all’estetica di Benedetto Croce che fonda l’autonomia dell’arte svincolandola dall’utile, dal vero e dal bene. Al centro dell’interesse siloniano c’è la condizione empirica dell’uomo nella comunità a lui contemporanea.
Proprio perché ognuno di noi porta con sé una “Contrada” intesa come paese d’origine, può richiamare la coscienza di tutti alla responsabilità civile in ogni luogo e in ogni tempo. Al di là di latitudini e meridiani il suo capolavoro ”Fontamara” ambientato, dice Silone, “in un antico e oscuro luogo di contadini poveri situato nella Marsica” diventa emblema della condizione di alienazione che attanaglia i poveri in ogni parte del mondo. Quando il lirismo del nostro Ignazio, talvolta, emerge nelle sue prose commuovendo l’animo del lettore trascina sempre verso un’empatia suscitata dall’umiliazione della dignità. Pertanto la sua ricerca spirituale si fa riscoperta della parola nei suoi valori essenziali. In una vocazione insieme laica e religiosa, Silone si identifica nel libro” L’avventura d’un povero cristiano” nel protagonista Celestino V, che non tradisce la fede con un vile rifiuto del seggio papale, come scrive Dante, ma che, nella difesa degli ultimi, non si sottomette né al potere temporale né a quello religioso. Anche se denuncia i dolori e le ingiustizie soffermandosi nelle sue opere nella misera condizione esistenziale dei “Cafoni”, Silone non cede mai alla rassegnazione. Del resto come dice un vecchio proverbio dalle nostre parti, perdere la speranza significa perdere tutto. Il senso amaro della realtà si unisce sempre alla fantasia e al mito che fanno della parola riscoperta della qualità della vita di ogni uomo. Silone è affascinato dal sentimento, proprio come tutti i poeti, ma lo analizza nei suoi effetti culturali, relazionali, privati e pubblici evidenziandone la nobiltà e nel contempo invitando tutti a prenderne coscienza per vivere in armonia con gli altri nella giustizia sociale.
Mi sia concesso, a questo punto, evidenziare il rapporto di profonda stima e di onesta collaborazione intellettuale tra lo scrittore francese Albert Camus e il marsicano Ignazio Silone per la sensibilità con la quale si approcciavano entrambi alle tematiche sociali. Recensendo “Fontamara” Camus, scrive: “Se la parola poesia ha un senso, è qua che la ritrovi, in questo spaccato di un’Italia eterna e rustica, in queste descrizioni di cipressi e di cieli senza eguali e nei gesti secolari di questi contadini italiani”.
All’annuncio dell’assegnazione del Nobel per la letteratura, Albert Camus dichiarò: “A meritare il Nobel, era Silone. Silone parla a tutta l’Europa. Se io mi sento legato a lui, è perché egli è nello stesso tempo incredibilmente radicato nella sua tradizione nazionale e anche provinciale”.
Al pari di Camus, Silone amava l’essere umano più di ogni altra proiezione ideologica e soprattutto si batteva per la libertà assoluta che è: “la possibilità di dubitare, la possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare, di sperimentare, di dire no a una qualunque autorità letteraria, artistica, filosofica, religiosa, sociale e anche politica”. Il messaggio rivoluzionario di Silone, proprio come quello di Camus, illumina di intrinseco valore l’uomo e la sua anima. Entrambi si interessano di uomini nudi che consapevoli della loro emarginazione cercano il riscatto nella speranza senza compromessi. In tal senso il loro essere autentici li avvicina a Pirandello: “In certi momenti di silenzio interiore, in cui l’anima nostra si spoglia di tutte le funzioni abituali, e gli occhi nostri diventano più acuti e più penetranti, noi vediamo noi stessi nella vita, quasi una nudità arida, inquietante” (Pirandello, L’umorismo, 1908).
Tornando al nostro Silone si può sostenere l’universalità della sua poetica aperta alla tolleranza e alla solidarietà, nella ricerca dell’uguaglianza e della pace sociale. L’arte di scrivere in Silone si fa verbo che non sacrifica l’autobiografia per diventare parola del cuore ed insieme della mente. E’ proprio nell’aver unito in un binomio del vissuto empirico prosa e poesia, ragione e sentimento, o con un’espressione leopardiana, pensiero poetante e poesia pensante, la grandezza di Silone. La sua opera, definita scrittura del meridione, è un’opera d’arte perché riesce ad unire il locale all’universale nella metafora perennemente attuale dell’esistenza.
Lasciatemi concludere con delle riflessioni in versi di Giuseppe Rizzi che leggendo Fontamara ne fece una traduzione poetica testimoniando l’esistenza di emozioni e sensazioni capaci di motivare alla speranza in un avvenire migliore per tutti.
Non leggete Fontamara!
Non leggete Fontamara!
E’ un romanzo troppo vero e ancora attuale.
Non leggete Fontamara!
Non riuscirete a liberarvi del suo ricordo.
Non leggete Fontamara!
Ignazio Silone è uno scrittore
Tra i più grandi del 900 europeo.
Non leggete Fontamara!
O vorrete combattere le
Ingiustizie nella vita d’ogni giorno.
Non leggete Fontamara!
Perché Berardo Viola vive,
I morti siamo noi.