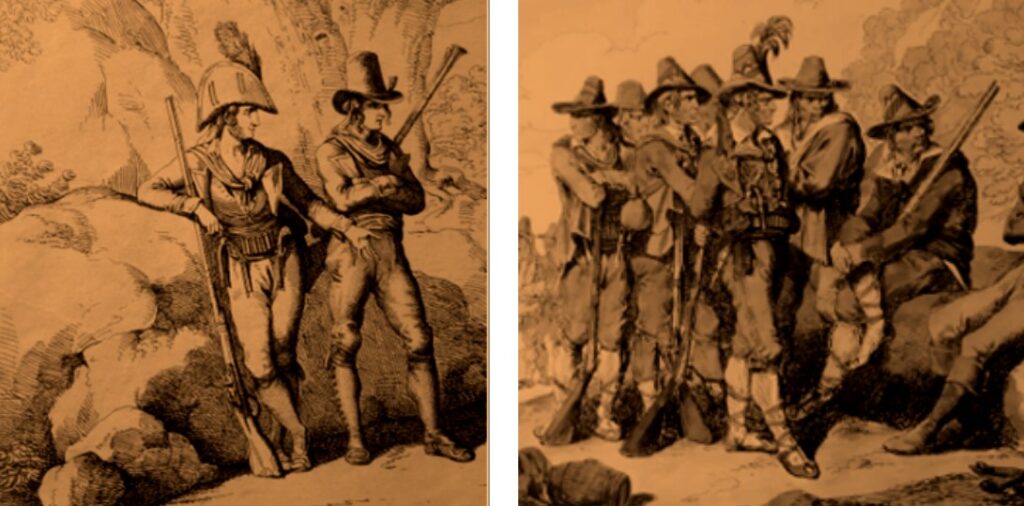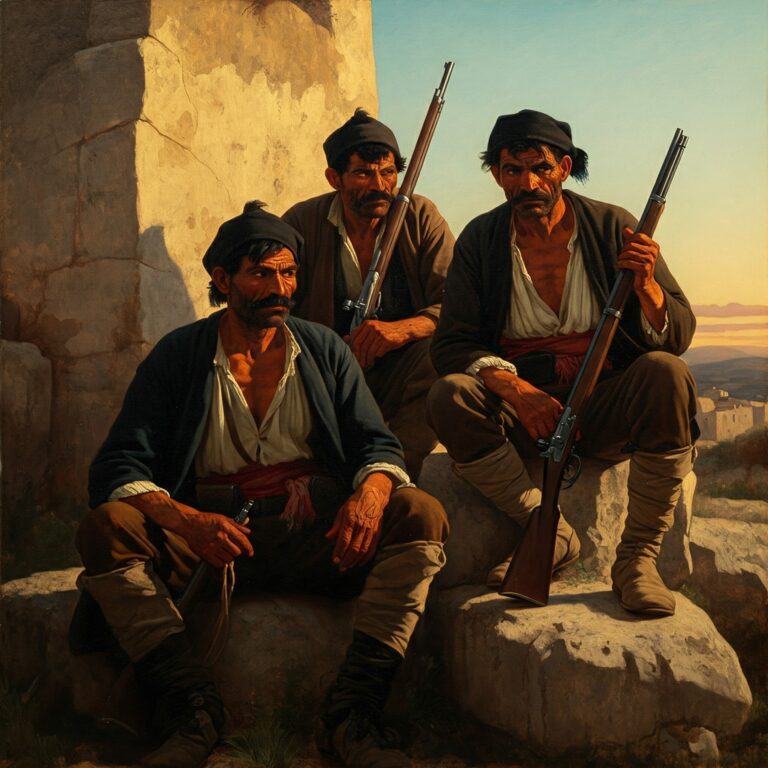La Musica non riconosce passaporti
Jacopo Sipari di Pescasseroli alla testa della Haifa Symphony Orchestra, formazione che raccoglie rappresentanti di diverse, grandissime “scuole”, trionfa presso l’Herlzliya Center of performing Arts insieme alla violinista Abigeila Voshtina, per il concerto di Max Bruch e la seconda sinfonia di Sergej Rachmaninov
Rubiamo il motto della violinista Abigeila Voshtina, allo scopo di immaginare un titolo per il concerto della Hajfa Symphony Orchestra, formazione che raccoglie l’essenza di scuole diverse, archi russi, tra i quali alcuni provenienti dalla corte dello “Czar” Valery Gergiev in San Pietroburgo, altri appartenenti all’altissimo magistero ebraico, atanor dei massimi violinisti sfornati sino al duemila, sino alla bellezza del suono del corno inglese, proveniente dalla Cleveland orchestra o un ritrovato contrabbasso albanese, la perfezione assoluta del piattista o l’intensità evocativa del suono del corno, protagonista del quarto dei grandi appuntamenti con il sinfonismo, per la XXI stagione in corso all’ Herlzliya Center of performing Arts. Un invito, rivolto al direttore abruzzese Jacopo Sipari di Pescasseroli e alla violinista albanese Abigeila Voshtina da Amos Talmon: un ritorno sia per il maestro italiano, il quale nel 2019 ha diretto in Tel Aviv la Israel Symphony Orchestra, che per la Voshtina, la quale si esibì in concerto al Santo Sepolcro, vent’anni fa con l’orchestra del teatro alla Scala. Programma tardo-romantico, quello confezionato per questa prestigiosa occasione, a cominciare dal Concerto in sol minore per violino e orchestra n. 1, op. 26 di Max Bruch.
Intonazione sempre immacolata, quella di Abigeila Voshtina e del suo Dante e Alfredo Guastalla del 1936, la sinistra che vola senza fallo e senza fatica, suono limpido, caldo e omogeneo in tutte le stesure, arco iperabile, dal legato ai colpi d’arco staccato, un vibrato non molto stretto, straordinariamente vario e che “corre” sino all’ultimo scranno della sala, per un’esecuzione respirata, ardente e ad altissima tensione, senza alcuna caduta del flame, in empatia con l’orchestra e, in particolare, con il direttore Jacopo Sipari, che ben conosce. Eloquio asciutto di entrambi, dalla cadenzina d’entrata al tema principale, strabordante di passione, ma dal violinismo controllatissimo, quindi la velata, incantatoria intimità del tempo lento e in punta d’incisore, sino alla chiusura dal pathos forte ed estenuato, dalla grande trasparenza e dal lirismo e nerbo nei passaggi virtuosistici, come un meccanismo di precisione.
Applausi scroscianti e dopo tanta tensione, il Johann Sebastian Bach della Courante della I partita in Si minore BWV 1002, che si è estesa nella più filosofica serenità, frutto, nella sua semplicità, di una disciplina tecnica e ritmica senza eguali, per la durata delle note, nelle quali si richiede la più stretta osservanza della conduzione delle parti, del tempo, dei valori relativi e, naturalmente, del ritmo. Ma, di tutte queste qualità, quella che maggiormente domina, è il senso della forma, della struttura, della proporzione. Bisogna graduare i punti più importanti: se ve ne sono molti, è spesso necessario decidere quale sia quello principale, senza mai perdere di vista le difficili esigenze di una struttura equilibrata.
Alla musica di Bach, bisogna, inoltre, accostarsi con uno stile molto particolare, mai l’esecutore dovrà suonarla per compiacere soltanto se stesso. Certamente lo fa, ma solo ad un livello molto, molto alto: partecipa alla musica con il suo spirito e le sue emozioni, eppure deve cercare di eliminare tutte le impurità spirituali ed emotive. Un Bach questo proposto dalla Voshtina, che si è collegato idealmente, ma la musica resta una catena senza soluzione di continuità, al III movimento della seconda sinfonia in Mi minore di Sergej Rachmaninov, un Adagio, in cui abbiamo percepito, attraverso la bacchetta del Maestro Sipari, la sua grande rassegnazione, unitamente, però, alla forte volontà di unirsi a Dio, in assenza, nei confronti, di una pagina indiscutibilmente “bella”, di orgoglio e retorica, ma letta con profonda umiltà e rispetto. Una compresenza, questa che è qualcosa, forse, di perduto ai tempi nostri, perché noi consideriamo tali sentimenti come antagonisti ed escludentisi l’un l’altro: ma essi non lo sono e non dovrebbero esserlo. Per essere più precisi il Maestro Sipari ha controllato l’uso di vibrati eccessivi, e, contemporaneamente, ha spinto l’orchestra verso una qualità simile alla voce umana, attraverso una conduzione pura e chiara, con attenzione ai singoli strumenti, che vanno a comporre il misterioso universo del genio russo.
Ha dominato un climax schiacciante nel I movimento, mentre il Maestro Sipari ha mantenuto il finale ben mosso, in cui siamo riusciti a leggere la stessa ossessione che penetra la gremita scrittura pianistica del compositore, quasi a rivelare la presenza di un inquietante, nevrotico fantasma da cui è difficile liberarsi. È proprio questo aspetto che ha mosso la lettura del maestro abruzzese, mai condiscendente alla facile seduzione melodica, che sotto la pulsazione della sua bacchetta è riuscita ad allargarsi fino ad una tensione spasmodica, in ondate di suono, avvolgenti. Intensità emotiva, certamente, per Jacopo Sipari che ha trovato nella Haifa Symphony Orchestra, chiarezza ed eleganza, sufficienti ad evitare ogni deriva melensa, in cui è fin troppo facile cadere con Rachmaninov, unitamente ad un mondo di colori caldi, e tendenzialmente scuri, ovvero la tavolozza di un’espressione, per così dire, antica che si è rivelata molto congeniale all’approccio introspettivo proposto dal direttore italiano. Abbraccio calorosissimo dell’esigente pubblico che ha affollato la sala, diverse chiamate al proscenio, in preludio di un presto ritorno sul podio israeliano.