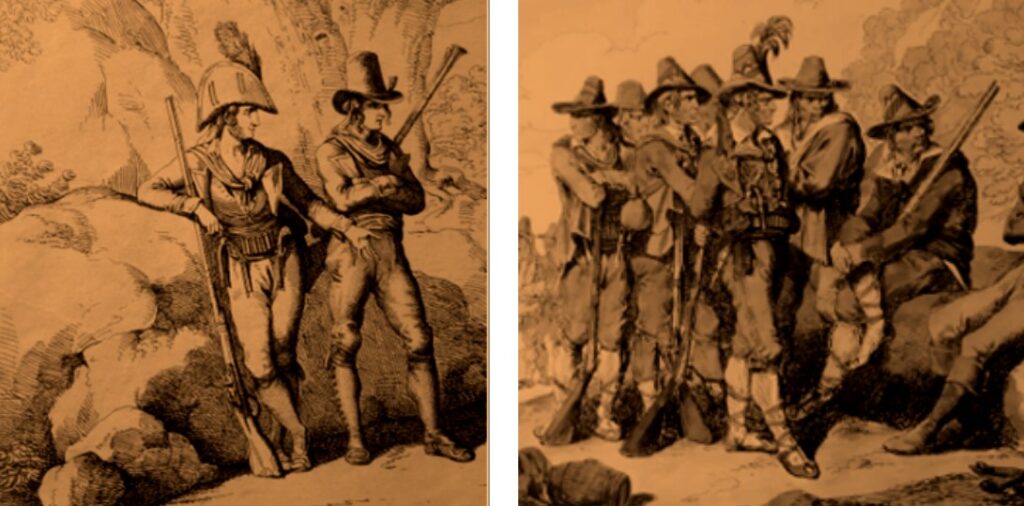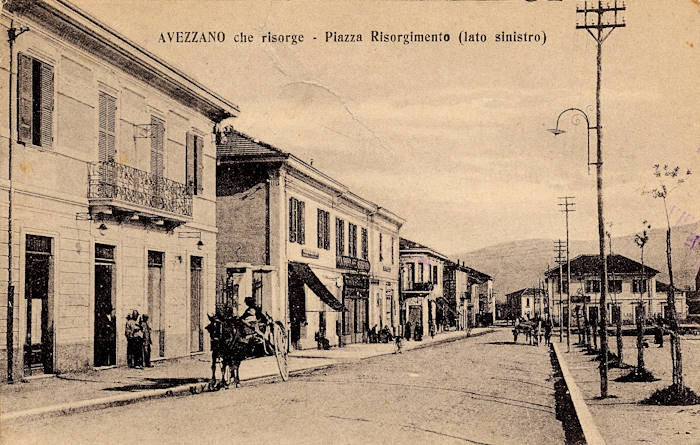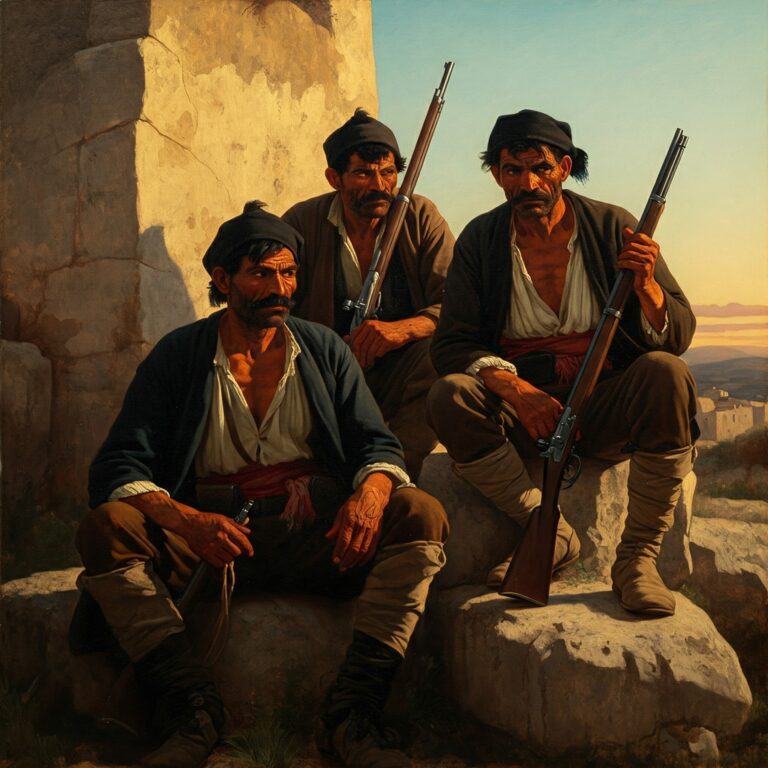Nell’ultimo quarto del secolo XVIII, la più efficace denuncia documentata dei mali che affliggevano ormai da qualche tempo la Marsica e le province periferiche del regno di Napoli, fu quella dell’avvocato Giuseppe Maria Galanti. Nell’introduzione alla «Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie», egli scrisse tra l’altro: «L’essenziale si è di conoscere le sorde cagioni de’ mali pubblici, e l’influenze delle cattive leggi e de’ cattivi costumi» (1).
Le sue minuziose indagini, sulle reali condizioni sociali ed economiche del territorio, furono svolte di persona visitando anche l’Abruzzo aquilano nel 1795. In particolare, egli toccò un problema non risolto che poneva il Mezzogiorno, come l’Italia tutta, in posizione di arretratezza nei confronti della cultura europea. Tuttavia, come vedremo, i tempi erano maturi per: «l’ampliarsi delle forme della socialità settecentesca, dovute all’estendersi del dibattito illuminista e le iniziative di riforma e di modernizzazione degli apparati amministrativi dello Stato da parte della monarchia borbonica» (2). L’opera coraggiosa dell’insigne giurista (come già rilevato da molti studiosi), occupa una posizione singolare nella storia del movimento riformatore degli anni precedenti all’invasione francese (1799-1806).
Come già rilevato, le vertenze giudiziarie tra il regio Fisco, baroni ed ecclesiastici «insieme a quelle, ugualmente continue e interminabili, tra baroni e università», si erano indebolite in condizioni di sostanziale tolleranza verso la sussistenza di abusi di ogni genere (3). Sicché, molti conflitti di competenza, aggravati dall’arroganza amministrativa in cui si disperdevano le migliori energie della magistratura, rappresentavano le vere sabbie mobili del riformismo «ferdinandeo». Per questo, il Galanti tra disordini, anomalie, ingiustizie gravi e palesi, ci mostra un popolo alla vigilia della rivoluzione senza una vera coscienza unitaria: «diviso da antagonismi di classe, da sproporzioni di ricchezze, da interessi provinciali e cittadini, senza neppure una di quelle passioni militari, religiose, politiche, che creano unità pur nella disuguaglianza, colmando questa nell’unità d’azione». Ancora una volta, i lunghi resoconti stilati in più tomi dal Galanti calzavano perfettamente alla grave congiuntura della popolazione marsicana (come stiamo vedendo), che non aveva ancora acquistato sicurezza in se stessa, perdendo ogni fiducia nel governo «che ha imparato a sentire come estraneo ed ostile». Infatti, la persistente arroganza dei feudatari e la prepotenza del clero (ritenuto parassitario), al momento dell’inchiesta del Galanti, avevano sopraffatto i disegni di riforma già avviati dal ministro Tanucci, laddove: «la forza del Governo è riposta in una burocrazia onnipotente e in una plebaglia favorita sol perché temuta» (4). In effetti, seguendo il tracciato di molti documenti, si evince uno stato di anarchia latente che favoriva un aumento di bande armate sui confini della Marsica (Forca Caruso, Colli di Monte Bove, Rocca di Mezzo, Monte Tranquillo, ecc.).
Ed è in questo senso che si devono anche intendere le severe direttive emanate dal Preside aquilano Carrascosa, riferite a «tutti i ladri, che scorrono la campagna». Per parte sua, il Tribunale dell’Udienza aquilana minacciò chiunque fosse sorpreso in campagna in atto di aperta ostilità, con lo «sterminio, anche con armar gente atta alle armi». Insomma, con vari dispacci, il capo della provincia permise a chiunque di intraprendere una caccia spietata contro banditi, delinquenti e malfattori alla macchia (13 giugno 1792). Giova a questo proposito citare le scorrerie di Domenico Occili e Pietrantonio Perna, che da mesi imperversavano sull’Altopiano delle Rocche con furti e rapine. Un gruppo di birri, comandati dal caporale Feliceantonio Dell’Oro e dal giudice sulmontino Don Serafino Arcieri, per ordine del governatore locale, si gettò sulle loro tracce senza ottenere, però, alcun risultato. Infatti, gli «scorridori di campagna» avevano già attraversato la frontiera pontificia, mettendosi al sicuro (5). Qualche giorno dopo (17 giugno 1792), i monaci della «Chiesa Madonna della Candelecchia, sita nel tenimento di Trasacco», furono malmenati e derubati da un gruppo di malviventi «che portavano li cappelli alla Foggiana con vesti corti, e calzoni anche di panno color turchino». Uno dei banditi (Salvatore Bucci), venne catturato durante rastrellamenti nella zona e accusato di aver guidato la comitiva armata nel territorio marsicano. Tradotto a Luco dei Marsi, fu interrogato davanti al giudice Gennaro Marino, condannato e poi giustiziato (6).
NOTE
- Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie dell’avvocato Giuseppe Maria Galanti, Tomo Terzo, Napoli M.DCC.LXXXIX, p. VII.
- M.C.Napoli, Giuseppe Maria Galanti. Letterato ed editore nel secolo dei lumi, Franco Angeli, Milano 2012, p.8.
- A.M.Rao, L’amaro delle feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del ‘700, Guida Editore, Napoli 1984, p.12.
- M.Schipa, Il regno di Napoli in una descrizione veneziana del 1730, in «Archivio Storico Per le Province Napoletane», n.s., Anno VII, Vol.XLVI, p.398.
- Archivio di Stato di L’Aquila, Fondo del Preside, Affari Generali, Iª Serie, cat.27, b.21, fasc.486.
- Ivi, b.27, fasc.595.