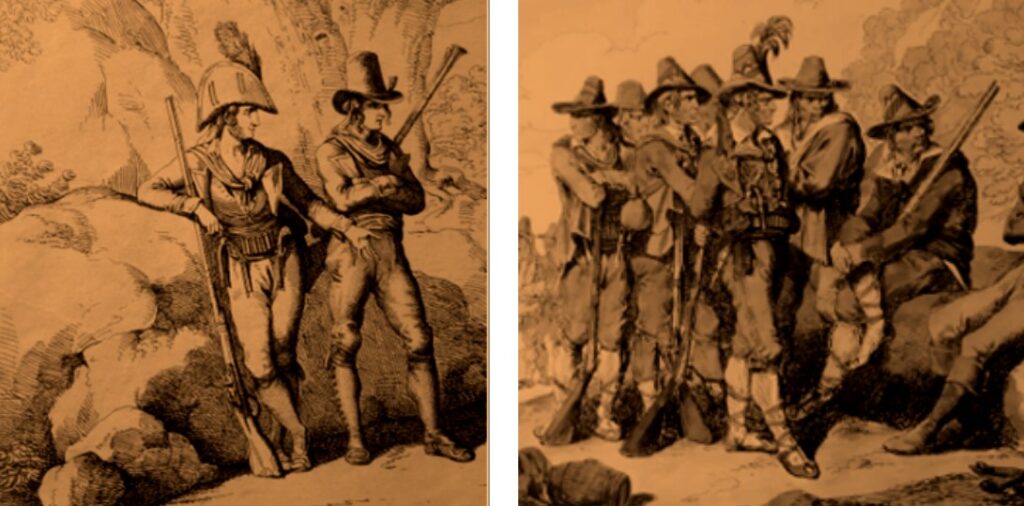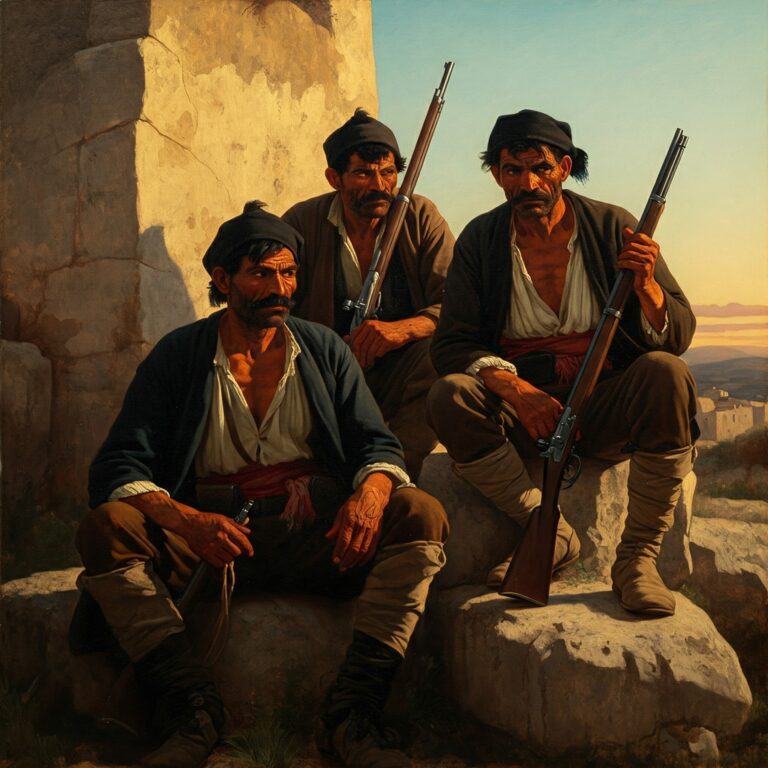“Molta parte dell’anima nostra è in dialetto” (Benedetto Croce)
Il 21 febbraio la giornata internazionale della lingua madre, proclamata dall’ONU e dall’UNESCO nel 1999, insieme all’obiettivo per lo sviluppo sostenibile sull’istruzione dell’Agenda 2030, rivaluta e protegge le lingue madri soprattutto nei primi anni di scuola.
Non solo per rispondere ad un dettame costituzionale, che tutela le lingue minoritarie, ma per consentire la promozione della cultura della parola questa giornata vuole offrire l’opportunità di dare spazio all’ascolto e alla riflessione. La pluralità delle voci consente un dialogo in continua evoluzione alla ricerca delle proprie radici dando forma al caos dell’anima. Nella poesia “Cosa significa”, scritta nella città francese di Montgeran nel 1960, Czeslaw Milosz mostra come l’uomo spesso non ha consapevolezza delle proprie origini :” Non sa di brillare/ Non sa di volare/ Non sa di essere questo e non quello”. Non è pertanto capace di interrogarsi per riscoprire, come sosteneva Petrarca, la memoria dei luoghi non solo fisici ma affettivi e spirituali che ci hanno generato. Trattenere i sentimenti che hanno popolato la nostra infanzia in una foscoliana corrispondenza di amorosi sensi significa conservare lo stupore dei poeti affascinati dal mistero per ricercare il senso ontologico dell’esserci.
Mai come oggi immersi in un mondo mediatico invaso da una comunicazione finalizzata all’individualismo narcisistico, all’edonismo e alle leggi economiche dei mercati è necessario fare poesia.
Scrivere nei vari idiomi per fare poesia significa avere fiducia nel progresso civile come integrazione ed accoglienza solidale, significa aprire una porta al futuro delle nuove generazioni. Tutti gli scrittori originano la loro ispirazione dai luoghi nativi per farne paesi dell’anima. Dal particolare all’universale per rivendicare in tutti e in ognuno quella scintilla divina che si chiama dignità. La parola può cogliere l’essenza che vive al di là della parola stessa per farsi sacra verso tutto quello che non ci è dato comprendere. Solo l’identità linguistica, oggettuale, affettiva e comunitaria ci permette di sopravvivere al mondo. Soprattutto la poesia non è solo un’espressione estetica conforme alle regole della retorica, ma è un atto di resistenza contro l’oblio della nostra umanità.
La poesia è andata in guerra non per cantare il dolore ma per riporre l’essenza dell’esperienza umana nella speranza di un futuro, al di là delle diversità, fraterno e solidale. La lirica che è la lingua dei sentimenti anche quando usa il codice cosiddetto colto affonda le sue motivazioni più profonde nei gerghi e nei dialetti che rappresentano il veicolo delle emozioni vere preservando l’identità dei singoli e delle vari gruppi sociali. Sono i paesaggi e gli idiomi locali a modellare le parole dei poeti con le emozioni. Come sostiene l’esistenzialismo filosofico del novecento l’essere
è definito dai suoi limiti, dalla differenza rispetto al non essere e all’altro. Non percepire la propria identità linguistica e umana radicata nel territorio in cui si nasce e si vive senza percepire la propria essenza e il proprio ruolo nel mondo è alienante. Per comprendere senza pregiudizi la differenza bisogna avere dei valori universali che pur partendo dal locale consentano di accogliere il globale incoraggiando il pensiero critico.
Nell’epoca della rete mediatica in cui internet regna sovrano, la lingua madre come la poesia colloca la parola ad un certo luogo e ad un certo tempo per fare della storia personale la storia universale . Il vernacolo proprio come la struttura linguistica e semantica dei poeti assorbe la realtà che lo circonda e ne restituisce l’anima. Contro la spersonalizzazione delle proprie radici espressive e comunicative oggi è nato una termine nuovo “Paesologia”ideato dal poeta Franco Arminio per celebrare la bellezza lirica dei nostri borghi. L’Italia, una delle nazioni che sia per motivi geografici che storici è ricca di borghi, fa dei vari dialetti voci uniche e preziose armonizzate nel coro della lingua madre. Una famiglia umana la nostra che si fa testimonianza del potere del linguaggio di far vibrare corde comuni nell’intento di costruire la civiltà dell’amore. Lasciatemi concludere con dei miei versi affinché si facciano respiro primaverile della mia terra “Vorrei parlarti/ nel natio dialetto/ che a fatica ormai ricordo/ della bellezza del cielo posato/ sulla corona frastagliata/ dei Marsi monti/ a rischiarar gli occhi/ del terso aprile”.