Per avere una piena adesione e partecipazione delle masse italiane e marsicane, il regime fascista nel 1927 ebbe bisogno di ricorrere a plateali manifestazioni propagandistiche: «basti pensare, a quest’ultimo proposito, alle molte fotografie, riprodotte con grande rilievo dalla stampa, e ai molti cinegiornali nei quali il duce era colto nell’atto di trebbiare e di raccogliere il grano o di premiare personalmente le famiglie numerose». Tutto questo avvenne mettendo in evidenza un aspetto decisivo del consenso che il fascismo riuscì a realizzare anche nel nostro territorio attorno alla figura di Mussolini, tra la fine del 1925 e la metà degli anni trenta (1).
Lo storico e filosofo tedesco Ernst Nolte coglie piuttosto i caratteri generali di questo «mito», riferiti al particolare momento di crisi economica attraversato dal regime, affermando in proposito: «Il fascismo non vuole dire soltanto manganello e olio di ricino: dopo la sua vittoria esso è anche entusiasmo di costruzione, è una passione di mettersi al lavoro, in cui trovano posto molte delle migliori forze dinamiche dei giovani» (2).
Nei primi giorni dell’ottobre 1927, Paolo Ciocci (podestà di Luco dei Marsi), con una istanza rivolta a Mussolini salì subito alla ribalta delle cronache marsicane. In realtà, il rappresentante del municipio: «al quale non sfugge uno solo dei bisogni sentiti da questa forte e laboriosa popolazione, con quella passione onde è sempre animato per l’istituzione di nuove opere rivolte al pubblico bene, si è da tempo vivamente interessato presso le autorità scolastiche e quelle della Provincia, perché venga istituita nel Fucino, e precisamente nella zona che a noi appartiene, perché limitrofa alle nostre terre, una Scuola dell’Ente allo scopo di venire in aiuto a quelle numerose famiglie, alle quali, data la lontananza della zona da esse abitate, non riesce agevole, specie nella stagione invernale, mandare i loro figli a scuola». La proposta, che confermava il volere del duce di far frequentare la scuola a tutti, rappresentò un’iniziativa davvero importante.
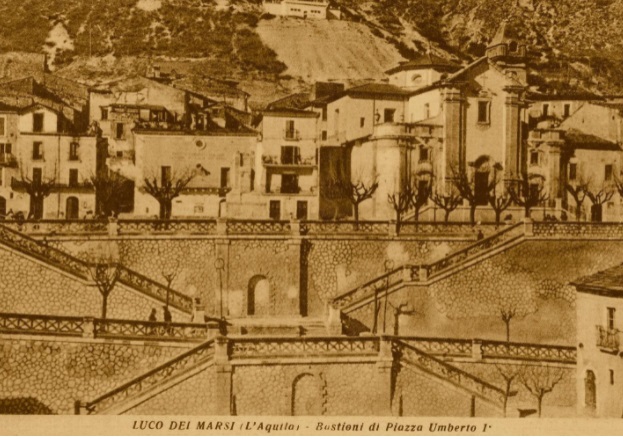
Per il podestà, era assolutamente necessaria una scuola, proprio perché: «il colono di queste terre, non è il cafone dell’antica tradizionale leggenda abruzzese (ravvolte l’anche come i fauni antichi) di carducciana memoria [Odi Barbare], proveniente dalla vecchia e rude stirpe di Aligi che, alla madre terra apporta tutta l’immane fatica delle sue braccia per diromperne il seno e prepararlo al rigoglio della nuova seminagione, usando solamente la forza fisica e bruta con l’aiuto di pochi e antichi strumenti da lavoro; ma è l’agricoltore vero e proprio che, alla coltivazione del terreno si dedica con intelletto ed amore; con rito veramente sacerdotale, facendo uso, per la bisogna, di tutte le risorse che gli possano provenire dallo strumento nuovo del lavoro, dalle macchine e dagli attrezzi rurali in genere, che la nostra meccanica, ideata dal genio italico, lavorando in silenziosa operosità nelle nostre industri officine, sa produrre di giorno in giorno sempre più semplici e perfette, per agevolare la dura fatica del nostro contadino e renderla mille volte più produttiva». In tale scenario, a detta del podestà, il progetto di istituire una scuola nell’agro fucense popolato da numerose famiglie coloniche, era indispensabile. Alla fine del lungo articolo, il corrispondente del giornale aggiunse alcune conclusioni, sfoggiando la sua cultura liceale: citò la dea romana delle messi, identificata con quella greca Demetra, paragonando le terre emerse dal lago Fucino in: «un lembo di paradiso terrestre per la bellezza di sistemazione di strade e di meravigliose piantagioni sovra interminabili zone feconde, dove la Dea Cerere prodiga profusamente, a piene mani, i tesori della sua grande abbondanza e della sua opulenta ricchezza [sic!]» (3).
Nello stesso periodo, l’urgenza e la gravità di altri problemi zonali, spostò l’attenzione dell’opinione pubblica nella «Piana del Cavaliere». I paesi di Oricola e Rocca di Botte chiesero ancora una volta di staccarsi dall’Abruzzo aquilano, per essere annesse alla provincia di Roma, aggregandosi alla pretura di Arsoli. Riemerse così un annoso problema risalente al 1907 e mai risolto. Però, a dispetto di queste vicissitudini, rimaneva il fatto che staccandosi ben due comuni dal mandamento di Carsoli, la pretura sarebbe stata abolita. Di questa disputa assai complessa si occupò con un articolo polemico Alfredo Arcangeli che, risalendo alle richieste esternate dai municipi secessionisti già dall’11 novembre 1926, riaffermò con forza i desideri unitari di Mussolini: «Colui che tanto sapientemente guida la Nazione ad una maggiore grandezza e ad un maggiore benessere» (4).

La manifestazione fascista ad Avezzano davanti al monumento dei caduti
Non va peraltro sottovalutata la grande mobilitazione delle masse marsicane accorse ad Avezzano per la commemorazione «della Vittoria e della Marcia su Roma». Infatti, la mattina del 3 novembre 1927: «da ogni finestra, da ogni balcone sventolava il tricolore e dai paesi vicini cominciavano ad affluire militi e camice nere». La cronaca riporta che: « Il Console e Segretario politico cav. Rino Mancini, con quella genialità che è frutto d’una vita vissuta nel giornalismo e nelle ansie della passione fascista, ebbe la splendida idea di abbinare alla celebrazione della Vittoria quella della Marcia su Roma». Già molti manifesti inneggianti al re, al duce e all’Italia, tappezzavano la città da alcuni giorni, firmati dal podestà, dai presidenti degli ex combattenti e dei mutilati, dal segretario politico e dal presidente dell’associazione commercianti. Alle nove e trenta l’area di Piazza Risorgimento «era assiepata di Autorità, di militi e di camice nere, nonché dagli alunni e dalle alunne delle scuole». Da un altare adornato da bandiere tricolori il vescovo Bagnoli officiò la messa, con partecipazione devota di numerosi presenti. Dopo brevi parole del monsignore: «parlò il Podestà comm. Cambise, molto applaudito. Seguì il Console cav. Mancini nel discorso del quale si sentiva vibrare l’anima fascista di vibrazioni che si ripercuotevano nel cuore dei presenti i quali accolsero la chiusa del discorso con entusiastici applausi. Dopo la rivista della 132ª Legione della Milizia passata dal Console e dal Seniore cav. Ferri, le Sezioni degli ex Combattenti e dei Mutilati, coi rispettivi Presidenti cav. Iatosti Umberto e cav. Avv. D’Amico Guido, la locale Sezione Fascista, le Associazioni Sindacali, le scuole precedute dai concerti della Milizia e dal Dopolavoro ferroviario, formarono un numeroso corteo, che si recò a deporre una corona di quercia sulla lapide dei Caduti, murata nell’atrio della Stazione ferroviaria». Scioltosi il corteo, tutte le autorità furono invitate dal podestà di Avezzano al municipio, dove fu offerto loro un rinfresco tra gli «Alalà» rivolti al re, al duce e all’Italia. Nel pomeriggio, nella sede del comando della milizia, giurarono fedeltà al regime venti nuovi ufficiali, in onore dei quali «la sera, ci fu una riuscitissima festa da ballo al Circolo del Littorio. Gli onori di casa furono con molta signorilità disimpegnati dal Presidente del Circolo e dal Console coadiuvato dalla sua signora Donna Ida Mancini, che ebbe premure squisite per tutte le signore e signorine intervenute» (5).
Il diciassette novembre dello stesso anno, l’ufficio stampa del fascio femminile avezzanese, comunicò che alle ore quindici era stato convocato dalla segretaria Giovanna Merolli il direttorio, per annunciare a tutti la nascita dello stesso. Ed appunto, durante questa prima riunione in assemblea generale, furono assegnate cariche alle rappresentanti: Amelia Petrella (vice segretaria); Margherita Libori (tesoriera); Rosa Salmeri (delegata per la propaganda e cultura); Francesca Camathias (delegata per la difesa dei prodotti italiani); dottoressa Caroselli (delegata per la sanità); Jole Pennazza (delegata per le giovani italiane); Margherita Nardelli (delegata per le piccole italiane); Angela Mancini (delegata per il dopolavoro femminile). Seguì un lungo e retorico discorso pronunciato dalla segretaria del fascio femminile Giovanna Merolli, che richiamò l’attenzione delle intervenute sulla solidarietà nazionale e sulla genialità di Mussolini. Tra l’altro, affermò: «Occorre risvegliare in questo nostro popolo l’anima intera e diretta, volta con incrollabile fermezza alle opere grandi e buone. A questo compito di complessa unificazione ed educazione del Popolo Italiano, anche noi siamo chiamate a cooperare. È la prima volta che in Italia le donne sono ufficialmente assunte ad una funzione sociale di tanta importanza. Possiamo essere liete ed orgogliose». Infine, furono inviati telegrammi di fedeltà a Mussolini «possente rinnovatore dell’Anima Nazionale»; a Turati e alla delegata provinciale dei fasci femminili di L’Aquila, consapevoli «dell’alta Missione che la Rivoluzione fascista affida alle donne italiane» (6).
NOTE
- R.De Felice, Mussolini il fascista, II. L’organizzazione dello Stato fascista 1925-1929, Giulio Einaudi editore, Torino 2019, p.379.
- E.Nolte, I tre volti del fascismo, Milano 1966, pp.376 sgg. Occorre precisare che negli anni a divenire, l’intellettuale tedesco fu criticato per il suo revisionismo storiografico da molti storici italiani. Per tutta la questione si veda: Pier Paolo Poggio, La ricezione di Nolte in Italia, in «Storia e Memoria», vol.1, 1998, pp.535-553.
- Il Risorgimento d’Abruzzo e Molise, Anno IX – Num.740 – Roma, 6 Ottobre 1927, Corriere di Luco ne’ Marsi. Proposta di una istituenda scuola nell’Agro Fucense, p. 2.
- Ivi, Anno IX – Num.745 – Roma, 23 ottobre 1927. Per tutti i particolari della complessa vicenda, si veda: F.D’Amore, Equi e non Marsi! Il tentativo di Carsoli, Oricola e Rocca di Botte per staccarsi dall’Abruzzo aquilano, in «Il foglio di Lumen». Miscellanea 19, dicembre 2007, p.2; Id., Il distacco delle frazioni di Oricola e Rocca di Botte dal comune di Pereto, in «Il foglio di Lumen», Miscellanea 25, dicembre 2009, p.7.
- Ivi, Anno IX – Num.749 – Roma, 13 Novembre 1927, Corriere di Avezzano. Commemorazione della Vittoria e della Marcia su Roma, p.2.
- Ivi, Anno IX – Num.753 – Roma, 27-30 Novembre 1927, Corriere di Avezzano. Costituzione del Fascio femminile.







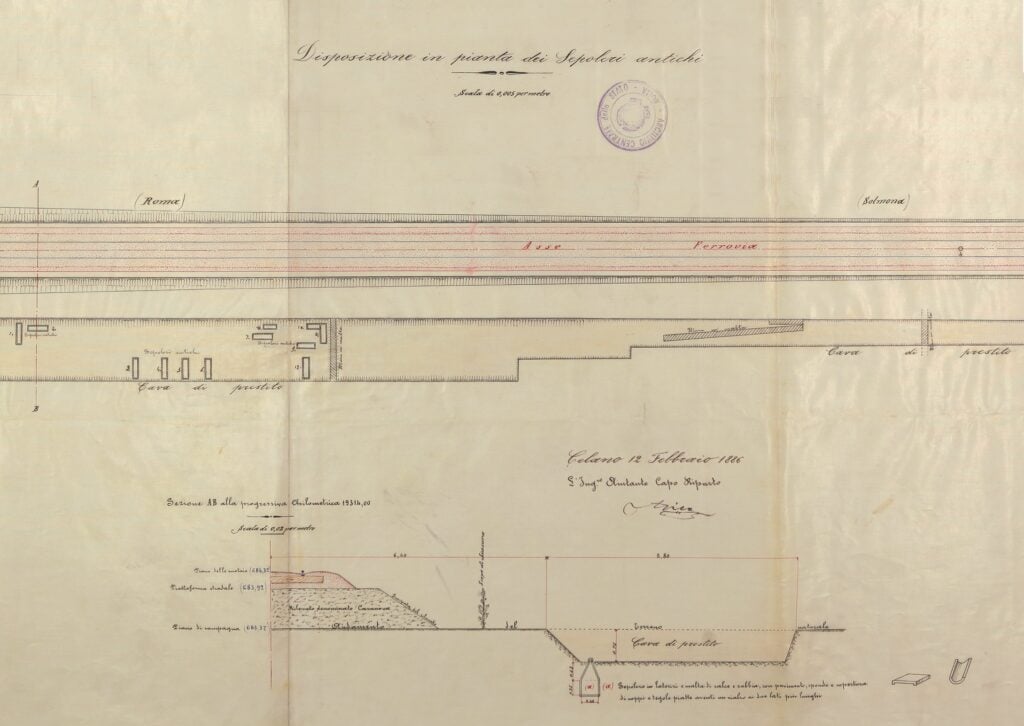












![Picsart_25-04-04_12-37-04-761 {"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](https://www.terremarsicane.it/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Picsart_25-04-04_12-37-04-761-scaled-r3v0yy2vap421d3m0neguc2hy4k9rfia3jd8vdaclc.jpg)






















