Avezzano – Dal 1° Settembre prossimo, Stefano Lustri, marsicano “ impenitente”, interprete originale di alcune ricerche artistiche a cavallo tra l’inizio degli anni ‘ 70 e l’inizio degli anni ‘ 90, cesserà la sua attività d’insegnamento portata avanti da decenni nelle aule del Liceo Artistico “ V. Bellisario” di Avezzano.
La pubblicazione di alcune sue riflessioni, come risposta a precise domande a lui rivolte, rappresenta un doveroso omaggio ad una persona presente nell’osservare e metabolizzare sia questioni che attengono al mondo della scuola, in particolare a quello della formazione artistica, sia problematiche più generali che hanno in qualche modo ispirato da sempre certe sue personali traiettorie di ricerca.
Si è deciso d’impostare la conversazione sollecitando su taluni aspetti il prof. Lustri, ma anche l’uomo-artista Lustri.
M. C.
“Stefano, tu sei stato uno dei primi alunni della scuola d’arte “ V. Bellisario”, istituita nell’ormai lontano 1968. Hai frequentato quindi per cinquant’anni, come studente, poi come docente e contemporaneamente come artista quegli spazi: ora, mezzo secolo, in un mondo in cui tutto cambia a velocità supersonica, lo potremmo considerare come una sorta di era geologica. Per quanto possibile, riesci a sintetizzare come , secondo te, siano cambiate le scuole d’arte e le ragioni che ne costituiscono l’essenza principale?”
S.L.
Dall’ 800 fino agli anni ’50 del ‘ 900, la scuola d’arte rappresentava il luogo in cui si conservava e si incentivava l’eredità del patrimonio artigianale- artistico e/o di produzione soprattutto nella tradizione delle risorse e vocazioni del territorio. Così operavano scuole ispirate ad attività manuali, locali, quali la lavorazione del legno, del ferro, del rame, dell’oro, della pietra, della ceramica, del corallo della tessitura ecc.
Con gli anni ’60, ancora con il diploma triennale di Maestro d’Arte, queste scuole risentono pesantemente l’influsso dell’industria. Si ha l’esigenza di preparare operatori al nuovo mondo della produzione artigianale e del design; per oggetti da ottenere a minor costo, per una diffusione di massa. Nel 1970 viene istituita la prima classe del biennio di sperimentazione con il diploma di cinque anni; gli studenti avranno facoltà di accesso a tutti i corsi universitari. Altra anima dell’istruzione artistica era il liceo artistico, con il corso di studi di quattro anni e l’anno integrativo per l’accesso all’università. Nel 2011 le due anime del vecchio liceo artistico e dell’istituto d’arte si fondono per dare vita al liceo d’arte , caratterizzato da diversi corsi di studio quali il design dell’arredamento, quello dei metalli e dell’oreficeria, le arti figurative, l’inserimento della lingua straniera , questi nuovi percorsi di studio hanno il fine di formare studenti con un titolo spendibile nell’ambito di un mondo globalizzato.
Il diplomato del futuro delle scuole d’arte potrà programmare con un computer, progettare e/o far realizzare la sua creatività, come un nomade, da qualsiasi parte del mondo.
M.C.
Mi pare di aver capito, quindi, che tu indichi nel tempo due momenti cruciali in cui si verificano cambiamenti strutturali: il passaggio dalla produzione artigianale a quella industriale, con nuove esigenze formative , e quello determinato dalla riforma del 2011, cioè la “liceizzazione” degli istituti d’arte. Tu, su quest’ultimo orientamento deciso a livello centrale, che opinione hai?
S.L.
Forse era meglio mantenere un biennio unico di formazione generale per poi poter scegliere dei percorsi professionalizzanti o in alternativa un curriculo che consentisse la prosecuzione degli studi a livello universitario .Questo per coniugare sia l’esigenza di sviluppare una preparazione più trasversale e meno monomaterica, sia quella di salvaguardare il grande patrimonio professionale costruito negli anni dagli istituti d’arte.
M.C.
Non trovi paradossale che in un Paese come l’Italia, detentore del più vasto patrimonio d’arte al mondo, certe scuole siano sempre state ritenute realtà educative e formative di secondo ordine? Pensi che questa vulgata sia il frutto di un modo di rappresentarsi delle istituzioni d’arte come poli eccentrici e forse un po’ anarchici, oppure, come io credo, la concezione gentiliana, quella che su assunti antistorici ha diviso le scuole per studiare da quelle dove si fa” altro”, ha un peso specifico determinante in questo senso?
S.L.
Io credo che questa visione piuttosto riduttiva delle realtà formative ad indirizzo artistico sia dovuta ad entrambi i fattori cui tu fai riferimento: la riforma Gentile, che faceva dell’elitarismo la ratio principale, considerava queste scuole come luoghi in cui “addestrare al lavoro ed alla produzione artistica”, quindi luoghi in cui acquisire specifiche competenze che, però, non evocavano il concetto di manualità colta o di metodologie progettuali, ma rispondevano ad esigenze socio-economiche molto concrete, finalizzate a formare artigiani e tecnici specializzati. In questo senso il solco che si è voluto marcare tra queste scuole e quelle delegate alla formazione delle classi dirigenti ha avuto un ruolo importante, anche se bisogna riconoscere che fino agli anni ‘ 60 il diploma di Maestro d’Arte rappresentava comunque un titolo concreto. Poi però, con l’avvento della cosiddetta arte concettuale e quindi l’inizio di nuove sperimentazioni, sono saltate alcune propedeuticità: molto spesso, quella umana inclinazione al fantastico che sta alla base di qualunque meditazione e ricerca artistica, si è intrecciata con un’inclinazione al fantasmagorico. E questo ha contribuito a rendere tali istituzioni come una sorta di “ luoghi sospesi” agli occhi di una cultura dominante.
M.C.
Ma l’arte , secondo te, si può insegnare? O meglio, si può insegnare a diventare artisti?
S.L.
Non credo che un liceo artistico debba prioritariamente generare degli artisti, semmai quell’inclinazione al fantastico cui accennavo può essere educata e formata per costruire gli strumenti concettuali e metodologici che consentano di affrontare la complessità di un atto creativo. Questo una scuola d’arte lo deve e lo può fare, poi ognuno potrà decidere se iniziare una personale traiettoria di ricerca in campi d’azione che, oggi come oggi, sono molto più ampi, proprio perché l’effervescenza della civiltà delle immagini sta imponendo figure professionali nuove o più flessibili che siano il risultato di una formazione meno monomaterica e più trasversale. Comunque insegnare una grammatica visiva con cui osservare tutto ciò che ci circonda e soprattutto acquisire una consapevolezza su come fare , cosa fare ma anche su perché fare , credo sia un obiettivo possibile. A mio parere un artista o designer, per scegliere cosa fare e oltre, può solo scegliere su quanto imparato in precedenza. Se si saprà fare appena, la scelta non potrà che essere la conseguenza. Certi percorsi formativi danno al discente la possibilità di ampliare la conoscenza su come si fa prima di cosa si potrebbe fare; così come accade nello sviluppo della conoscenza in tutte le attività umane.
Non si può inventare un manufatto grafico-pittorico, plastico, di design ecc, ignorando i metodi e le scelte che hanno portato al risultato. Il diplomato di una scuola d’arte potenzialmente è un cultore d’arte; sia esso un futuro pittore, scultore, designer, collezionista, critico d’arte, allestitore di mostre ecc., tutto ciò che farà in seguito lo farà con metodo, talento, onestà intellettuale.
Poi, sai, chi si illude d’ insegnare a diventare artisti, corre il rischio concreto di generare dei cloni. E questo sarebbe l’errore più grossolano.
M.C.
Nelle scuole dove appunto si dovrebbero acquisire delle “manualità colte”, in che modo le nuove tecnologie possono interagire? Ad esempio, nelle Discipline Plastiche, materia che tu insegni da sempre, l’avvento delle stampanti 3D diventa un problema oppure costituisce un’enorme opportunità?
S.L.
Può rappresentare un’enorme opportunità a patto che non si perdano di vista alcune questioni che regolano il rapporto tra il sapere ed il saper fare, tra il fondamentale nesso che esiste tra mano e cervello.
M.C.
Parliamo del nostro territorio e del Liceo Bellisario che in esso opera. Mi è sempre rimasta impressa una tua proposta, quella di collegare in qualche modo l’attività didattica con la rinascita del Premio d’Arte Città di Avezzano che ,negli anni ’60, aveva raggiunto un prestigio internazionale di assoluto rilievo. Ci puoi spiegare meglio come bisognerebbe interpretare il rapporto tra un’istituzione scolastica a carattere artistico ed il proprio luogo di appartenenza?
S.L.
Intanto credo ci sia l’assoluta necessità, così come per una comunità urbana anche per una scuola d’arte, di allestire con l’aiuto di una o più persone competenti, un archivio storico per mantenere e restituire parte dell’identità e della cultura di un territorio, quindi non perdere il filo conduttore della creatività tra le generazioni che si susseguono. Riguardo gli eventuali agganci con un’auspicabile rinascita del Premio Città di Avezzano, penso che il Liceo Bellisario possa rappresentare un presidio affianco alla rassegna, un luogo di coordinamento per la crescita didattica e culturale degli studenti del territorio, avvicinandoli alle problematiche dell’arte contemporanea.
Comunque, in generale , il rapporto tra una scuola d’arte ed il proprio territorio d’appartenenza dovrebbe incentrarsi su una partecipazione attiva dell’istituzione come soggetto che propone continue collaborazioni con realtà locali che siano punti d’eccellenza sotto vari aspetti e con queste concordare , all’interno della propria didattica, laboratori di sperimentazione grazie ai quali acquisire tecniche, procedimenti, vivere esperienze di progetto, attuare proposte culturali.
M.C.
A proposito del Premio Città di Avezzano, il prof. Tempesti, attento conoscitore di questa rassegna, nel ripercorrerne la storia, si domanda se dopo diciotto anni di stop, riprenderà il suo cammino. Tu pensi che ci siano le condizioni culturali per far rivivere il Premio e le personalità giuste come eredi di coloro che alla metà degli anni ’60 portarono la rassegna ad una ribalta internazionale?
S.L.
Sì, se si va a costituire una vera e propria fondazione, nella quale confluirebbe l’interesse per il Premio e per le opere costituenti la pinacoteca comunale. Del resto una fondazione diretta da persone scientificamente preparate non può che essere una garanzia.
M.C.
Stefano, tu hai più volte sollecitato , attraverso giornali a diffusione locale, le istituzioni, gli enti preposti e gli operatori culturali, a riportare al centro del dibattito il recupero della memoria, della conoscenza di ciò che era Avezzano: hai sempre proposto la fondazione di un Museo della Memoria, operazione che ritieni cruciale per pensare come proiettare la città nel futuro. Ora, perdonami la provocazione, ma io credo che l’attuale impianto urbano previsto da Piano Bultrini ( 1916) sia molto più interessante di ciò che era Avezzano prima del terremoto e che ancora oggi gli spazi ed il tessuto edilizio realizzati all’interno del cosiddetto “quadrilatero”, siano gli unici che riescano a dare l’idea di una città, seppure piccola ma pur sempre città. Tu che ne pensi nel merito? E non credi che questa legittima e continua ricerca di una radice storica, abbia portato in qualche modo a sottovalutare la portata del Piano Bultrini, pensato ormai più di cento anni fa e che invece esso poteva essere un riferimento importante per evitare tutti i “ non luoghi” che caratterizzano drammaticamente le periferie di Avezzano?
S.L.
La Avezzano prima del terremoto del 1915 era quella che ci aveva lasciato la storia, una stratificazione urbana che durava da cinquecento anni, con poco più di diecimila abitanti. Il Piano Bultrini ha dato un nuovo assetto razionale alla città; definita “città giardino”, definita in orizzontale più che in verticale. Successivamente un certo numero di costruzioni sono andate distrutte nei bombardamenti del ’44. Tuttavia la città è aumentata nel numero degli abitanti e dagli anni ’60 si è creata, quasi a contrasto, una concentrazione urbana a Nord rispetto a quella del ’16. Nuove tecniche di costruzione, verticale, nuove opere pubbliche ed una certa smania di espansione in risposta ad una crescita demografica che ha sforato i 40.000 residenti. Tutto ciò ha destabilizzato l’armonia di quella parte di città disegnata e realizzata secondo le intenzioni di Bultrini. Rimane un dato di fatto e cioè che comunque Avezzano oggi è troppo estesa rispetto al numero di abitanti.
M.C.
Hai seguito le ultimissime vicende sulla realizzazione della pista ciclabile, il ripensamento della fontana di Piazza Risorgimento e dello spazio adiacente? Non credi che ci sia in generale da parte della cittadinanza una pregiudiziale avversione a modificare l’esistente? A pensare che uno spazio urbano, per anni vissuto secondo certe dinamiche relazionali, possa essere fruito anche in maniera diversa?
S.L.
Quando si cambia qualcosa si può sempre andare incontro al pregiudizio, ma se l’idea è lungimirante il tempo non può che dare ragione. Si sta andando inevitabilmente verso un’urgente, rinnovata coscienza ecologica. L’invito ad andare più in bicicletta che con l’auto è sicuramente una direzione da perseguire. In quanto al ripensamento della fontana di Piazza Risorgimento, così come la decorazione gotico-romanica che avrebbe dovuto completare la cattedrale, sarebbe stato interessante chiederlo a Bultrini. Bisogna tener presente che quel nodo urbano, dopo il progetto iniziale, ha sempre attratto l’attenzione di chi la vede come luogo da completare o luogo d’accoglienza di manufatti commemorativi o decorativi. Ad esempio nel ’39, lì venne collocato il monumento ai caduti di Ermenegildo Luppi, poi spostato in Piazza Torlonia. Mentre nel ’54 si stava considerando il completamento della fontana con una scultura di Assen Peikov, la cui immagine conteneva una serie di elementi simbolici che secondo l’autore caratterizzavano il contesto marsicano. A me viene da interrogarmi solo su un dato di fatto: ma di che tipo di conservazione ha fruito il progetto di quella piazza? La valorizzazione dell’area pedonale intorno, da sempre luogo d’incontro dei cittadini e dei forestieri, è senza dubbio un valore aggiunto per la socializzazione.
M.C.
Sembra quasi che chiedere di ritrovare l’identità perduta di una realtà urbana, come quella avezzanese, costituisca in fondo il filo conduttore nelle tue espressioni artistiche e quindi un preciso obiettivo da perseguire anche nel campo dell’arte: quando scrivi “ per me un dipinto significa la possibilità di avanzare di un centimetro dal più profondo del labirinto in cui ci siamo calati”, esprimi tutto il tuo disagio ed il tuo disorientamento di fronte a quelle che tu definisci “macerie prodotte dal concettualismo ideologico”. Spiegaci meglio.
S.L.
Io credo che “il labirinto” dei fermenti artistici che hanno contribuito a quel periodo sia ancora da affrontare. “Il ponte” che ha portato l’arte, dagli anni ’60 agli anni ’80, non mi sembra sia stato spiegato del tutto e con quali materiali è stato costruito; mi riferisco a quegli artisti che, negli anni ’70, non avendo percorso la strada della “ricerca che conta”, ma quella di una ricerca spontanea, agli inizi degli anni ’80 sono stati repentinamente messi in secondo piano, in Italia come nel successivo dibattito internazionale. Nel 1986, con il critico Dario Micacchi, avvertendo l’emergenza, si volle porre all’attenzione di una più vasta opinione pubblica la questione, organizzando una rassegna dal titolo-“La memoria, il presente, l’utopia”-, che comprendeva la presenza di 24 pittori italiani di diverse generazioni ed esperienze, come nucleo avanzato di una ricerca assai più vasta. In mostra c’erano opere di: Boschi, Calabria, Carmassi, Ciai, De Micheli, Fidolini, Fieschi, Guccioni, Guerreschi, Lustri, Maselli, Mulas, Notari, Possenti, Sarri, Sughi, Titonel, Tommasi Ferroni, Turchiaro, Vacchi, Vespignani, Vitagliano, Viiani, Volo. A testimoniare la presenza di artisti figurativi che non hanno avuto bisogno del recente, tanto enfatizzato ritorno alla pittura per legittimare la loro ricerca. Il mercato dell’arte, nel suo corso naturale, ha poi amplificato il divario tra quello che conta ( su cui investire) e tutto il resto.
M.C.
Qualche anno fa eri stato selezionato per essere inserito in un volume dell’Enciclopedia dell’Arte Italiana del ‘900: ciò fatalmente non è avvenuto ma un’eventuale etichettatura artistica, ad una lettura forse superficiale, porterebbe a definirti come un ‘’ nuovo figurativo’’. Però alcune tue declinazioni di ricerca, come quelle che titoli’’ l’aniconico latente’’, sembrano quasi indicare che in fondo il tuo spazio d’azione sta nell’intersezione che vorrebbe collegare le cosiddette neoavanguardie con un’arte figurativa rifondata. E’ così?
S.L.
Infatti per me non rappresenta un pregiudiziale ripudio
ad ogni forma d’astrazione, essa è il risultato di un’operazione inconscia di un puzzle di particolari che , se osservati, evocano forme non sempre codificabili nel reale.
Ora prelevare un dettaglio è come fotografare uno sguardo per vedere altrove. In alcune mie opere, come quelle cui tu ti riferisci di “l’aniconico latente”, dei frammenti smontati ed osservati da altri punti di vista generano la scomparsa di un’immagine riconoscibile ed il possibile manifestarsi di altro. Ecco perché nella mia pittura la fotografia ha un ruolo importante, in quanto ritengo che in essa, “all’interno”, ci sia un mondo sconosciuto, che può essere svelato solo se l’intelletto accetta di collaborare con l’obiettivo fotografico. Gli iperrealisti sfidano la fotografia ed i neorealisti, a volte, la nascondono per il timore di non essere compresi. Io non realizzo un dipinto per ottenere una fotografia, ma scatto una fotografia per realizzare un dipinto, per ritrovare un altro racconto, immaginando, dalle foto in bianco e nero, quello che era il colore. Prima di scattare un fotogramma di scena del racconto, c’è sempre la preparazione di un set teatrale, a volte con la costruzione di oggetti. Come un “work in progress”, termine citato nella presentazione del catalogo di una mia mostra del 1977 dal critico Mario Lunetta.
Piuttosto io pongo un interrogativo di fondo: se è vero che la pittura analitica, intesa come alternativa all’arte concettuale, testimonia le macerie prodotte dal concettualismo ideologico dilagante sull’opera tra gli anni ’60 e ’70, chi negli stessi, recependo l’urgenza, ha condotto una pittura di ricerca?







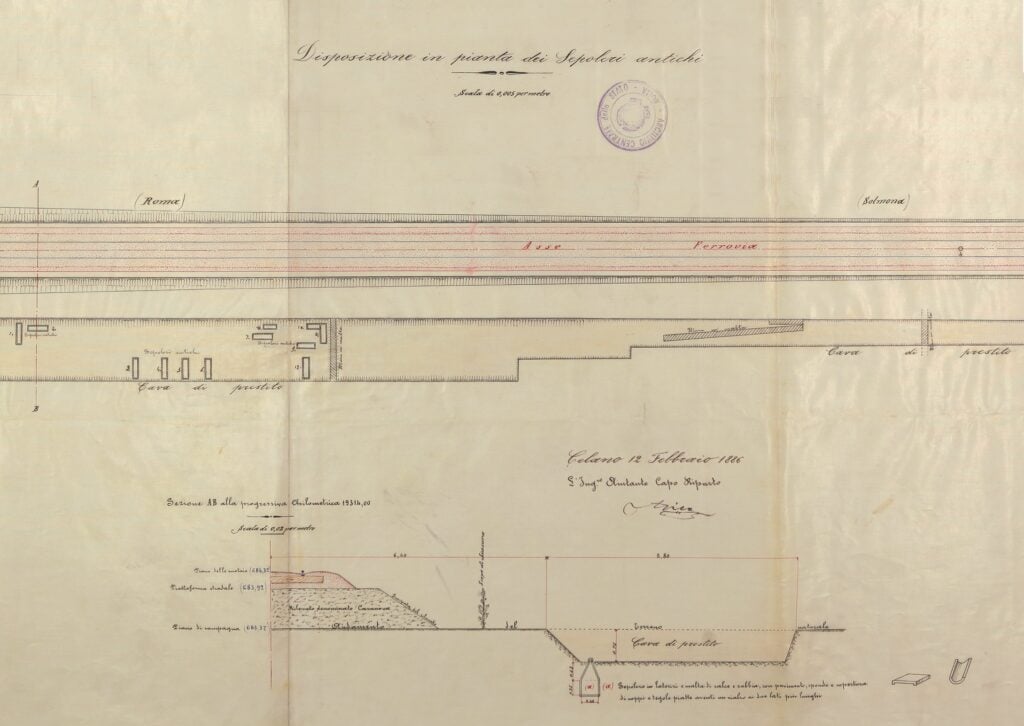
























![Picsart_25-04-04_12-37-04-761 {"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](https://www.terremarsicane.it/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Picsart_25-04-04_12-37-04-761-scaled-r3v0yy2vap421d3m0neguc2hy4k9rfia3jd8vdaclc.jpg)









