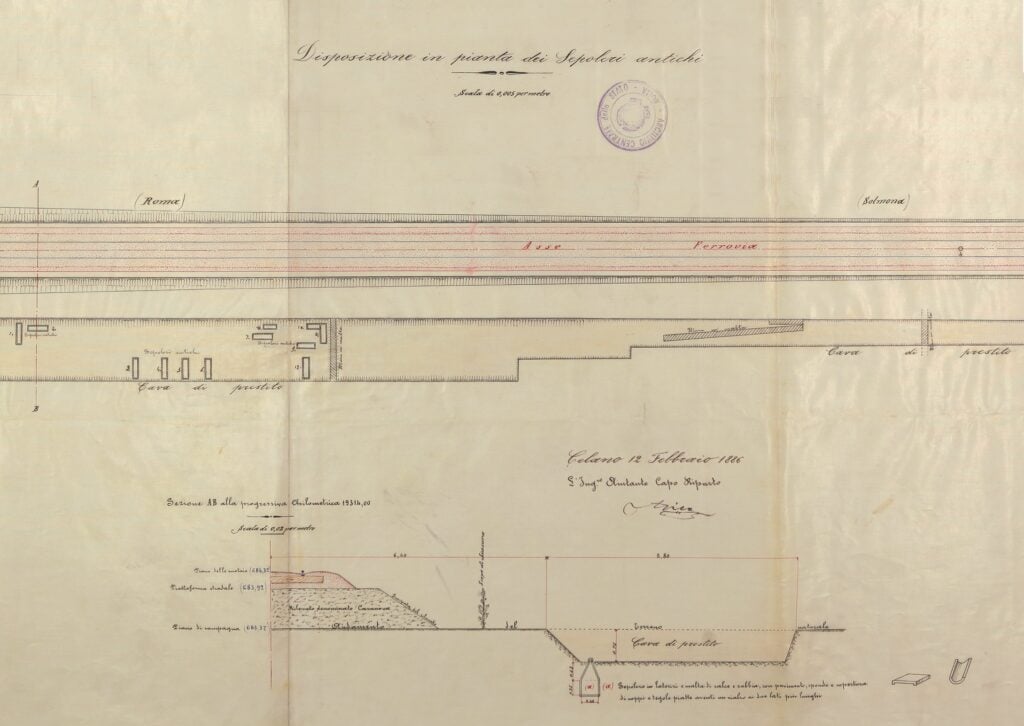Cappadocia – “Voglio andare a Cappadocia, dalla zia Costanza. Mettimi sul mulo che sa la strada ( … ) Voglio tornare là. “, lo scriveva Gabriele D’Annunzio nella sua opera “La Fiaccola sotto il moggio”. Proprio oggi, 1° marzo, ricorre l’ottantunesimo anniversario della sua morte, e in questa occasione è importante ricordare il legame che il grande autore abruzzese ha instaurato con il territorio marsicano attraverso un componimento nel quale il Vate cita Cappadocia, l’incantevole borgo marsicano con poco meno di 600 abitanti.
D’Annunzio ebbe modo di frequentare Cappadocia e di soggiornarvi durante la gioventù, per respirare un po’di aria fresca e pura che migliorasse i suoi problemi d’asma.
Gabriele D’Annunzio, poeta abruzzese emblema del Decadentismo italiano, si è reso famoso per la sua capacità di inserirsi nel contesto politico del tempo e di farsi interprete dello spirito nazionale, tant’è che nel corso della Prima guerra mondiale si fece promotore dell’impresa di Fiume, contesa tra Italia e Jugoslavia, che portò all’occupazione della città, successivamente liberata dal governo giolittiano. Ideologicamente vicino al fascismo, assieme a Filippo Tommaso Marinetti fu tra i primi firmatari del Manifesto degli intellettuali fascisti.
Tra le opere principali del Vate vi sono i romanzi “L’innocente” (1892), “Il trionfo della morte” (1894), “Le vergini delle rocce” (1895), la tragedia “La figlia di Iorio” e la raccolta poetica Alcyone (che contiene la celebre lirica “La pioggia nel pineto”).
Di seguito lo stralcio suggestivo della tragedia “La fiaccola il moggio” in cui viene menzionato Cappadocia, luogo da cui D’Annunzio rimase letteralmente incantato:
“Voglio andare a Cappadocia, dalla zia Costanza. Mettimi sul mulo che sa la strada.
Ah! Come si respira nei boschi di castagni!
Voglio ancora il mio schioppo e i miei cani pezzati.
bianchi e neri, bianchi e falbi, e quei belli occhi grandi,
e quelle orecchie molli come il velluto,
e le sorgenti fredde del Liri tra i macigni,
dove scendono e salgono le donne con le conche sul capo,
e quella stanza bianca, dove si dorme in pace tra l’armadio e il canterano
che stanno cheti senza scricchiolare e sanno di lavanda.
Voglio tornare là.
( … )Ahimé, nutrice, anche diceva (Donna Monica) quando era l’estate (non te ne ricordi”) “stasera apparecchiate sotto il platano, Ceneremo all’ aperto”,
E veniva dai monti la frescura su la tovaglia, ed era intorno ai lumi un aliare di farfalle, e noi gittavamo le mandorle novelle contro i pavoni appollaiati, .. Andiamo, Annabella”.